DIES IRAE
Il Viaggiatore prese posto sul treno poco prima delle quattordici, ora prevista per la partenza. Distrattamente scorse qualche pagina d’un quotidiano e mentre il convoglio si avviava con lentezza pachidermica notò invece la data e la festività del giorno: domenica delle Palme. Gli tornò alla mente il paese che tanti anni prima aveva lasciato in treno, un treno dal quale di fatto non era più sceso a causa del suo lavoro itinerante. Con un sorriso mesto ora si lasciava scorrere dinanzi agli occhi le immagini sbiadite di quando, al paese, vide per l’ultima volta la processione delle Palme: canti, colori, suoni, gente ansimante per il caldo e l’ardente passione. Anche adesso faceva caldo, un caldo insolito per una stagione normalmente mite. Pur stando perfettamente immobile avvertiva, sulla schiena, la formazione di minutissime goccioline di sudore che si univano in un filo e tanti fili che si univano in un unico rivoletto.
Il treno penava sulle rotaie ed ogni tanto gemeva come un bue ferito. “Ancora due giorni!” pensò sgomento il Viaggiatore, considerando che sarebbe giunto nella lontana capitale solo mercoledì mattina. Tentò allora di dormire ma il calore vigilava affinché ciò non accadesse. Verso sera, sfinito, riuscì ad aggrapparsi ad un lembo di sonno. La notte trascorse senza riposo, come fosse appesa ai fili retti da un burattinaio ubriaco. E infine, l’alba.
Il Viaggiatore si destò di soprassalto, con gli occhi sbarrati. Una coltre greve di afa già incombeva sul paesaggio e, quasi senza volerlo, il suo pensiero andò a tutti coloro che in quello stesso momento, con immane fatica, si apprestavano a rimettere in moto quel complesso di ruote dentate che è il vivere quotidiano. Il finestrino del treno gli sembrava come un grosso monitor su cui ora scorrevano senza sosta campagne, città, fiumi, villaggi che si fendevano sotto la veloce lama del treno. Quella fuggente e impunibile violazione d’intimità, dove tu vedi tutti ma nessuno vede mai te, gli provocava un’ambigua sensazione a metà tra il piacere e la nausea.
A tutto ciò pensava il Viaggiatore quando il treno, già in frenata, con un ultimo sussulto si fermò in aperta campagna, nei pressi d’un piccolo borgo. Distolto dalle proprie riflessioni, si affacciò al finestrino per scoprire la causa di quella fermata imprevista: solo un semaforo rosso, una questione di precedenza fra treni. Il villaggio giaceva esanime nella piana rovente, adagiato tra i campi come una matrona opulenta ed annoiata. In quel punto la ferrovia lambiva una piazzetta, sulla quale un modesto caffè sbirciava col suo unico occhio malinconico. Un capannello di contadini ciarlava stancamente sulle temperature insolite della stagione, mentre un tipo asciutto, anziano, ricoperto dalle vestigia d’una antica divisa da ammiraglio si avvicinava con passo incerto al gruppetto di avventori. Quando fu alla loro portata, indugiò su ciascuno con un vago sorriso beffardo, poi bofonchiò: “Questa volta ci siamo!”. Nello stesso istante il treno si mosse. Il Viaggiatore rimase perplesso, quasi stizzito, per non aver potuto assistere al finale della scena, che certamente avrebbe chiarito il perché di quel curioso siparietto. Ma già un vago senso di intorpidimento ora lo pervadeva; i pensieri aggrovigliati si slegavano, prendendo ciascuno vie diverse. Un breve sonno lo rapì.
* * *
Il treno ora procedeva veloce ma senza forzare troppo, in mezzo alla teoria di case, strade e terre. Ovunque si vedeva scemare l’animazione, mentre le prime luci imperlavano la sera. Poi più nulla, tutto di nuovo inghiottito dal gorgo della notte, tranne un vegliante: il Viaggiatore. Anche il giorno del Martedì Santo corse veloce ad abbracciare il buio, attraversando impassibile la crescente tensione che sempre più traboccava da ogni parte e a tratti sembrava sommergere perfino lo stesso treno.
Il caldo aveva ormai raggiunto punte estreme, insopportabili. Creature boccheggianti, inutilmente in cerca di ristoro, si aggiravano ovunque come ombre di dannati. Radio e televisione cominciavano ad ammettere con una certa ritrosia che sì, effettivamente c’era qualcosa di strano in quella stagione atipica, cercando di diffondere generiche notizie rassicuranti. E adesso anche la notte attendeva tutti al varco, seduta in trono, ingioiellata d’ogni possibile luce insonne, per nutrirsi di tormento. Quando ne fu sazia, discretamente scomparve ed il treno finalmente riuscì a gettare gli ormeggi nella capitale.
* * *
Il Viaggiatore, scotendosi, si sentì inguainato in una pellicola di sudore gelato. Raccolse il bagaglio e scese in fretta. La stazione era appena lambita da un raro formicolio di persone e tra una pensilina e l’altra filtrava la cipria bluastra della penombra. Confrontò il proprio orologio con quelli situati in testa ad ogni binario ma il responso fu univoco: erano con certezza le nove e trenta del mattino. Vagamente perplesso e guardingo il Viaggiatore si avviò all’uscita.
La piazza antistante la stazione centrale era estremamente ampia, degna della capitale, ma lo sguardo veniva calamitato verso l’alto. Il cielo era ingombro di nuvole nere, compatte, unite tra loro senza la minima fessura; un sottile nastro di vivida luce ne guarniva l’orlo inferiore, verso ponente. Così la città, nonostante fosse giorno inoltrato, si dibatteva in una innaturale semioscurità, mentre un vento teso e fresco – che soffiava fin dal giorno prima – spazzava via foglie secche e cartacce. L’attività della metropoli ferveva come al solito ma il rumore di fondo si percepiva più attutito, ovattato: la generale inquietudine fungeva da solvente.
Il Viaggiatore provò un senso di solitudine quale mai aveva conosciuto. In quel momento, per la prima volta, ne avvertì tutto il peso millenario. Come destandosi da un lungo sonno vedeva finalmente il faticoso, inutile arrancare delle creature umane sotto un cielo assente e, più che sgomento, sentì il cuore stretto in un’infinita pena. Guardò la scogliera scura dei palazzi e si avviò verso le sue gole, in cerca di riparo.
* * *
Mattina del Giovedì Santo. Il Viaggiatore, sprofondato nel fondo d’un povero alberguccio, si alzò stancamente dal letto ed aprì la finestra. Un sussulto di orrore lo fece retrocedere di qualche passo ed un incontenibile terrore gli impediva di riaccostarsi. Meccanicamente si guardò allo specchio, passandosi più volte la mano sui capelli grigi e sulle rughe incipienti, non riuscendo altro che a mormorare più volte il proprio nome: Velthur, Velthur, …… Poi d’improvviso si fece impassibile e si riaccostò alla finestra.
La fascia di viva luce bianca che fino alla sera prima aveva immutabilmente acceso l’orizzonte s’era fatta rosso fuoco, ed ora tutte lo scenario urbano appariva riverberato da un forte bagliore di fiamma. Velthur sentì il bisogno di uscire: il chiuso della stanza s’era fatto soffocante. Lungo le strade la gente camminava rivolgendo costantemente lo sguardo verso l’alto, con un disagio sempre più tangibile. Il popolo metropolitano, in genere tetro e spietato, stava perdendo la sua sdegnosità: erano ormai moltissimi quelli che cercavano di incrociare lo sguardo con qualcun altro, cercando una risposta o anche semplicemente il conforto della condivisione, della solidarietà.
Il vento era intanto aumentato d’intensità. Il furore di quello scenario apocalittico, da cui trasudava un senso come di contaminazione, mostrava adesso il presagio di un inesorabile dies irae.
Un giornale, occorreva un giornale. Concitatamente Velthur ne comprò uno, lo aprì e ne scorse rapidamente le pagine in cerca di notizie sugli eventi in corso: assolutamente nessuna. Di contro, aveva largo spazio un comunicato dei Sacri Palazzi con cui si rendeva noto che il Gran Vegliardo avrebbe ripreso una tradizione abbandonata ormai da secoli, guidando personalmente nel pomeriggio una solenne processione penitenziale che si sarebbe snodata per le vie della capitale per poi concludersi in una veglia di preghiera. In un commento a margine, seppur limitato a poche righe, un autorevole opinionista rilanciava sommessamente un’ipotesi circolante, ossia che una decisione così clamorosa potesse avere un qualche nesso con i mutamenti climatici in corso, ma le fonti ufficiali replicavano seccamente che l’iniziativa era esclusivamente legata all’ormai prossimo Anno della Perdonanza. In ogni caso la notizia era assai rilevante, anche perché il Gran Vegliardo non usciva da anni dai Sacri Palazzi né era più ricomparso in pubblico dopo la sua elezione, tuttavia ciò non riusciva ad attrarre la mente di Velthur. Essa vagava lontano, oltre l’emozione e lo stupore del momento, in un viaggio a ritroso che portava fino all’amniotico buio del grembo materno, oltre il quale doveva pur esserci una terraferma……..
Le ore adesso cadevano in fretta. Il cielo s’era fatto più nero e più rosso; il vento ancora più forte e gelido. I passanti erano rari, mentre balconi e finestre s’erano popolati di gente in attesa. Chi attendeva la processione, chi la pioggia, chi qualunque altro accadimento che potesse sciogliere l’enorme tensione accumulata. Era una folla molto mobile ma estremamente silenziosa quella che fioriva dalle nere occhiaie dei grandi cubi forati e a guardarla dava una certa vertigine.
Camminando e rimuginando, senza accorgersene, Velthur era giunto alla cattedrale. Dinanzi al tempio poche decine di persone sostavano infreddolite, anch’esse in silenzio. D’un tratto una leggera animazione: era l’ora. Uscendo dalla cattedrale quattro turiferari precedevano il vessillifero, un po’ incerto sotto il peso d’un immane simulacro in legno dorato, alto almeno quattro metri. Seguivano una cinquantina di accoliti e una folta schiera di dignitari, tutti col viso arrossato dal freddo e con le vesti svolazzanti. In lontananza, oscillante sopra la moltitudine di teste e confuso dai fumi d’incenso, s’intravedeva il baldacchino avvicinarsi. Ed eccolo, gravato dai solenni paramenti, glorificato dalle insegne della sua autorità spirituale: Larth, il Supremo Ecclesiarca.
Assiso sul trono gestatorio appariva ancora più maestoso. Alto, solido, capelli bianchi e lunga barba grigio ferro, occhi magnetici, Larth era un asceta dal magistero inflessibile: durante il suo ventennale e volontario esilio nei Sacri Palazzi aveva saputo ugualmente guidare con fermezza e carisma il suo indocile gregge. Dietro il baldacchino incedevano i componenti del Sacro Consesso, poi altri notabili, dignitari, esponenti delle varie organizzazioni legate ai Palazzi. I pochi presenti si accodarono mentre la testa del corteo si era già insinuata nel dedalo di strade cittadine. Velthur era turbato, magnetizzato da tanta solennità, sicché si ritrovò quasi inconsapevolmente a camminare accanto a tutti gli altri. Man mano che la processione avanzava molti uscivano dalle case e dopo due ore era diventava un fiume in piena. Una voce solitaria ruppe all’improvviso l’alto silenzio ed iniziò a salmodiare un antico inno; timidamente altre voci si unirono, poi altre ed altre ancora, finché non fu un unico possente coro.
Ormai da due giorni il sole, apparentemente, non sorgeva né tramontava, e ciò che in altri tempi sarebbe stato il cuore della notte era ora qualcosa d’indefinibile, sospeso in un vuoto pneumatico. I processionanti si ristoravano di tanto in tanto con parche vivande, senza interrompere il cammino. Ad un’ora collocabile attorno alle dieci antimeridiane del Venerdì Santo l’immenso corteo raggiunse la piazza della stazione. Moltissimi vi trovarono posto ma la gran parte dovette accontentarsi di lontane retrovie. Al centro della piazza, su un alto podio e sotto un baldacchino fiorito di fregi barocchi, il trono di Larth. Decine di migliaia di persone si stringevano l’un l’altra cercando calore e conforto, ma quella folla ondeggiante aveva ormai un solo punto di riferimento e di speranza, il Gran Vegliardo. Lui meditava, chiuso in un austero silenzio, ma avvertiva il peso che quella folla gli poneva sempre più sulle spalle. E si sentiva ancora più solo.
Lunghe ore di preghiera si susseguivano uguali. Intorno alle quindici un rombo cupo, come di terremoto, squassò la barriera di cristallo interposta tra cielo e terra. Dopo un boato più forte iniziò a piovere e fu il terrore: dal cielo cadevano fittamente grosse gocce che avevano l’apparenza e la consistenza del sangue. Spinta con forza dal vento, la pioggia flagellava i veglianti con effetti orribili sulle vesti e sulle cose, tanto da creare la perfetta sensazione di trovarsi in un enorme mattatoio. Dopo l’impatto iniziale, però, il cieco panico si stemperò, dapprima in cupa rassegnazione poi in accorata implorazione. Moltitudini di visi piangenti, diversi eppure così uguali, umilmente invocavano l’aiuto del cielo con gli occhi disfatti e la bocca piegata quasi in un sorriso riconoscente. Era forse il segno di un prepotente desiderio di espiazione, come di redenzione da ignote colpe ataviche di cui, pur essendosi perse le origini, restavano tuttavia intatte le ombre, non meno grevi e inquietanti.
Sembrava che i veglianti si stessero un po’ rincuorando, allorché un nuovo urlo attraversò la folla come le incrinature in un vetro prossimo ad infrangersi: la parte di cielo ancora luminosa si andò rapidamente oscurando, fino alla caduta d’un impenetrabile sudario di tenebre. Non c’era luce elettrica, non la minima sorgente luminosa poteva resistere sotto l’imperversare della bufera. Si era ormai al buio assoluto e Velthur, pur stravolto e sballottato, non poté fare a meno di pensare ad esso come alla materia primordiale da cui esplose la Creazione.
Furono lunghissime, penose ore di caotica disperazione: grida, preghiere e bestemmie si fondevano e annaspavano inutilmente nell’aria; corpi aggrovigliati e bagnati cercavano di districarsi per sfuggire a quella mattanza che, pure, non faceva vittime. Nel suo angoletto Velthur provava quel particolare desiderio di piangere che accomuna i poli estremi della disperazione e della gioia.
Fu la voce di Larth a sovrastare all’improvviso il cieco furore dei veglianti. Solenne, stentorea, levava in alto invocazioni simili ad esorcismi e col passare delle ore essa sola rimaneva, senza cedimenti, a testimoniare il dolore di quella gente sfinita ed affamata. Velthur immaginava il Larth di quel momento supremo fino a “vederlo”, eretto in tutta la sua imponente figura, con le braccia tese drammaticamente verso l’alto e la bianca veste che la tempesta non riusciva, non poteva riuscire a tingere di rosso. Ma invece anche quella voce cominciò ad un tratto a vacillare, mentre d’intorno ormai non si levavano altro che flebili lamenti invocanti “pietà…” Infine cadde pure quell’ultimo baluardo e sul profondo, disperato sonno degli uomini si riversava, a ondate, il muggito degli elementi.
* * *
Velthur giaceva supino, col capo poggiato su qualcosa di duro e scomodo; sulla guancia destra avvertiva una sensazione di piacevole tepore. Faticosamente cercò di aprire gli occhi, di vincere sia il pesante torpore che il senso di abbacinamento che gli dava la luminosità filtrante attraverso le palpebre. Quando finalmente riuscì a recuperare il pieno uso sensoriale fu folgorato dallo stupore. Lo scompartimento ferroviario era vuoto; sul sedile c’era solo la valigia che gli aveva fatto da cuscino. Mentre si massaggiava il collo indolenzito guardò fuori del finestrino aperto: il paesaggio era di un intatto nitore, il cielo azzurro intenso, il sole dardeggiante.
Macchinalmente Velthur si guardò le mani e i vestiti, sgualciti ma asciutti e senza macchie, poi si scrollò di dosso un’immaginaria polvere. Ancora, guardò la data sull’orologio e si accorse che era Martedì Santo: aveva solo dormito un po’ più del solito. Con un fondo di perplessità raccolse da terra il giornale ormai vecchio di ventiquattrore e prese ugualmente a sfogliarlo, distrattamente. Dopo un po’ cominciò a percepire una sensazione di caldo, un caldo afoso e sgradevole. Pur stando perfettamente immobile avvertiva, sulla schiena, la formazione di minutissime goccioline di sudore che si univano in un filo e tanti fili che si univano in un solo rivoletto. Velthur allora, senza interrompere la lettura, con gesto meccanico cavò da una tasca un arruffato fazzoletto con delle chiazze color rosso vivo e ci si asciugò la fronte, lasciandovi un paio di leggere strie rosate.
Intanto il treno penava sulle rotaie ed ogni tanto gemeva e sbuffava come un bue ferito. Ben presto si confuse, in lontananza, nella tremolante nebbiolina d’afa che iniziava a salire dall’orizzonte.

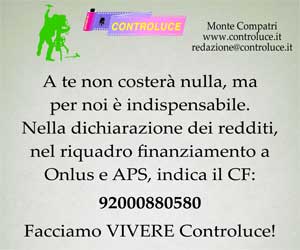


















































































































































































Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento