Turlo il bambino etrusco
Nell’Italia antica, tra il IX e il IV secolo avanti Cristo, visse un’importante civiltà presso i territori dell’odierna Toscana, di parte del Lazio, dell’Umbria e della pianura Padana: tra mirti, piante verdi e profumate tipiche della selva mediterranea, olivi, viti, cavalli e bovini caratteristici e imponenti, mentre il mar Tirreno fluiva grande a ovest.
Le opinioni sulle origini di questo popolo sono diverse. Si parla di teorie che lo ritengono proveniente dalla Lidia, altre dall’Asia Minore, ma pare che la più attendibile sia l’ipotesi che vede gli etruschi giunti dal Mediterraneo e precisamente dalla zona orientale tra l’Ellesponto e la Siria.
Notevoli erano le città-stato che rappresentavano modelli di comunità, presso cui le genti convivevano, cercando di garantire il benessere al popolo. Anche gli etruschi narravano favole ai fanciulli per aiutarli a crescere e Turlo, il bimbo protagonista delle nostre storie, si recava ogni giorno presso l’oliveto, dal quale gli addetti alle arti divinatorie, leggevano il cielo, i fulmini e le saette e poi consultavano i loro grandi libri. In questi libri si trovavano anche tante favole.
Una crescita importante, in questo periodo ebbe, proprio in seno alla civiltà etrusca, l’arte.
I sapienti della città-stato narravano di popoli che riuscivano a vivere senza paura di chi tanto si vantava di essere superiore ed era arrogante.
Proprio in riferimento alla produzione artistica quel giorno, mentre si frescheggiava presso la pineta e l’aroma di resina si univa al frinire delle cicale, venne raccontato leggendo nel libro dell’oliveto:
IL SEVERO BEAUTO
Beauto era guerriero spavaldo e superbo. In modo altezzoso e presuntuoso fece costruire una enorme statua. La scultura di terracotta bianca era imponente al centro della città.
“Guardate la mia statua e tremate!” urlava Beauto.
Era una costruzione mastodontica, con un uomo armato e il busto eretto coperto da un gran mantello, aveva lo sguardo malvagio, teneva una scure e mostrava la dentatura.
Il popolo vedeva quella scultura statuaria gigantesca e tremava di terrore, tutti avevano paura.
Beauto con tale statua s’impose al resto del popolo. Ognuno aveva timore di fronte a quella figura grande, che troneggiava in mezzo alle vie di pietra serena.
“E’ troppo imponente!” dicevano e fuggivano non appena vedevano Beauto, altero e borioso, minacciare.
Scappavano i cani e i gatti, piangevano i fanciulli, si nascondevano i vecchi e le donne.
“Che statua possente!” si vantava Beauto avendo in mano il potere della città. Tutti erano ai suoi ordini ed egli sentiva di avere in pugno la situazione. L’angoscia aveva colto i suoi compagni, non sapevano più come fare in quella situazione di tirannia di Beauto, che imperava altezzoso.
Un giorno una nuvola buona si mise in mezzo al cielo terso. Si avvicinò alla statua gigantesca e possente. Pareva davvero una statua potentissima, ma la nuvola si annerì, scatenò un fulmine che colpì la figura scolpita ed essa si sbriciolò in mille e più pezzi.
Il popolo accorse nel mezzo della via ed esultando:
“…E noi che avevamo avuto tanta paura, non era niente altro che una statua debole debole!” dissero davanti alla terracotta andata in frantumi.
Troppo spesso ciò che appare tanto imponente, poi in un attimo si riduce in briciole.
Gli etruschi erano maestri di eleganza. I tessuti erano normalmente in lana variamente colorata o lino. Gli uomini usavano perizomi, lunghe tuniche e portavano cappelli. Le donne avevano vesti più fluenti e si decoravano con orecchini, bracciali, anelli e fibule . Particolare attenzione c’era per le calzature, di cuoio in inverno. D’estate, specialmente i fanciulli come Turlo, usavano i sandali. Proprio quel giorno Turlo aveva i suoi bei sandali nuovi. Li portava gioioso per la selva, correndo tra i pruni e ammirando gli aironi in cielo dirigersi verso il mare. A caratterizzare la civiltà etrusca fu soprattutto la capacità di integrarsi all’ambiente naturale. Turlo si avviava presso la costa. Camminò a lungo sull’arenile, col volto dolcemente sferzato dallo zefiro marino, poi andò verso l’oliveto, presso il quale i grandi saggi lessero una bella favola dal grande libro, proprio in relazione alla natura.
LA BONTA’ DEL FIUME
C’erano una volta, nella pianura che si stendeva verso la foce del fiume, tante piante che chiedevano acqua e alberi da frutto assetati.
“Sono egoista e tengo il mio prezioso liquido per me!” diceva il fiume, per nulla intenzionato ad arrecare beneficio all’ambiente. Tutto intorno era brullo e secco. I rami scheletriti pendevano gialli e stenti, gli uccellini non sapevano dove fare il nido, non c’erano petali colorati né profumi.
“Facci nuotare!” supplicavano i pesci al fiume, ma lui non permetteva a nessuno di occupare il suo corso.
“Non voglio dare niente né donare!” diceva.
Si narrava di posti lontani e splendidi, arricchiti dalle fragranze dei fiori e dal vivere di tanti felici animali.
Un giorno, alla riva del rio si avvicinò una splendida cerva che accompagnava i suoi piccoli all’abbeveraggio.
“Fa rinfrescare la bocca ai miei figli!” chiese la cerva al fiume, ma lui non volle ascoltare.
“Sono un egocentrico e non ci penso nemmeno!” rispose sdegnato dalla richiesta.
Tutti guardavano questo malvagio corso d’acqua: c’erano le averle appollaiate sui pini secchi e i cinghiali in cerca di ghiande.
Il fiume si accorse di essere scorto da un così nutrito pubblico e decise:
“Adesso vi darò una bella lezione!” e fu una lezione d’amore.
Il canale mostrò quant’è bello regalare. Iniziò a dare la sua acqua a fiori e piante, alberi e animali assetati. Mandrie di cavalli sauri, morelli e bianchi, con gran soddisfazione si rifocillavano all’abbeverata. I puledri nitrivano salutando i bei bovini maremmani, anch’essi lieti di poter bere. Nacquero il lentisco e la lupinella, gli alberi divennero frondosi, gli oleandri tinsero ogni cosa di rosa, rosso e bianco.
Divenne un paradiso terrestre, con la natura rigogliosa e il fiume si accorse che più donava, più si sentiva colmo di pienezza, fu la vittoria della bontà.
Presso il misterioso popolo etrusco, assai importante era la famiglia. Famoso è il celebre capolavoro denominato il “Sarcofago degli Sposi”. Esso rappresenta il ritratto scultoreo di una coppia di coniugi intimamente legati tra loro. Il senso della famiglia e della fratellanza erano fondamentali per l’etrusco, ma era il sentimento di amicizia in generale che veniva predicato ai giovani, come venne narrato dai grandi saggi quella mattina attorno al libro magico delle fiabe, mentre tutti i bambini ascoltavano estasiati.
IL CAMMINO
Il popolo non sapeva più dove andare. Arduo era il cammino e tutto si fece buio.
“Non vediamo al di là del naso!” protestavano gli uomini.
Le donne abbracciavano con le loro materne membra i propri piccoli cercando di calmarli, mentre si versavano lacrime di sconforto.
Volarono in cielo i terribili uccelli neri della guerra e del maleficio.
I ragazzi più gagliardi e robusti decisero di salire in alto per osservare meglio. Avevano davanti tutta la piana che portava al mare, ma non vedevano nulla. Le tenebre vincevano ogni cosa.
“E’ buio pesto!” esclamava la vedetta, non comprendendo che per continuare il percorso serviva qualcosa di magico.
A tentoni si cercò di procedere, ma il terreno divenne palude.
“Come fare per andare avanti?” chiese il lucumone ai suoi consiglieri.
Ognuno proponeva una risposta, ma a nulla serviva ricercare e studiare. Il più buono del popolo era un vecchio cieco:
“Vi condurrò io!” disse l’uomo privo della vista. Aveva il viso stanco e carico d’anni, ma un bel sorriso lo abbelliva. Egli poggiò il suo bastone sull’erba e mostrò una traccia solcando il terreno.
“Procederemo verso il mare dove troveremo la mèta!” diss’egli.
“Ma tu non ci vedi!” commentarono tutti, quando la saggia civetta che cantava in quella notte buia declamò:
“Il cieco è l’unico di voi che vede la luce dell’amicizia, seguitelo in quanto è lui guidato dalla luce della fratellanza!” e immediatamente, dietro all’anziano cieco, si misero tutti in fila indiana o tenendosi per mano… mentre fu grande luce.
Principalmente, tra gli etruschi, si annotava l’esistenza di dodici città-stato. Nei momenti che richiedevano la necessità, ogni città-stato inviava un proprio delegato al tempio della dea Voltumna, ove si tenevano le riunioni per decidere, scambiare, unire forze, progettare.
Presso la sacra costruzione i rappresentanti delle dodici città discutevano, offrivano i loro saperi e fruivano di conoscenze.
La dea Voltumna era pregata come regina della maturazione dei frutti e proprio come un frutto che matura, cresceva ognuna del le varie città-stato, grazie a questi scambi. Spesso i saggi narravano di tali riunioni e della lega della dozzina di città. Le città-stato di questa dodecapoli etrusca erano: Veio, Caere, Tarquinia, Vulci, Roselle, Vetulonia, Populonia, Volterra, Volsinii, Chiusi, Perusia, Cortona, Arretium e Fiesole.
Mentre dall’oliveto guardavano il fiume scorrere verso la foce, i bambini etruschi, tra i quali sorrideva il nostro ardito Turlo, udirono un racconto proprio sull’utilità del conoscersi e dello scambiare:
CONOSCERSI
Golo è il capo di un gran popolo. Essi inneggiano a Minerva e Marte, possiedono estese pianure, ma non vivono bene. Non sanno coltivare né allevare, non conoscono la lavorazione dei materiali e si isolano dal resto del mondo.
“Come mai la vita è così dura?” chiede Urlo al proprio Capo… egli non risponde. Golo è tutto preso a tenere gli altri a distanza, non vuole compiere viaggi per conoscere nuove terre e scambiare conoscenze, non ha nessuna intenzione di avere contatti con gli altri popoli.
Quella mattina in cielo c’è un bel sole, ma la gente non sorride, ci sono problemi persino per alimentarsi.
Un bambino corre in mezzo al campo e guarda il sole. L’astro del giorno storce il naso osservando questo popolo tanto appartato e solitario.
“Perché sei triste?” chiede il bel sole sorridendo al fanciullo.
“Il nostro capo vuole per noi l’isolamento!” dice il piccolo assai mesto, con la fronte aggrottata e gli occhi lucidi.
Cade una lacrima. Il sole spedisce i suoi raggi magici sulla lacrima che brilla e scrive in alto nell’aere:
“Conoscersi e scambiare con gli altri popoli è la prima regola per un mondo che cresce, unito, solidale e ricco di frutti: mai isolarsi!”
La gente allora comincia a correre, prepara fagotti e mette scarpe da viaggio. Tutti partono, iniziano a imparare nuove cose dagli altri popoli, a scambiare, apprendere. S’inizia a saper coltivare, ad allevare: tutto cambia e il benessere viene rendendo tutti felici… prima regola è volersi conoscere e scambiare.
Quella mattina Turlo camminava presso il grande tempio. Era un edificio imponente, con una facciata ampia e decorata in terracotta. Dal lato sinistro si entrava e Turlo varcò la soglia d’ingresso. Era un po’ buio dentro e si vedeva il bel soffitto di legno, che sopra era coperto di tegole. Le travi erano ornate da lastre rilucenti, impreziosite da bassorilievi.
La religione aveva molta importanza e il tempio era un ambiente assai frequentato. Il tempio principale era quello di Tinia, il corrispondente dello Zeus greco.
Si costruivano numerosissime tombe per i morti, per aiutare le loro anime prestando fede a una forma di sopravvivenza del defunto.
Ecco la favola che venne una volta narrata dagli auguri , ovvero gli addetti alle arti divinatorie riguardo all’anima:
L’ANIMA AL SIGNORE DEL MALE
Bras era un giovane bellissimo, ma povero in canna.
Camminava mestamente, senza un tozzo di pane, per le vie di Cerveteri, quando il Signore del Male apparve lui e gli disse:
“Vendimi l’anima e divieni cattivo, avrai ori in quantità e non sarai più povero!”
La tentazione fu tale che Bras accettò. La sua anima fu offerta al Signore del male, egli non dovette più mendicare né lavorare. Aveva una grande abitazione, piena di cose preziose e i forzieri ricolmi.
“Adesso che sei ricco e la tua anima è mia, ti ordino di non tagliarti più le unghie per 30 anni e di non tagliarti più i capelli per 50!” dispose il Signore del Male.
Bras divenne orribile. Non era più bello, con le unghie lunghe lunghe e i capelli che gli coprivano il volto.
Avvenne un giorno che l’intera città dovette affrontare una grande carestia. Non c’era più pane per nessuno e il solo a essere ricco era Bras, con le sue casse alimentate dal Signore del Male, al quale aveva venduto l’anima. In cuore tuttavia, Bras era rimasto buono e pulito. Non resistette allo spettacolo dei suoi compagni che affrontavano la fame e donò tutti i suoi ori, per salvare il paese dalla carestia. Di colpo il Signore del Male rifiutò la sua anima, gli furono tagliati i capelli e le unghie. Tornò bellissimo e tutti lo riconobbero. Non aveva più gli ori offerti dal Signore del male, ma il lucumone lo prese nel suo palazzo come primo consigliere e visse d’allora felice e appagato, a lungo, con gesta scritte dai grandi storici sugli annali, sempre pronto a far del bene e aiutare la gente.
La grande ricchezza del popolo etrusco, non era solo quella di avere a portata di mano abbondanti prodotti naturali. Gli etruschi erano infatti assai abili, nella capacità di ottenere prodotti lavorandoli. Bravissimi artigiani, usavano ferro e rame con ammirevole tecnica, creando statuette di uomini, donne, scimmie. Si lavoravano anche bronzo e ambra, mentre in ceramica nera si producevano i famosi buccheri, bellissimi vasi che venivano persino commerciati con la Grecia.
Non mancavano preziosi gioielli fatti con l’oro importato, essendo principalmente gli etruschi una genia di commercianti.
Turlo assisteva quella mattina alla creazione di una coppa d’oro. Si erano da tempo cominciati, in Etruria (circa XI – IV secolo a.C.), dei giochi sportivi per farsi perdonare dagli dei.
“Avete fatto guerre e chiedete perdono! Istituite a Cere delle gare sportive per ingraziarvi gli dei!!” sentenziò la sacerdotessa Pizia. Così si tenevano gare di lancio del disco, salto con l’asta, getto del peso. Gli atleti avrebbero lottato con tutto il cuore, per conquistare gli agognati premi e quella coppa che Turlo stava vedendo nascere dalle mani degli artigiani, era destinata alla finale di corsa, ma in relazione alle gare e alla voglia di vincere le corse, gli addetti alla lettura dei responsi divinatori raccontarono, sfogliando il grande libro, ai piccoli:
LA VERA CORSA
Si teneva quel giorno, nel centro della città, la grande corsa in onore degli dei.
Tutti indossavano tuniche da cerimonia, ricchi e poveri erano presenti.
“Anche io vorrei vincere una corsa!” disse il piccolo Becro, un fanciullo che avrebbe pagato chissà quanto, per conquistare una coppa simile a quella messa in palio in quell’agone.
Fu una gara emozionante, tra grida, tripudi e appassionanti momenti.
Come tutti i bambini, Becro sognò a lungo quella giornata e si cimentò in diverse prove in campo atletico. A lui, tuttavia, non riusciva di eccellere nella corsa.
Sconsolato e mesto si rivolse all’aquila sacra dell’oracolo. Era una figura scolpita color dell’oro, mostrava enorme becco adunco e ali aperte, come a invocare la gente sotto di lei.
“Voglio diventare un asso della corsa!” si spiegò Becro con il rapace sacro.
Solo i bambini riescono a intendere le magie e il giovane capì il responso dell’aquila che gli disse:
“Chi corre per vincere la corsa atletica, sa che c’è un solo premio: la coppa. Tu corri invece per l’amore; la corona di vittoria per chi ama non è per uno solo, ma per tutti coloro che aprono il cuore!”
“Ho capito! Da oggi non sognerò più di vincere le gare nell’arena, ma di galoppare nella strada del sentimento!” rispose Becro, che imparò così ad assaporare la gioia di voler bene e di avere tanti amici.
Il popolo etrusco si è distinto sia per le conoscenze tecniche, sia per i lunghi viaggi in mare, ma soprattutto è stata la sua società ad appassionare gli studiosi. Analizzando con attenzione il sistema comunitario degli etruschi, si evidenzia che era la famiglia, centro portante di tutto. Genitori, figli e nipoti convivevano. Il padre aveva estrema importanza e tutti erano legati da fortissimi vincoli. Anche la donna aveva un ruolo speciale e i suoi compiti erano assai importanti. La famiglia era un eccezionale addestramento alla vita, si trasmettevano valori e saperi. Turlo non aveva genitori ricchissimi, ma ascoltando la favola di quella mattina, capì che era davvero fortunato, perché ci sono cose che non hanno prezzo e valgono assai più dei soldi e dell’oro.
LE COSE MATERIALI
Per il popolo presso il grande lago, era fondamentale la ricchezza. Il commerciò aveva valore primario, in quanto Fenici e Greci, Orientali e Occidentali scambiavano merci preziose e di gran valore.
“Viviamo solo per le cose!” dicevano tutti e s’impegnavano con ogni zelo e forza, per accrescere il contenuto dei propri forzieri.
Si viveva solo col pensiero di non perdere le cose materiali e divenire sempre più ricchi.
La fanteria di questo popolo aveva scudi tempestati di diamanti, i gambali erano d’oro e i generali avevano l’elsa delle spade, decorata con zaffiri e smeraldi.
“Quanta dovizia!” esultavano tutti, credendo che quella situazione di benessere economico, potesse dare la felicità perpetua, ma invece nessuno era gaio, troppo preso dall’egoismo e dall’accumulo di denaro. Non c’era amore nelle case. Erano avari i nonni come i bambini, erano esosi uomini e donne.
Gli dei erano tristi per questi spettacoli di grettezza e mandarono un messo alato ad annunciare l’ora del cambiamento.
Tra le genti tristi e angosciate, il messo con le piume color niveo e i piedi poggiati su un cirro parimenti candido, disse:
“Non si deve aver paura di perdere le cose materiali, quello che conta è la gioia dei sentimenti!”
Il popolo comprese, con quel messaggio che veniva dall’alto; tutti pensarono un po’ meno ai soldi e alle cose materiali, per amare di più i sentimenti familiari e di unione, sentendosi veramente ricchi. La vera gioia era dato dall’amore nelle abitazioni e con i vicini.
A rendere particolare la vita quotidiana degli etruschi, era l’armonia con la quale le genti vivevano, tutti rispettando il re e lavorando. Grande era la deferenza per la fertile natura e diligenti i comportamenti nelle opere. I campi erano ben divisi e ognuno si dedicava alacremente a coltivarli, anche con le splendide viti che davano il latte d’uva e molti olivi. Prodigiosi, altresì, gli allevamenti di buoi, cavalli e suini. Il popolo viveva in buon accordo, si amava, in clima pacifico, la musica e si banchettava spesso, giocando magari a dadi.
“Bisogna sempre essere uniti!” predicavano gli aruspici a Turlo e ai compagni e raccontarono:
L’ARTIGIANO E LA COMUNITA’
C’era una volta un artigiano che odiava il prossimo e non voleva avvicinare nessuno.
“Voglio star solo!” protestava nella sua bottega, sotto ai begli archi a volta di quell’ambiente e contornato da vasi e oggetti ben lavorati, era infatti un ceramista davvero bravo.
Con quell’odio verso il prossimo sprangò però porte e finestre, per rimanersene in solitudine. Gli altri erano preoccupati.
“Aprici!” lo supplicavano battendo all’uscio, tuttavia lui insisteva a rifiutare la compagnia del prossimo.
Trascorsero i giorni. Le scorte di viveri in casa andavano terminando e non c’era più la creta per torniare vasi e brocche.
“Non posso più lavorare, non ho più da mangiare; tra poco terminerò anche l’acqua da bere!” si accorse. Non potendo più fare niente si sdraiò sul lettuccio nel retrobottega. Tutto era pieno di bei soprammobili, ma adesso non poteva più lavorare. Senza mangiare e senza bere cominciò a sentirsi venir meno e cadde in un sonno profondo. In sogno apparve lui un essere magico, che sorse da una nuvola di fumo color argento. Era un luogo al limite del mondo, dove volavano uccelli bellissimi e si respirava un’aria frizzante e vivificante, era il regno dell’amore.
“Perché qui si respira quest’aria?” domandò l’uomo all’essere fatato.
“Qui ci si ama. Nessuno può bastare a sé stesso: bisogna accogliere amici e compagni!” sentenziò quella figura incantata. L’uomo si risvegliò e aveva ben capito che non si poteva vivere isolandosi, ma bisogna interagire con gli altri. Tosto spalancò la porta del suo negozio e invitò tutti gridando:
“Entrate! Entrate: fratelli e amici!”
Le città etrusche, quando non erano protette dalla particolare posizione, avevano grandi mura a difenderle. Belle porte istoriate segnalavano l’ingresso ai centri, poi si vedevano case di diversa fattura, anche se molto regolari, divise in borghi e rioni più o meno benestanti. Turlo apparteneva a una famiglia di medie condizioni e sebbene la sua casa non fosse troppo grande, era assai elegante, arredata dalle tante suppellettili che costituivano l’adornamento della mobilia.
Vicino all’abitazione di Turlo, stavano edifici pubblici destinati alla conservazione dei cereali e altri magazzini di utilità per i periodi di carestia. Si mettevano da parte derrate alimentari e semenze. Il lavoro, presso questi magazzini, era incessante. Turlo vedeva gli operai sistemare in concerto perfetto, enormi quantità di materiali e cibi, mettere in ordine, aerare i locali, tenere tutto pulito e a posto, grazie all’alacre e zelante lavoro d’ognuno:
“Bisogna operare in euritmia e accordo, per superare le fatiche!” predicavano i saggi leggendo le favole del grande libro, infatti narrarono presso l’oliveto delle fiabe un bel racconto:
QUANDO IL CARICO E’ TROPPO PESO
C’era una volta un enorme masso che andava spostato dalla strada.
“Come facciamo a passare?” chiedevano commercianti che dovevano andare al mercato e contadini bisognosi di recarsi nei campi.
Tutti avevano occorrenza di trovare la via sgombera, ma non era possibile andare oltre quel gigantesco macigno. Ormai il sole era alto in cielo, tuttavia il cammino era impedito.
Si presentò un uomo muscoloso e aitante e iniziò a spingere il masso, ma a nulla servì.
“Tenterò io!” disse uno dei contadini. Spinse il blocco di roccia aiutandosi con gli attrezzi per lavorare la terra e fece mille sforzi, ma non ottenne niente altro che grosse stille di sudore.
Ce la mise tutta anche un commerciante:
“Non si smuove!” commentarono tutti.
“Non c’è che un modo di spostare le grandi cose e superare gli impedimenti: bisogna unirsi. Il masso sarà meno peso se il carico sarà portato da tutti!” disse un anziano.
Così contadini e commercianti, passanti e normali abitanti, unirono gli sforzi.
“E’ vero, ogni fardello, ogni croce, riescono a essere portati se ci mettiamo insieme!” esultarono i presenti, riuscendo a spostare il masso e a sgomberare la via.
Gran lusso per i ricchi tra gli etruschi, ma anche per i meno abbienti non mancava da mangiare: c’erano pane e cibo per tutti. La gerarchia era molto rigida, tuttavia nessuno pativa la miseria più nera. Ai giovani, i saggi aruspici narrarono quella volta, una favola sulla ricchezza degli animi, che vale più del borsello colmo di monete:
LA RICCHEZZA DEL CUORE
“Viva i danarosi!” lodavano tutti davanti a chi esibiva ori riccamente lavorati, provenienti dall’oriente.
Nessuno stimava il pio Festo, ragazzo tanto buono d’animo e generoso, in quanto lui non aveva monete, né si adornava di monili.
Il popolo festeggiava chi passava per le vie della città decorato di oggetti preziosi, mentre malediva e canzonava il bravo Festo.
Dal Tirreno, i commerci marittimi facevano entrare tra le mura del paese tanti gioielli. C’erano donne con braccialetti stupendi, collane con medaglie raffiguranti il sole, orecchini splendidi ai lobi delle giovani, pareva che mostrare dovizie fosse la cosa fondamentale.
Chi poteva ostentava i propri averi e si dava tante arie, con boria e alterigia.
Quella mattina, come al solito, giunse l’ora di recarsi al tempio, per udire la predica del Gran Sacerdote, che illuminato dai segni celesti insegnava comportamenti e disciplina.
Festo era presente e voleva ascoltare, ma tutti lo spingevano:
“Tu sei povero! Fatti in là!” gli dicevano.
Il Gran Sacerdote aveva quel giorno, da sentenziare un insegnamento assai importante. Aveva osservato il cielo e consultato le viscere di un uccello.
“Ho da fare una gran rivelazione!” disse serio il ministro del culto. Tutti erano attenti e porgevano l’orecchio.
Il Gran Sacerdote fece venire avanti Festo, poi disse:
“Noi lodiamo il cavallo quando è vigoroso e svelto, non per la sua bardatura. Apprezziamo un levriero per la sua velocità e non per il collare. Ci piace un uccello per le sue ali e non per le corregge e i suoi sonagli . Perché allora, allo stesso modo non stimiamo Festo per la sua bontà d’animo, senza pensare alle sue poche ricchezze?”
Dopo quelle parole tutti impararono a stimare e amare Festo, che divenne apprezzato e reputato grande uomo da ognuno.
A Turlo piacevano molto le produzioni artistiche degli artigiani. Il giovane trascorreva ore e ore a osservare, nelle loro botteghe bronzisti, orefici e ceramisti, dar vita a oggetti destinati ai ricchi sbalzando materiali, che poi i nobili avrebbero esibito. Un artista era particolarmente intento a lavorare, si chiamava Breto; era ammirevole e oltretutto era anche un brav’uomo: i saggi e i bambini lo indicava come una sincera persona.
Stimandolo e tenendo in gran conto la sua lealtà, i saggi lo portarono ad esempio ai piccoli e narrarono un bel racconto sulla sincerità e la dirittura morale:
BENE NEL CUORE
C’era una volta un artigiano che per essere lodato dagli altri uomini avrebbe commesso qualsiasi malefatta.
“Voglio fare un bucchero!” disse e decise di rubare il materiale necessario. Non gl’interessava essere probo e onesto.
“Ruberò anche dell’oro e produrrò capolavori assai importanti, così tutti festeggeranno la mia maestria!” pensò.
Trafugò metalli preziosi e creò tanti ornamenti di pregio. Sui suoi scaffali c’erano oggetti assai costosi, che lui aveva sottratto agli onesti.
“Riceverò lodi in quantità!” sognava.
La notte però, quando andava a coricarsi, si rigirava nervoso tra le lenzuola. Il rimorso per aver rubato lo assaliva.
Proprio quella sera, all’ora di andare a dormire, in cielo si scatenò una tremenda bufera. Ora dovete sapere, che gli etruschi erano capaci di leggere nei fulmini, i messaggi del cielo.
Un fulmine lampeggiò saettando nel firmamento oscurato dal violento temporale:
“Ho paura!” urlò il disonesto artigiano.
“Non temere, voglio solo guidarti a cambiare!” rispose tuonando il fulmine e gli disse:
“Non cercare la lode degli altri uomini, ma la serenità del cuore!”
Il turpe artista decise la svolta. Non appena il cielo annunciò tra le nubi, il sorgere del sole, quando le nuvole grigie del passato temporale erano vinte da una bella tinta rosea, l’uomo sortì di casa, rendendo ori e metalli rubati. Da quel giorno fu onesto e in cuore si sentì così bene, che mai più ebbe problemi ad addormentarsi.
Il popolo industrioso e capace degli Etruschi, ci ha lasciato numerose necropoli e testimonianze, come monumenti e iscrizioni. Dell’epoca di Turlo, sono reperibili anche diversi oggetti votivi, posti davanti agli altari degli dei, in bronzo o in argilla.
Era una bella mattina di sole, quando davanti a uno di questi oggetti votivi, un buon pastore lavorato nella creta, i saggi aruspici narrarono una favola sull’amore verso il prossimo:
LO STIPENDIO DEL MALE
C’era una volte un ricco signore, che accumulava ricchezze nocendo al prossimo e facendo del male:
“Commetti gran peccato!” lo ammonivano i sacerdoti, lui tuttavia non ascoltava. Attendeva ogni giorno il calar della notte e celato alla vista dal buio delle ore prive di sole, si addentrava nelle case della gente per colpire e rubare.
Faceva del male ovunque. Bastonava i cani da guardia e accoppava con una mazzata chi si destava nell’udire i suoi passi, mentre trafugava oggetti preziosi e soldi.
“Sono assai ricco!” cercava di rallegrarsi contando il bottino, tuttavia in cuore provava un gran dolore. Tutto quell’agire male e peccare, procurava lui tanta costernazione e si vergognava di sé stesso, pensando alle malefatte. Aveva perso l’appetito e non era più capace di cogliere un momento di pace. Osservava i compaesani vivere felici in gran concordia e gaia armonia. Tutti erano solidali e amici, lui invece non aveva compagni, non sapeva godere dell’appagamento di aiutare il prossimo e si preoccupava solo di rubare. Il suo forziere, nel quale custodiva oggetti trafugati di gran valore, era stracolmo, ma il suo animo sempre più mesto.
“Come mai gli altri sono così felici? …Mentre io sento il mio spirito spengersi?” chiese questo ladro al sacerdote.
“La morte del cuore è lo stipendio del peccato !” gli rispose il ministro del culto, poggiando la mano sul suo bastone e camminando lento ma sicuro.
L’uomo decise di cambiare. Non rubò più e cominciò a compiere opere di bene. Così facendo il suo cuore iniziò a essere felice e la sua vita divenne allegra e lui contento.
L’arte etrusca era assai legata ai bisogni quotidiani. Si producevano infatti, non solo ornamenti per le case dei ricchi, ma altresì oggetti d’uso giornaliero, ora con semplice e puro gusto d’artigiano, ora con vera maestria.
Si lavoravano bronzi e terrecotte, ma ad attirare i fanciulli, tra i quali il più curioso era Turlo, erano falegnami. Belli erano infatti i vasi di ceramica, ma spiccavano pure quelli in argilla dorata o argentata. I metalli davano origine a splendidi monili e l’oreficeria era d’alto livello. Anche le sculture, in pietra, travertino o alabastro, venivano ammirate, come pure le pitture che decoravano le abitazioni o adornavano le tombe . Spesso, percorrendo le vie della città, i giovani si mettevano a osservare l’arte della lavorazione del legno. Proprio un bel giorno di sole, vicino alle grandi querce della selva, gli aruspici narrarono una fiaba sui falegnami:
IL FALEGNAME MAGICO
C’era una volta un paese nel quale si pensava solo a combattere e guerreggiare; così tutti lavoravano per preparare l’esercito alle battaglie e agli scontri. In quel modo la vita era un continuo incubo. Si sognavano le lotte con scudisciate e pugnalate, colpi di spada ed elmi insanguinati.
“Compiremo grandi stragi!” dicevano i capi delle forze armate e si attendeva l’alba solo per partire alla volta di una guerra.
Anche gli artisti erano ridotti unicamente a produrre armi. Non si lavoravano statuette od oggetti per decorare la casa.
Il fabbro faceva lame taglienti per uccidere i nemici. Il bronzo veniva usato per creare oggetti d’assalto, era tutto un mirare a sconfiggere il vicino.
C’era solo un falegname, talmente buono che piangeva ogn’ora per il suo popolo tanto aggressivo e violento.
“Tu che arma costruisci?” gli chiese il capo dell’esercito con già imbracciato lo scudo a figure nere. Il capo si attendeva una bella elsa di spada per ammazzare il prossimo.
Il falegname buono invece rispose:
“Io costruirò la pace!” e lavorò un grande tronco nel quale scolpì un enorme cuore. Il cuore venne posto al centro della città. Era un cuore fatato, perché fatto con passione e chiunque lo toccò comprese che la guerra produce solo male e sofferenze: nel giro di pochi giorni tutti gettarono nel burrone le loro armi e il paese divenne un luogo di pace.
Celebri per aver costruito ponti e acquedotti sono soprattutto i romani, troppo sovente, tuttavia, si dimentica di ricordare che il popolo della città imperiale sfruttò le conoscenze etrusche.
Le città etrusche, difatti, erano di solito erette presso fiumi. Nella parte nord del Lazio, o nell’Etruria, sorgevano città vicine all’Arno e al Tevere: dovendo scavalcare i corsi d’acqua, si dovettero così progettare importanti ponti. La tecnica costruttiva era notevole e si videro ponti in quantità.
A Turlo piaceva molto ammirare quelle strutture che permettevano di andare oltre le sponde; ascoltò quindi con molta attenzione la favola narrata, riguardo ai ponti, dai saggi del Grande Libro letto presso l’oliveto:
PONTI D’UNIONE
C’erano una volta, tanto lontano, in un posto assai bello da commuovere gli abitanti per i colori dei fiori e il profumo delle piante, dei popoli che si lasciavano vincere dall’egoismo e dalla cattiveria:
“Dividiamoci dagli altri!” dicevano i componenti ogni tribù, così si erigevano mura divisorie, sparirono i fiori e i colori.
Ogni paese era isolato dall’altro e si scavarono fossati attorno a ogni centro.
Nella solitudine, ogni popolo cessò di scambiare conoscenze con l’altro. Neanche il commercio era più attivo. Non si parlava con il vicino, in piena segregazione.
“Vogliamo stare soli!” si urlava.
La divisione vinceva su tutto e gli uomini divenivano simili a orsi, riottosi nel comunicare con il prossimo e tanto ostili verso chiunque. Le persone cominciarono a smettere di saper parlare, le donne s’ingobbirono, tanto prese a guardare per terra anziché osservare lo sguardo delle altre donne e i bambini no sapevano più giocare.
Più il tempo passava, più si erigevano alte mura per separare ogni città dall’altra. Il mondo divenne triste e mesto fino a che non giunse un uccello d’oro. L’essere alato aveva splendide piume auree che risplendevano nell’aere.
Tutti voltarono gli occhi verso la volta celeste, mentre lui si librava in cielo dicendo:
“Non costruite muri di divisione, ma ponti d’unione!”
La gente cominciò a superare gli ostacoli che dividevano le città costruendo grandi ponti. Si ritornò a comunicare e scambiare. Non erano più orsi gli uomini, ridevano i bambini, erano contente le donne e la vita tornò a essere bella mentre sbocciarono nuovi fiori e belle piante.
La religione per gli etruschi era assai importante, essa disciplinava gran parte della vita di questo misterioso popolo. Le divinità erano per lo più legate alle forze della natura. C’era Tarconte, il dio della Tempesta, c’era Velthune che rappresentava il continuo incessante mutare delle stagioni e gli dei Selvans legati alla foresta. I sacerdoti predicavano continuamente la solidarietà e l’unione e ai fanciulli, tra i quali Turlo era il più attento, narrarono:
QUEL FUOCO ECCEZIONALE
Faceva freddo ed era buio. Le genti non sapevano più come fare, cercavano di riscaldarsi vicino alle torce accese ma la fiamma era troppo debole, tentavano di rischiarare le tenebre ma ogni cosa era offuscata.
“Vorremmo poter volare alti in cielo come quegli uccelli!” dissero gli uomini rivolti al lucumone e indicando degli splendidi volatili che compivano piroette tra le nuvole bianche.
Il lucumone invocò gli uccelli, mentre i saggi cercavano di trarre premonizioni dal loro volo.
Gli aruspici lessero il senso di quel battere d’ali e capirono di dover peregrinare verso la selva. All’interno della foresta era ancora più buio:
“Non si vede niente!” si dicevano tastando il terreno tra le foglie che maceravano vicino ai tronchi delle querce.
Si udirono spezzare dei rami secchi. Tutti avevano paura, pensavano ai miti infernali come l’orrendo Tuchulca dal volto d’avvoltoio armato di serpenti, ma ecco che si presentò Turan, la dea dell’amore:
“C’è un solo modo per scaldare e fare luce!” disse la dea nascendo da un roseto selvatico.
Ognuno era estasiato alla visione di una divinità tanto dolce e buona:
“Accendete d’amore i vostri cuori!” sentenziò Turan.
Gli uomini, le donne, gli anziani e i bambini si decisero a manifestare ogni sentimento benevolo verso i compagni. Ogni cuore si accese e si scaldarono abbondantemente le anime fredde. Le fiamme dell’amore facevano anche gran luce: vennero vinti per sempre il ghiaccio e il buio.
Gli etruschi erano rispettati ma anche temuti. Nei mari infatti viaggiavano, non solo per commerciare ma anche per compiere opere di pirateria. Pare però che siano stati soprattutto i greci a raccontare di atti di assalto e attacchi, infatti sin da quando erano piccoli, i giovani venivano guidati ai comportamenti retti.
Davanti ai begli olivi, con le foglie verdi argentee, i saggi narravano per intimare a comportamenti buoni:
“Non cercate la ricchezza nelle monete!” dicevano e venne raccontato a Turlo e agli altri piccoli:
LE MONETE
Fabo pensava solo alle monete. Rubava e attaccava il prossimo e poi comprava oggetti che lo facessero sentire ricco, tuttavia pur avendo l’abitazione piena di pietre preziose, soldi e monete d’ogni tipo, non si sentiva dovizioso.
Aveva i soldi di Vulci e di Populonia, ce n’erano di bronzo, d’oro e d’argento ma era triste. In alcune monete c’erano effigiate le figure degli dei, in altri decorazioni ornamentali.
“Quante monete!” diceva Fabo, ma non provava vero piacere, non si sentiva affatto ricco.
In un forziere particolare ne aveva un gruppo di stupende, caratterizzate dall’immagine di un leone.
“Andrò a vedere le monete con il leone che mi piacciono tanto!” disse Fabo cercando di trovare svago e lietezza tra i suoi soldi.
Aprì il forziere e magicamente sentì il leone della prima moneta ruggire. Il re della foresta aveva per incanto preso vita. Sortì dalla moneta e si mise a mostrare le fauci.
“Aiuto!” cominciò a urlare Fabo.
Il leone era stupendo, il pelo fulvo e dorato e la criniera lo rendevano meraviglioso.
“Accidenti alla mia voglia di essere ricco, troverò la morte proprio tra le mie monete!” si lamentò Fabo temendo di essere sbranato dal leone.
La fiera gli disse allora:
“Non ti mangerò, voglio solo farti capire che a poco ti serve accumulare soldi, non ti sentirai mai ricco perché sei povero nell’animo!” e da quel giorno Fabo smise di rubare e accaparrare monete.
Probabilmente, una delle pecche del popolo etrusco, fu quella di non riuscire a unire le forze di tutte le città per resistere all’avanzata dei romani che andavano dominando il territorio. All’interno però di ogni città-stato c’era gran coesione. Erano gli aruspici che invocavano la partecipazione alla vita comune. Quella mattina, vicino all’oliveto, i maestri parlavano di collaborazione.
“Bisogna essere uniti!” dicevano e poi spiegavano:
“Ci vuole la partecipazione di tutti!”.
Bisognava infatti che il paese vivesse in piena armonia per poter preparare i carichi da inviare in mare, amministrare e lavorare le campagne, usare i metalli e trasformarli.
Ecco una favola che spiegò a Turlo e ai suoi compagni cosa è il concorso di ognuno nell’ambito della cittadina:
UN SOLO CORPO
C’era una volta un gatto magico, dotato di una coda bianchissima e luminosa, questo bel gatto, a ogni giungere della notte si metteva al centro della piazza e narrava un aneddoto ai popolani:
“Viva la pace!” diceva per salutare tutte le sere il micio con la coda bianca alla gente. Allora i facenti parte la popolazione si sedevano intorno all’obelisco che dominava la piazza e ascoltavano cosa aveva da dire il gatto.
“Miao! Miao! Miao!” cominciò in un dì di luna piena. Il satellite terrestre risplendeva bello nel firmamento e pareva illuminare a giorno la pietra serena della piazza.
“La popolazione deve sentirsi come un sol corpo: mi dice la luna!” affermò il gatto incantato.
“…E perché?” chiese la gente; allora il felino rizzò il pelo, come faceva ogni volta che si doveva concentrare e poi cominciò:
“C’era una volta un uomo che voleva vivere da solo e che diceva di non aver bisogno degli altri. Non si accorgeva che era nei forni che i panettieri cocevano per lui il pane quotidiano, non teneva conto dei soldati che difendevano anche per lui la città, dei lattai che mungevano le mucche, della partecipazione di tutti. Una fata lo toccò con una bacchetta d’oro ed egli per incanto si risvegliò all’interno del proprio corpo. Lì il cervello dava gli ordini a tutti gli organi. Gli occhi vedevano e davano informazione agli altri; le mani agivano e prendevano il cibo da portare alla bocca, le braccia stringevano le cose e lavoravano, lo stomaco digeriva ciò che veniva mangiato, le gambe si muovevano ma senza gli occhi non avrebbero potuto farlo, i denti masticavano ma senza i palmi a portare il pasto alla bocca sarebbe stato inutile il loro esistere. Ogni parte del corpo faceva la sua parte, ma ciascuna dipendeva dall’altra, in piena armonia: ognuno è diverso ma ha bisogno degli altri, proprio come la popolazione di una città che è come un corpo, c’è chi costruisce una cosa, chi coltiva i campi, chi alleva i bambini, ma nessuno può riuscire a vivere da solo!” dopo il breve racconto il paese intero venne illuminato dalla coda nivea del felino, egli miagolò a lungo e i paesani cantarono in coro volendo l’unione e la fratellanza… anche quella volta l’aneddoto del micio era riuscito a far comprendere al popolo l’importanza di un insegnamento.
Grazie ai ritrovamenti di tombe e resti di costruzioni, si è potuto studiare e capire com’era fatta la casa etrusca. Quella di Turlo era composta da tre locali: un grande atrio, una sala di ricevimento chiamata Tablinum e un locale destinato al riposo. Assai bella era la copertura, ovvero il tetto, con adornamenti e fregi pittorici . Turlo amava la sua casa e vi passava ore piacevoli, gli avevano insegnato una magia, quella di sentirsi bene nel cuore, allora vedeva la sua abitazione tinta da incantata luce:
LA LUCE DEL BENE
Dall’Aspetto mite e con il sorriso in bocca c’era una volta un infido mercante. Egli parlava con falsa cortesia e poi voleva male a tutti.
“Commercerò per buone merci contraffatte!” architettava, allora preparava vetro vendendolo come diamante, odiava ognuno e buggerava il prossimo.
Quando la sera entrava nella sua dimora però vedeva tutto nero:
“Che buio!” diceva sconsolato tastando le pareti per non sbattere contro il muro. Un senso di angoscia lo assaliva nelle tenebre e desiderava la luce.
“Come posso illuminare questa casa?” si chiedeva lamentando l’oscurità.
Si affacciò dalla piccola finestra e vide che la notte era più luminosa del solito:
“C’è più luce fuori che nella mia casa!” analizzò, poi si mise a osservare il bel salice sul quale si rispecchiava la luna e le cui foglie parevano argentate. Allora si rivolse al cielo e vide la miriade di stelle:
“Ma cos’è che vi fa brillare così tanto?” chiese rivolto agli astri che punteggiavano in una stupenda fantasmagoria il firmamento:
“E’ la luce del bene, noi non inganniamo nessuno e amiamo tanto!” risposero le stelle.
“Prova a diventare buono!” sentenziò la luna.
Il mercante si apprestò a mettere insieme tutte le merci false e le bruciò.
“Da ora in poi tratterò i clienti con amore e amicizia, non trufferò e vorrò bene al prossimo!” giunse così la luce del bene e come in un prodigio la sua casa divenne luminosissima e allegra: non fu più buio.
Popolo di commercianti, gli etruschi, mercanteggiavano per mari e per terre; anche in tutte le città, dopo ogni alba, cominciavano le compravendite al mercato, nel centro del paese. Le flotte mercantili portavano merci da oriente e da occidente. Il lucumone, sul suo trono d’avorio comandava di far entrare in città vari prodotti. A volte dentro alle mura giungevano forestieri. I bambini notavano la differenza della lingua, quello etrusco infatti, idioma misterioso, era assai diverso dal linguaggio dei popoli stranieri.
“C’è un linguaggio che vale per tutti!” dissero gli aruspici quella volta, prima di cominciare la giornaliera narrazione:
CAPIRSI
L’egoismo e la cupidigia avevano diviso sempre più i popoli del mondo. Gli orientali erano separati dai meridionali, chi viveva a nord scansava gli abitanti del meridione: c’erano tanta ostilità e disgregazione.
Vivendo ognuno isolato dall’altro, tutti avevano imparato lingue diverse e nel mondo non ci si capiva più.
Giunse la pioggia e bisognava costruire dighe e rinforzi ai margini dei fiumi.
La gente parlava con le comunità vicinorie, ma proferendo lingue differenti, nessuno comprendeva il prossimo.
Erano preoccupati gli asiatici, non sapevano più come fare gli europei, i neri erano incompresi dai bianchi e così via.
In tutti gli stati si riunirono filosofi e linguisti, cercando di risolvere il problema della incomunicabilità. Non si poteva dialogare.
C’era da trovare una lingua che valesse per tutti.
“E’ indecifrabile!” diceva ogni popolo ascoltando le parole degli altri.
Non c’era possibilità di unirsi e collaborare.
Un giorno provenne dai mari caldi un ibis azzurro. Era un uccello soave e dall’aspetto pittoresco. Dotato di poteri profetici, l’uccello volò di nazione in nazione predicando:
“Parlate con il cuore, abbracciatevi e stringetevi la mano: sarà il linguaggio dei sentimenti quello che varrà per ogni etnia!” diceva il meraviglioso volatile.
Pur non articolando parola, la gente cominciò a dare la mano allo straniero. Tutti si compresero abbracciandosi e collaborando. Furono costruiti muri di argine ai fiumi e dighe e il mondo venne salvato dall’inondazione.
Sul colle degli ulivi, gli aruspici bruciavano profumo per mezzo di una piccola scultura a forma di uccello e con la testa di cervo; era questo il loro modo di officiare agli dei. Intanto i ragazzi assistevano al rito. Un inserviente dei sacerdoti recò un porta incenso, anch’ esso venne acceso. Si trattava di un vasetto munito di ruote, come un minuscolo carro e mentre veniva dolcemente adagiato sul tavolo, il sacerdote bevve da una coppa sacra, poi offrì da bere ai suoi colleghi. Ognuno sorseggiò piano, prima di cominciare a dire ai ragazzi:
“Ricordatevi di vivere con intensità il presente, non indugiate sul passato e non progettate troppo riguardo al futuro: vivete l’attimo!” ergo si narrò a Turlo e ai suoi amici:
LA CHIMERA
La magica Chimera, in quell’inverno freddo, sputava fuoco dalle sue fauci leonine e scaldava la gente. Tutti erano innanzi a questo animale divino, figlio di Tifone ed Echidna, formato da vari animali: capra, drago, serpente e leone. Il leone rappresentava la forza e quindi il calore dell’estate. Il serpente era simbolo invece di terra e indi di freddo, per significare l’inverno. La capra indicava il passaggio e pertanto autunno e primavera. Era un animale che ricordava lo scorrere del tempo.
La chimera ruggì davanti al popolo.
Assai temuta dai viaggiatori, dei quali si cibava, la bestia magica fece gran paura. Un brusio si sollevò dal folto gruppo di astanti. I più si nascosero dietro il muretto davanti all’animale.
“Aiuto!” urlarono i più giovani temendo assai.
Ma la Chimera voleva solo offrire un insegnamento alle genti; vedeva tutti rimuginare sulle stagioni precedenti o vivere in apatia progettando il futuro, ella disse invece:
“C’è chi pensa alla trascorsa estate, chi fa teorie sulla futura primavera; nessuno invece pensa a vivere con intensità questo periodo di riposo della natura, l’inverno, mentre tutto si prepara a nuova nascita. Il tempo passato non esiste più; il futuro è ancora lontano a venire; quello che dovete vivere con tutto il sentimento possibile è il presente !” e i cittadini compresero di doversi lasciare andare e cogliere l’attimo.
La Chimera allora rise contenta, la sua bella criniera fulva e d’oro sventolò allegramente, non aveva da mangiare nessun viaggiatore, solo da insegnare saggezza ai paesani.
Assai amato dai benestanti, era circondarsi di cantori, suonatori di flauto e danzatori. La musica rallegrava vari momenti della giornata etrusca e anche i fanciulli, sul colle degli ulivi si addestravano a suonare il loro strumento.
“Ci vuole amore!” dicevano i saggi cercando di inculcare nell’animo dei giovani quel sentimento necessario per riuscire a intraprendere qualsiasi attività. Con la musica veniva accompagnato il lavoro, si assisteva alle cerimonie civili, perfino durante il pasto si usava ascoltare melodie.
“Dovete fare tutto il cuore!” dicevano gli aruspici e raccontarono:
LA LUCE DELL’AMORE
Era gran buio attorno alle case, erano tenebrose le vie, non si vedeva niente.
Le genti camminavano tentoni cercando di trovare orientamento:
“Rischiamo di cascare!”
“Possiamo sbattere contro qualcosa!” commentavano tutti.
Era davvero un problema, occorreva trovare una soluzione per rischiarare strade e piazze, abitazioni e luoghi d’incontro.
Il popolo provò a unirsi. Camminarono insieme in un brusio di voci, finché si ritrovarono sull’orlo dell’abisso. La forra era profonda e stavano procedendo rischiando di cadere nel precipizio, quando ai musici venne l’idea di mettere il loro amore per il prossimo al servizio dei concittadini.
Glia artisti presero i loro flauti di alabastro bianco, altri imbracciarono lire e cithare , mentre non mancavano strumenti a percussione timpani.
Brillavano di luce propria crotale e trombe, era la luce dell’amore.
Con tutto quel sentimento la vita di ognuno si rischiarò, non fu mai più buio con gli animi illuminati dalla forza delle emozioni e della fraternità. Tutti si misero a danzare al ritmo dei cembali. Il precipizio era ben visibile e così il pericolo lontano. Ballarono a lungo per tutto il dì, ora che avevano compreso che con la luce del sentimento si rende limpido il cammino e tutto diviene più bello.
Il freddo invernale era ormai al culmine. I ragazzi correvano per riscaldarsi sulla collina degli ulivi, mentre Turlo si baloccava a giocare a nascondino coi suoi amici. Gli aruspici avevano trascorso la notte a mirare le nubi scure nel firmamento per avere indicazioni dal cielo, adesso erano in preghiera e stavano per accingersi a tenere la solita lezione per i più giovani. Era un dì di penitenza, i sacerdoti avevano indosso leggere tuniche bianchissime:
“Non accumulate cose e averi, pensate al cuore!” disse il sommo sacerdote ai ragazzi e cominciò una storiella con l’intento di far capire che a poco serve circondarsi di oggetti e suppellettili, se non si ha un cuore pulito:
LA FELICITA’
Il guerriero Dromo era assai triste e sempre angosciato. Depresso e con il morale sotto ai piedi, si diresse verso la vetta del monte. Tirava un gran vento che gli ghiacciava il viso e lo faceva tremare di brividi. Egli infilò le mani nelle maniche della casacca per scaldarsele un po’ ma soprattutto era nel cuore che era freddo, privo di sentimenti e amore.
“Andrò alla ricerca dell’elmo d’oro e sarò finalmente felice!” disse Dromo, togliendosi l’ammaccato elmo di bronzo che portava a proteggergli il capo e deciso a trovare il famoso elmo d’oro.
“Con quell’elmo prezioso sarò per sempre gaio!”
Mise del cibo nella bisaccia e decise di avventurarsi per scoprire dove era nascosto l’elmo aureo.
Vagò per tombe e tempi e sudò sette camice. Sotto la cotta di maglia che gli serviva per proteggersi dalle frecce nemiche, brillò per magia una lucciola.
Era la lucciola dei tesori:
“Ti guiderò al forziere dov’è custodito l’elmo d’oro!” disse il piccolo insetto accendendo il suo lumino.
In poco tempo Dromo venne condotto presso la sala di un palazzo di vetro. I raggi del sole s’infrangevano nei prismi delle mura dell’edificio e una serie di raggi indicava una teca. Dentro la teca, pur’essa di cristallo, c’era un bel forziere tempestato di diamanti. Dromo aprì il forziere e trovò l’elmo d’oro, da gran cerimonia, con fregi stupendi nella parte anteriore e disegnati guerrieri sui lati, il tutto decorato con scritte di smeraldo.
“Ecco che finalmente hai il bellissimo elmo!” disse la lucciola a Dromo.
“…Ma non sono affatto più felice!” rispose il guerriero.
“Infatti: non è nelle cose che puoi trovare la felicità, la devi cercare dentro il tuo cuore !” rispose la lucciolina.
I fanciulli avevano un po’ di timore nel vedere tutte quelle tombe, quelle necropoli costruite nei sotterranei. Per ogni defunto c’erano camere particolari e locali assai importanti. Insieme alla salma si mettevano cibo e suppellettili e ogni cosa della quale il trapassato avrebbe potuto aver necessità.
“Non si deve aver paura della morte!” dissero durante una fredda ma assolata e luminosa mattina i saggi dell’oliveto. Venne aperto l’importante libro e si lesse un racconto denso di saggezza:
LA PAURA DELLA MORTE
Il cratere aveva tonato da poco ma i fuggitivi non ebbero tema:
“Ci nasconderemo nella bocca del vulcano per scappare agli inseguitori!” era un popolo innocente di esuli, che viveva d’amicizia e d’amore e per questo inviso ai potenti. L’esercito inseguiva questa gente piena di buon cuore e di misericordia.
“Ma potremmo morire dentro al cratere!” urlò qualcuno, volendosi sottrarre all’idea di rifugiarsi colà ove da poco era zampillata la lava.
Era stata una notte illuminata dalla brace incandescente, che a fiumi era discesa dall’altissima montagna.
“Non temete la morte e usate l’amore: l’amore può tutto!” intimarono gli anziani.
Il cratere tuonò ancora una volta, mentre l’esercito si avvicinava al popolo buono. Non c’era scampo, l’unica possibilità era davvero nascondersi nella bocca del vulcano.
“Avanti: tirate fuori il cuore!” continuarono a dire i savi.
Il popolo si fece coraggio. Mentre, armati di lance e con gli elmi abbassati, i soldati si avvicinavano, gl’innocenti si calarono con lunghe corde dentro alla bocca infuocata. L’amore era più forte però, davvero d’ogni cosa. Il vulcano si mise buono buono a scaldare la gente senza infierire. Tutti individuarono comodi giacigli ove trovarono scampo dall’esercito che passò senza trovare nessuno:… e la gente buona fu salva per sempre, credere nell’amore era stata l’arma più forte.
Le foreste delle montagne Toscane erano allora fitte e quasi invalicabili: era arduo attraversarle e rami e fronde impedivano spesso il passaggio, tra pruni e spine. Allora gli etruschi erano guidati dagli aristocratici che prendevano in mano le redini del popolo e s’incaricavano di guidare la gente oltre l’ostacolo:
“Basta farsi forza a vicenda!” dissero gli aruspici davanti ai fanciulli e si raccontò leggendo dal Grande Libro:
OLTRE LA MONTAGNA
C’era una volta una colossale montagna, solo oltre essa si sarebbero trovati la luce e il caldo, mentre rimanendo ai piedi del picco si pativa freddo e si stava al buio:
“E’ impossibile arrampicarsi per queste pareti e attraversare il bosco scuro!” dissero i pellegrini.
Le rocce erano scoscese, tra i massi stavano dritti alberi giganteschi che ostruivano il passaggio.
Qualcuno provò a farsi spazio tra i tronchi ma pareva impossibile poter valicare quel monte enorme e austero.
La gente sognava la luminosità della valle oltre la vetta, pensava a quel luogo che si raccontava pieno di vita, calore e fiori colorati.
“Ce la dobbiamo fare!” disse la guida del popolo. Si fece avanti e salì su un piccolo colle verde, per farsi scorgere e udire da ciascuno. Il popolo volse il viso verso l’oratore che sentenziò:
“Prendetevi per mano!”
Ognuno porse la mano al prossimo. Si creò una lunga catena, attraverso la quale si trasmettevano forza e sentimenti. Il cammino ebbe inizio. Non c’era tema d’inciampare né di scivolare, l’uno dava sostegno all’altro e al prossimo s’appoggiava. Fu attraversata la selva e valicata la montagna. La gente si ritrovò finalmente nel pascolo caldo e pieno di corolle sfumate d’ogni tinta. Era caldo, non si battevano più i denti e una luce che pareva imperitura illuminava il palcoscenico. Uomini, donne, anziani e bambini continuavano a tenersi per mano, quel gesto di stringere nel proprio palmo quello del vicino era davvero capace di offrire una forza magica.
Un animale assai amato dagli etruschi era il cavallo, esso veniva trattato con massimo amore e tanta cura. Le sinuose colline dell’Etruria, come i pascoli della Tosa, erano pieni di stalle e ricoveri per equini. Bai, sauri, morelli e grigi erano a miriadi sui verdi prati dell’Italia centrale. Il cavallo veniva usato per spostamenti, come compagno di viaggio e amico, ma famose erano soprattutto le corse che quasi ogni città teneva per ammirare i destrieri e i loro cavalieri misurarsi in agoni. Fantini coraggiosi, di solito a pelo, cavalcano bei soggetti potenti e percorrevano la pista nella piazza centrale o anche corse nelle vie del paese. Un lungo corteo cominciava dalla macchia mediterranea. Soldati con elmi dorati e ampi manti sulle spalle si muovevano di buon passo attraverso la vegetazione verdissima di quei luoghi, mentre si scorgevano mandrie di altri cavalli brucare l’erba. Innanzi al corteo stavano i portatori degli stendardi, ognuno riferito a uno dei soggetti partecipanti, poi ci si dirigeva verso la folla che attendeva la gara. C’erano anche corse comuni, tra le varie città etrusche, con grande partecipazione di pubblico. Chi vinceva era un eroe e tutti i bambini sognavano da grandi di divenire affermati cavalieri.
“Vorrei vincere e parlare d’amore!” disse Turlo ascoltando le narrazioni dei saggi relative alle corse.
“Bravo: devi sempre annunciare amore!” rispose uno degli aruspici e raccontò:
I CAVALIERI DELLA PACE
In quei tempi tutto era ghiaccio e il freddo rabbrividiva la Terra. Il castello bianco, interamente coperto di ghiaccioli e illuminato dal sole, svettava sulla grande montagna. In cima alla torre sedeva il re guardando dalla trifora e piangeva sul clima di quei tempi:
“E’ freddo, mancano la fratellanza e la pace che scaldano i cuori!” diceva con il volto coperto da una lunga barba che gli copriva gran parte del busto, così da celare la mano bianchissima che aveva disegnata sull’abito.
Era la mano della fratellanza. Il mondo era pieno di guerre. Si narrava del re del male, che a est combatteva e sottometteva tutti al suo potere, predicando cattiveria e malefici.
Più trascorrevano le albe e i tramonti e più i combattimenti aumentavano. Non c’era calore dei sentimenti tra le genti e tutto diveniva sempre più freddo.
Un giorno un esercito di cavalieri partì dai piedi della città. Il re guardava dalla sua finestra, sempre con la mano bianca coperta dalla barba, ma quello era un esercito nuovo: i cavalli si muovevano lievi mentre i fantini cantavano la pace e la fratellanza. Fu un evento straordinario, la barba del re sparì e la mano bianca si alzò sulla città. Era la mano dell’amicizia che unì tutti:
“Deponete le armi!” diceva una voce incantata.
Si scordarono le guerre per una solidarietà invincibile, il ghiaccio si sciolse e il freddo passò per fare posto a un’eterna primavera. Tutto si tinse di colori e il tepore del solicello fece cessare i brividi continui: la voglia di cantare la pace trionfarono su ogni cosa, mentre per sempre i cavalli e i cavalieri della gioia e dell’unione, continuarono a celebrare la fratellanza.
La civiltà etrusca ruotava principalmente intorno alla città, pur essendo importante anche la campagna ove si produceva. Il personaggio più importante della città era il lucumone. Tutti i bambini lo ammiravano, egli era il capo del popolo, era colui che si preoccupava di guidare il paese e cercava di portare la prosperità per tutti. Il lucumone aveva il compito di rendere la vita più agiata possibile, non doveva comportarsi con tirannia ma essere misericordioso e buono.
Ecco cosa raccontavano gli aruspici sulla collina degli olivi, di fronte al grande libro ingiallito dal tempo e dalla sapienza degli anziani:
L’USIGNOLO RE
Gli uccelli volavano nell’aere chiara sopra le montagne alla ricerca di un re.
Le cime spiccavano oltre le nuvole e i volatili erano stupendi, su quel mare bianchissimo, mentre cercavano di scorgere una guida che prendesse in mano le redini di ogni stormo e di ogni essere piumato:
“Vogliamo avere un re!” cantava la capinera.
Si cercava colui che avrebbe saputo portare gioia e pace in ciascun nido.
Sotto alle nuvole si vedevano gli uomini. Tra essi chi aveva il potere abusava del comando, sopraffaceva i deboli e lottava per avere il predominio.
Tra gli uccelli cantò lo stupendo usignolo. Le sue note erano gorgheggi soavi. Cantò l’amore e il bene tra gli esseri viventi. Tutti gli uccelli si abbassarono dal volo sotto all’albero presso il quale l’usignolo intonava le sue melodie:
“Il re non deve approfittare di ciò che può fare, egli deve indirizzare al bene e usare l’amore per guidare il popolo!”
Tutti gli uccelli si alzarono in volo e si misero a compiere piroette attorno all’usignolo:
“Ti eleggiamo re!” dicevano tutti al piccolo usignolo che venne incoronato. Egli era portatore di tregua e di fratellanza e la sua corona splendeva decorata da gemme e diamanti, mentre gli altri uccelli cantavano la pace. Le colline innevate erano nivee e stupende, le rocce sprizzavano luce di gioia, tutti levavano strofe e gorgheggi di felicità e solidarietà: mentre la primavera giungeva a colorare quel mondo di amici.
Belle erano le pitture etrusche, temi ricorrenti erano banchetti, danze, giochi e suonatori. Spesso tali decorazioni si facevano presso le tombe, cercando di ricreare dipinte, le scene del defunto in vita. Una volta, essendo i narratori di queste storie magici, da un dipinto rappresentante un guerriero, uscirono soldati in vera vita. Erano soldati speciali che avevano come spada il cuore e l’amore.
“Non combattete con le armi ma con la bontà!” dicevano i guerrieri e dal grande libro venne letta questa fiaba:
IL FUOCO DELL’AMORE
Era calato il buio nella città e faceva tanto freddo. La gente era divisa, non si era uniti e ognuno era egoista ed egocentrico. Mancavano la benevolenza e la coesione. In cielo cominciarono a volare orripilante uccelli neri, dal becco possente, vogliosi di spargere sangue. Il popolo non sapeva come fare:
“Solo la luce sconfiggerà questi rapaci neri!” dissero i saggi. Tutti fremevano e tremavano di terrore, mentre la volta azzurra si era fatta color cenere e il terreno tremava.
“Dobbiamo far luce!” si sgolavano i comandanti e i capi.
Per la prima volta tutta la gente si unì:
“Mettiamo insieme sentimenti e animo!” dicevano i maestri.
“Uniamoci e collaboriamo con tutto l’ardore!” erano uscite a cantare le donne.
La popolazione tutta venne ad aggregarsi. Ci si stringeva la mano e fu luce. Il fuoco dell’amore scaldò e illuminò tutto. Un raggio di solidarietà e fratellanza squarciò le tenebre. Ognuno strinse forte la mano del prossimo e d’incanto venne un giorno bello e fantastico. Gli uccelli neri si paravano gli occhi con le terribili ali munite di penne simili a lance e scapparono accecati dalla luce dei cuori.
Volarono via lontani per sempre… nei momenti oscuri solo il fuoco dell’amore può vincere il buio e il freddo.
D’allora in poi, mai più la gente fu divisa e si cominciò a vivere nella più grande armonia, con il sole che splendette sempre bello in cielo, senza che la notte sopraggiungesse mai.
Nell’Etruria meridionale c’era un posto chiamato ‘Acqua Rossa’, lì sorgevano case di etruschi, non troppo grandi ma confortevoli e calde, in quanto in esse regnavano l’amore e la pace. Si narrava di un’antica leggenda, parlando di un fiume color scarlatto intenso, rosso come l’amore. Questo torrente sapeva tutto e ammirava il popolo etrusco vivere in armonia e pace.
Ecco la fiaba narrata dagli aruspici sul colle degli olivi:
LA GUERRA
Scorreva un tempo, vicino alla costa, un fiume magico di color rosso amore. Questo corso d’acqua capiva tutto, conosceva ogni cosa degli uomini.
“So che avete bisogno di sfogare le tensioni, che amate il buon cibo e il sole; ho cognizione delle vostre esigenze e accetto tutto, ma una cosa non capisco: le guerre!”
Lontano si vedeva la torre nera del signore delle armi, da un occhio cattivo brillava un fuoco intenso di morte e di battaglie.
Paesi e città si scontravano e combattevano e il fiume rosso non capiva:
“Perché?” si domandava.
La gente che viveva presso l’acqua rossa si recava spesso sulle rive e ascoltava le parole di pace del fiume. Il popolo bevve quell’acqua magica e i giovani indossarono gli elmi per partire portando la voglia di urlare tregua.
Dalla torre nera si alzavano in volo rapaci maledetti che avevano in groppa guerrieri malefici, i quali lanciavano dardi di morte; i ragazzi però non temevano:
“Vogliamo un’era di pace!” diceva il loro capo e andavano avanti.
Si ritrovarono in campo aperto. I nemici cavalcavano mastodontici quattro zampe che avevano corni infuocati e denti avvelenati. I portatori di pace avevano con loro fiasche d’acqua rossa, la sparsero sul campo di battaglia e un’incantata forza entrò nel cuore di tutti, dei rapaci, dei guerrieri cattivi, degli animali e delle piante.
“Ecco che comincia l’era della pace!” cantavano i ragazzi con l’orgoglio e la gioia in cuore.
Tutto si ammantò di fiori e l’aria olezzava di fragranze ottime.
La guerra… l’unica cosa che nemmeno i più saggi e sapienti comprendono era finalmente finita.
Per i bambini etruschi era momento di gran gioia andare ad udire i narratori presso gli olivi. Il palcoscenico verde, della campagna dell’Italia Centrale era stupendo, si respirava il profumo delle piante, mentre si scorgevano i bianchi buoi maremmani andare verso la costa in cerca di beveraggio. Pareva d’essere davanti a un bel quadro agreste:
“Ci vuole armonia nel mondo! Non siate mai egoisti ma generosi!” disse il più anziano degli aruspici. Aveva il volto solcato da sagge rughe che parlavano della sua sapienza e un alone magico, di bianca luce, gli coronava la testa; narrò una favola sul cuore e la generosità:
COLUI CHE NON SAPEVA DONARE
Era tanto bello, in quell’epoca di difficoltà, con il freddo che veniva dai monti, scaldarsi il cuore con l’affetto e l’amicizia.
I ricchi si preoccupavano di donare ai poveri e chi poteva si levava di tasca i propri averi per aiutare i bisognosi ma il più dovizioso di tutti, il cattivo Buro, era egoista e non era disposto a dare nulla a nessuno:
“Andate via!” urlava mostrando i denti a chi lo invitava alla generosità.
Tra tutti, il giovane Mucio era il più dolce e tenero di cuore, avrebbe voluto far qualcosa per far comprendere al malvagio Buro la gioia di dare.
Mucio si recò quella mattina presso il pianoro. Sullo sfondo si vedeva la collina dei pascoli. Mentre tutto intorno era grigio per via dell’inverno, la collina pareva illuminata da un sole divino. Spiccava su tutto come immagine vivente di bontà e delicatezza. Mucio vide volare le anime di tutti coloro che in vita erano stati buoni e generosi.
Un angelo si fermò a mezz’aria e lo salutò.
“Ti vedo pensieroso!” disse l’essere celeste.
“Cosa posso fare per far capire a Buro quanto è brutto essere avari?” domandò il giovane.
Mucio pensava di dover ricorrere a urla e minacce per convincere il malvagio alla generosità, l’angelo invece rispose:
“Prendi parte della tua immensa bontà e donala a colui che non sa donare, sarà il regalo più sensato contro l’egoismo !”
Mucio corse verso il paese, riempì un forziere di mitezza e larghezza d’animo per recarla davanti al ricco palazzo di Buro. Persino gli imponenti mattoni della nobile abitazione s’inchinarono davanti a quelle virtù, Buro si affacciò e ringraziò del dono, divenendo anche lui più generoso e magnanimo.
Fu soprattutto alla fine del VII secolo a.C. che le città etrusche dominarono il Mediterraneo. Le attività mercantili, principalmente per via mare, fervevano, sia riguardo alle materie prima sia in relazione ai manufatti. I prodotti da smerciare all’estero erano famosi, soprattutto l’olio e il vino. A ogni vendemmia, la città di Turlo celebrava la raccolta dell’uva, si cantava e si suonava attorno ai tini ed ecco una fiaba raccontata in un bel settembre dorato, dai saggi della collina degli ulivi:
LA MUSICA DELL’ANIMA
Si voleva danzare, si cercava di porgere l’orecchio per riuscire a muovere passi a ritmi di bellissime melodie, ma i piedi della gente parevano bloccati: troppo malanimo e malvagità vivevano nei cuori di uomini, donne e bambini.
“Proverò con il mio zufolo magico!” intervenne Apuolo, un uomo carico d’anni e di sapienza. Era un contadino, un umile lavoratore della terra, egli non viveva pensando ai gioielli e alla ricchezza, ma al gusto di chinarsi a curare, con la schiena dolorante, piante e frutti.
“Sciocco!” rispondevano i compagni e continuavano a tentare di ballare. Si provarono vari strumenti, ma nulla pareva poter accompagnare i passi di danza.
L’arte di muovere il proprio corpo, manifestando messaggi del cuore, appariva una cosa lontana e irraggiungibile.
“Vogliamo ballare!” si diceva, tuttavia si continuava ad agire malamente e con cattiveria.
Apuolo si ritrovò al centro del paese e suonò il suo zufolo. Era uno strumento semplicissimo di terracotta e legno, però capace di creare soavi arie, che aiutavano i cuori ad agire in pace e fratellanza.
Appoggiò le labbra delicatamente allo zufolo e quando uscirono le prime note magiche, tutti cominciarono ad abbracciarsi, allontanando l’inimicizia dagli animi. L’aria iniziò a farsi dolce. Le note volavano per l’ambiente e la bontà vinse su tutto:
“E’ questa la musica dell’anima, quella che induce alla lealtà e al buon cuore!” si resero conto tutti. Ci si aggregò al suonatore incantato e fu per sempre gioia: era davvero la musica dell’anima quella che riusciva a far danzare la gente che si mise a ballare e a stringersi la mano… che festa, se ne parlò per anni e anni in tutta la regione.
Gli etruschi erano un popolo assai religioso. Grandiosi erano infatti i templi, con splendide scalinate d’ingresso e mura enormi. Gli edifici sacri spiccavano nella città e notevoli erano le tombe. Le case erano più modeste ma ognuno amava molto la propria abitazione. Intorno alla propria abitazione si scavava un fosso, presso il quale veniva eretto un recinto per creare qualcosa di simile a una struttura che contribuiva a sostenere la copertura della dimora. Tutte le case erano a un solo piano e ne esistevano di comuni. C’era una grande sala che veniva usata da tutti e poi, intorno, gli spazi per ogni nucleo. Le fondazioni veniva costruite con ciottoli di fiume e le mura erette con argilla, mattoni crudi e legno. Si entrava di solito da un corridoio stretto, poi si aveva accesso al vano principale .
“Invitate gli amici a casa!” dicevano i saggi per far stare insieme i ragazzi e venne raccontato:
PER GIOCARE BISOGNA STARE INSIEME
Un giorno regalarono a Empo due dadi coi bei numeri etruschi incisi sopra.
“Voglio giocare!” disse Empo tutto contento. Erano dadi stupendi, con effigiati in ogni faccia i bei numeri. Il bambino si chiuse in casa:
“Non permetterò a nessuno dei miei compagni di toccare i miei giochi e di entrare nella mia abitazione!” affermava.
Sprangò l’ingresso e rimase da solo.
Cominciò a toccare i dadi ma non provava piacere. Isolato da tutto il resto e nel buio creato dalla porta chiusa, era triste.
Sentì picchiettare all’uscio, era un uccellino magico.
Empo aprì e l’uccellino si librò sopra il tetto di tegole della sua dimora. Era un uccello sapiente e dolce:
“Perché hai chiuso la porta della tua casa?” chiese il tenero volatile al bimbo.
“Così ogni cosa cattiva rimane fuori!” rispose Empo.
“E’ bene chiudere la porta all’odio e all’invidia, ma devi spalancarla alla fratellanza !”
Empo spalancò l’uscio di legno e cominciò a chiamare i compagni e gli amici. Iniziarono a giocare coi dadi tutti insieme e fu un gran divertimento in spirito di concordia, felicità e fratellanza. Quei dadi servivano a poco se si chiudevano cuore, porte e sentimenti, alla compagnia del prossimo.
L’esercito etrusco era assai bello. I soldati cavalcavano stupendi cavalli, a pelo, i marciatori erano protetti da splendidi scudi istoriati e portavano schiniere di bronzo, mentre in testa recavano fantastici elmi. Nulla poterono i generosi etruschi contro Roma e famosa è la guerra dei cent’anni, coi romani che saccheggiarono Veio e le città vicine, mentre i soldati, con tanto cuore difendevano i territori.
Si narrava dell’epiche gesta degli eroi che cercavano di contrastare i nemici e si parlava di generosi atti. I giovani, sulla collina dell’olivo sognavano di essere importanti capi dell’esercito:
“Badate che il capo non è soltanto colui che comanda!” commentavano gli aruspici, ecco una favola legata al ruolo del comandante:
L’ACQUA DEL CORAGGIO
L’esercito marciava contro il nemico. I soldati avevano paura ma il comandante era ardito e saggio.
Le calzature dei guerrieri erano ormai logore, mentre il terreno sassoso diveniva fatto di sabbia:
“Stiamo entrando nel deserto e abbiamo paura!” diceva il plotone e non voleva procedere. Il sole batteva fortissimo sulle corazze di bronzo degli uomini d’armi. Il caldo era opprimente e il terrore assaliva ognuno.
“Io non desisto!” diceva il capo e continuava a esortare i suoi accoliti per incitarli a proseguire.
L’arsura era sempre più intensa. Il palcoscenico brullo e infelice, gli animi dei soldati a ogni passo più depressi.
Tra l’aria afosa e opprimente si levò una nuvola di polvere nivea e nacque un essere divino che offrì acqua al capitano:
“Bevi e rifocillati, placa la sete almeno tu!” disse lo spirito al comandante, tuttavia a lui non interessava la soddisfazione personale, ma il successo della spedizione; rispose allora:
“Io bevo solo se i miei uomini prenderanno coraggio !”
Lo spirito riempì una brocca d’acqua per il capo e aperse un libro magico sul quale lesse parole d’incitamento fatate. Tutti i soldati acquistarono per incanto coraggio, a ognuno passarono sete e paura e l’esercito poté proseguire.
Sempre in riferimento alle lotte e agli scontri, gli storici Erodoto e Strabone ci parlano delle battaglie navali contro i Greci, sia presso Rodi o le isole elleniche, ma soprattutto durante il VI secolo a.C. nel mare Sardo, il mare di casa. Si cercava di dominare le rotte commerciali. La flotta etrusca era la più famosa e molte furono le guerre con i greci scritte negli annali. I saggi, durante i loro racconti ai giovani sulla collina, parlavano dei marinai antichi, che con tanta generosità combattevano, uniti dallo spirito di difesa per la patria, da un sentimento di profonda coesione:
UNITI ANCHE NELLE DIFFICOLTA’
Era tanto bello il mare intorno all’isola e la nave procedeva sotto al sole, con il venticello piacevole che rinfrescava l’aria.
L’equipaggio andava fiero delle proprie gesta, si erano allontanati i nemici ma adesso si parlava di un’imminente guerra. Armati da nuove tecnologie, si avvicinavano i marinai greci. Si udirono i gabbiani gridare di terrore, mentre i rivali attaccavano, con innanzi alla prua istoriati i loro dèi.
“Iniziano le difficoltà e le sofferenze!” si lamentarono i marinai etruschi, impauriti e consci di dover patire presto pene e stenti.
“Dovremo lottare per giorni!” si diceva.
“Come faremo?” ci si chiedeva vicino al timoniere.
Era tremendo pensare a un duro periodo di tormento e tribolazione. Le onde cominciarono a schiaffeggiare la carena e la guerra iniziò. Per giorni e giorni, usando il famoso fuoco greco , gli ellenici portarono morti e patimenti, pareva la fine ma proprio nella difficoltà si riuscì a trovare le risorse nascoste, quelle che vengono fuori grazie alla coesione e all’unità.
“E’ proprio nei momenti difficili, quando sentiamo le nostre miserie e comprendiamo che abbiamo bisogno di unirci coi fratelli, che scopriamo la grandezza del gruppo!” si resero conto i marinai. Ognuno si strinse forte all’altro e si accomunarono le forze per riuscire a vincere sul mare Sardo e sconfiggere i greci. Tutto ha un senso: anche la sofferenza, quando serve a comprendere lo spirito di amore per il gruppo e la comunità.
Quella volta, mentre lentamente la natura faceva il suo corso e già i piccoli sognavano il giungere della primavera, gli aruspici accompagnarono i discepoli presso il consiglio degli anziani. Per gli etruschi avere la ricchezza degli anni, era gran virtù e accanto al lucumone si ascoltava la saggezza dovuta all’età. La classe dominante viveva presso belle ville, così che i membri del ceto gentilizio potessero esibire la loro ricchezza, ma bene fondamentale era considerata la sapienza, di modo che gli anziani fossero considerati portatori di un bagaglio di saperi assai prezioso.
“Ascoltate gli anziani!” dissero gli aruspici. Di lontano si vedevano i quartieri popolari, con tutte le loro botteghe e la gente che s’incontrava. Erano uomini poveri ma che vivevano con tanto sentimento e gli anziani raccontarono:
LA MUSICA DEL SENTIMENTO
Vet andava alla ricerca delle note magiche che rendevano gli animi sereni. Proprio quella sera, dopo il tramonto, nelle case doviziose si davano feste e si offrivano lauti banchetti.
“Andrò presso i luoghi dei bagordi, dove sicuramente si suonerà e canterà!” pensò Vet e s’incamminò sul selciato di mattoni. Mentre procedeva pensava a cosa avrebbe udito, tuttavia, una volta giunto alle grandi case, ove i facoltosi davano i festini, notò che questa gente pensava solo a sfoggiare anelli e begli abiti, senza aprire il proprio cuore. Vet porse l’orecchio ma non sentì che rumori e frastuoni.
Tristemente decise di far ritorno nelle vie umili del paese.
“Come sono deluso!” meditava. Quelle persone ricche, anziché dischiudere l’animo erano schiave della propria prosopopea e non potevano udire né cantar inni di gioia.
Mentre rincasava, Vet venne scosso da una soave musica. Curioso e con il petto che gli batteva per l’emozione, entrò nei quartieri poveri. Lì uomini, donne e bambini erano naturali e spontanei. Non c’erano pareti affrescate da preziosi dipinti ma semplici mura, però, era quella della gente umile la casa del cuore, ove ognuno offriva sé stesso.
“Che melodia eccezionale!” esclamava Vet esultando, poteva udire la musica dell’anima, quella che infervora e offre calore.
Ai tavoli dei ricchi spesso si banchettava e in giochi, a volte poco morali, si esibivano le belle ragazze etrusche, mostrando chiome ben curate e abiti doviziosi. I presenti si misuravano in gare e al vincitore spettava di scegliere la più bella del convito: ma qual era la più bella?
“Quella non troppo baldanzosa, umile e pura, non vestita di superbia!” commentarono i saggi sotto al cielo terso di quel dì invernale, illuminato dal sole mattutino. I piccoli, tra i quali Turlo era il più voglioso di ascoltare, si misero a sedere sull’erba ancora umida e porsero l’orecchio:
LA PIU’ BELLA
Maestri di eleganza, i mercanti, offrivano abiti alle donne della città:
“Ecco l’abito di superbia!” diceva il venditore dal banco centrale sulla piazza. Ragazze e donne mature si avvicinavano mirando quelle vesti. Erano tuniche finemente decorate, di tessuto assai pregiato:
“Potrete essere altere con quest’indumenti!” prometteva il mercante garantendo a ognuna la possibilità di apparire la più bella. Il commerciante mostrava vesti in svariate fogge, ora di lino, ora di tessuto raffinato, magari proveniente dall’oriente. Erano tutti oggetti di gran valore, per potersi mostrare ricche e vanagloriose. C’erano abiti viola o rossi, che spiccavano assai , vennero presentati mantelli e toghe.
“Sono stupendi!” diceva qualche donna.
Il mercante pregò alcune comari di provare gl’indumenti.
Molte si fecero avanti piene di boria e misero le vesti ricche e raffinate.
Solo l’umile Pionasta rimase coi suoi semplici abiti di modestia e semplicità.
Le donne si esibivano tutte, quando arrivarono i mariti:
“Eleggeremo la più bella!” dissero gli uomini.
Le donne pensavano a mostrare i loro abiti di superbia ma venne scelta proprio Pionasta, la più genuina e pura.
“A noi non piace l’ostentazione di superiorità!” dissero i mariti e sul volto di Pionasta fiorì un dolcissimo sorriso, mentre gli astanti vociavano entusiasti applaudendo la sua semplicità.
Assai importante, per la gente dell’Etruria e dintorni, era riuscire a sfruttare le ricchezze offerte dalle miniere. Nelle colline metalliffere maremmane c’era abbondante rame, nei monti della Tolfa, più a sud verso il Lazio, si trovavano anche zinco, piombo e soprattutto ferro, il Campigliese offriva altresì stagno e all’Isola d’Elba non mancava l’ematite. Lo sviluppo culturale, per imparare a estrarre le risorse e lavorarle, era assai legato a queste attività, che permise agli etruschi di crescere e progredire. Bisognava però lavorare di comune accordo e con rispetto per la natura. I saggi, sul colle degli ulivi cercavano allora d’iniziare i piccoli alla deferenza nei confronti dell’ambiente e dell’unità di gruppo.
“Fate sempre tutto con amore! L’amore è l’arma più potente!” dicevano per poi narrare favole come quella che segue:
LA VERA POTENZA
Il giovane Buno credeva nelle magie. Si ritrovò nel bosco, davanti alla miniera e sognava. Vedeva brillare pietre preziose ma il passaggio era stretto.
“Come farò a passare?” si domandò davanti a quel mondo di zaffiri colorati, diamanti e perle.
Sembrava il Paese di Cuccagna ma era impossibile attraversare lo stretto cunicolo.
“Proverò con il martello!” disse serrando i denti Buno. Impugnò una mazza di ferro assai grande e con tutta l’energia possibile cominciò a battere. Tuttavia era quella potenza che veniva fuori da sentimenti aggressivi e nulla poteva la violenza davanti alla natura.
D’un tratto un pipistrello intelligente si svegliò e uscì dal cunicolo: era un animale fatato e tanto saggio. Buno ebbe un po’ di ritrosità nel vedere quell’animale, poi, siccome anche i meno belli hanno il fascino del cuore , il pipistrello cominciò a parlare di amicizia e i due si avvicinarono.
“Non serve la cattiveria per aprirsi un varco! Chiama i tuoi amici e usate l’amore: l’amore è l’arma più capace, che permette di oltrepassare qualsiasi varco, chiuso da enormi sassi o da pietre gigantesche!” consigliò con saviezza l’animale.
Buno radunò tutti i suoi amici. Ognuno era amante di quei monti belli e imponenti. Si rispettava l’ambiente e si lavorava in concerto. La forza di quell’amore era davvero lo strumento più potente. Magicamente, tra i sassi si aprì un corridoio luminoso. La natura accettava l’ingresso di quei cuori buoni. Ogni fanciullo riempì la propria bisaccia di zaffiri e rubini per inchinarsi poi di fronte alla grandezza di madre Terra e tornare in paese, offrendo alla comunità tutto quanto di prezioso aveva trovato.
Gli etruschi furono soprattutto commercianti e artigiani, ma una folta manodopera, seppur non specializzata, si occupava di lavorare i campi. Da sottolineare i primi tentativi di migliorare le colture e gl’iniziali studi per ammendare e rendere il terreno più ricco. Il contadino era naturalmente in balìa del tempo, tuttavia s’insegnava ai giovani ad attendere, ad avere fiducia nel futuro senza mai disperare, la speranza infatti è alla base della vita, essa ci aiuta, ci conforta e spesso ci offre gli strumenti per guardare avanti e procedere. Mentre cominciava a giungere la bella stagione, ci s’intratteneva fino a mezzogiorno sul colle degli ulivi e intanto che gli agricoltori principiavano le loro opere di dissodamento, i saggi leggevano dal grande libro ingiallito dal tempo e dalla sapienza:
SOPRA LE NUVOLE
Il tempo scorreva incessante, tuttavia, mentre le genti attendevano la pioggia ad alimentare le piante e il sole a dare energia per la maturazione dei frutti, continuava la tempesta.
“Il vento soffia forte!” commentavano i coloni. Si cercava di porre riparo per proteggere le colture ma i rami si piegavano e i frutti cadevano dagli alberi.
Si lavorò tanto, fin quasi allo sfinimento.
“Ci arrendiamo!” cominciò a dire qualche contadino.
Molti riponevano tristemente le vanghe, avevano perso la speranza e si tiravano indietro rinunciando per quell’anno al raccolto.
Piano piano, ognuno seguì l’esempio dei primi rinunciatari. I campi furono sgombri dai lavoratori e sarebbe iniziata la carestia.
Quando tutto sembrava perduto e nessuno aveva più fiducia, giunse un suonatore incantato. Aveva in mano un flauto doppio, riccamente colorato e danzava scendendo dall’altura. Tosto la popolazione lo notò e si mise a osservarlo con stupore. Era un suonatore magico.
Le note parlavano di speranza e di attesa fiduciosa:
“Sopra le nuvole nere della tempesta, il cielo è chiaro!” disse il suonatore.
La gente osservò uno spiraglio aprirsi tra le nubi color dell’antracite. La magia si avverò. Il buio del cielo venne vinto dal sole. Dapprima cadde una lieve pioggerella vivificante, poi i raggi dell’astro del giorno iniziarono a far maturare i frutti. I contadini riacquistarono speranza:
“E’ vero, oltre le nuvole il cielo è sempre terso! Attendiamo con ottimismo!” dissero tutti. I frutti maturarono, in agosto le messi erano biondeggianti. Non cedere e continuare a lavorare con fede nel futuro, permise di evitare la carestia. Tutti avevano imparato: mai perdere la fiducia!
Il popolo etrusco era di solito caratterizzato dalla ricchezza dei raccolti, pertanto non mancava il cibo, pare infatti che gli uomini mostrassero spesso una certa prominenza nella pancia, sebbene già le donne pensassero assai alla linea mantenendosi snelle. Gli alimenti abbondantemente presenti erano farro, orzo, piselli, fave e altre leguminose… non mancavano veccia, ghiande e fichi . Gli allevamenti di pecore e capre offrivano latte e formaggi in quantità e nelle fattorie c’era tanta carne di maiale. I saggi cercavano tuttavia di parlare ai piccoli di sobrietà, affinché non abusassero mai e non si lasciassero prendere dalla gola, ma dicevano anche di generosità, per poter pensare a sfamare pure i miseri e i negletti. Ecco uno dei racconti relativi alla questione che venne narrato una volta a Turlo e ai suoi amici sulla collina degli olivi:
IL PIATTO CALDO
Vicino al fiume le donne avevano acceso il fuoco sotto alla pietra, per farla divenire rovente e cuocere gli alimenti:
“Cucineremo i cereali, farro e spelta!” dissero prima di tostarli sul macigno ardente. Alcune cuoche usavano il pestello e preparavano un gran pranzo per i benestanti del villaggio.
A forza di mangiare e mangiare tutti pensavano solo alla tavola e a sé stessi. Si era divenuti egoisti e nessuno si preoccupava di chi era senza una briciola di cibo. Nascosti nella selva stavano i miseri:
“Annusiamo i profumi!” dicevano, sognando di ristorarsi alla mensa dei più fortunati.
I ricchi si erano ormai lasciati prendere dall’ingordigia e ogni giorno si alzavano più avari e tirchi. Il cielo si arrabbiò a tale spettacolo di spilorceria. Mentre i miseri morivano di fame, al villaggio si banchettava.
A quattro palmenti c’era chi s’ingozzava e ingrassava senza mai riflettere su coloro che soffrivano per la mancanza di alimenti.
Piovve fango nero sopra le tavole imbandite. Tutto divenne melmoso e sozzo.
“Come faremo?!” dissero i ricchi ritrovandosi completamente impantanati.
A un certo punto i fanciulli seduti alla mensa, ebbero un moto d’animo positivo. Presero ciotole in quantità, per colmarle di pietanze calde e le portarono ove erano nascosti i poveri.
“Prendete e satollatevi!” invitavano sorridendo.
I miseri poterono sfamarsi.
Fu gran luce e un’acqua divina scese a lavare il fango.
“Un atto buono lava dal fango della cattiveria!” cominciarono a salmodiare i bambini e tutti compresero l’importanza di preoccuparsi del prossimo e del bisognoso.
In Etruria si allevava una razza di cavalli davvero prodigiosi. Si trattava di destrieri assai somiglianti ai purosangue arabi. Avevano fattezze stupende, erano armoniosi e agili ma al contempo robusti, con garretti potenti e figura proporzionata. Le corse in biga ebbero origine proprio con il popolo etrusco.
Per riuscire a creare un binomio tra uomo ed equino, occorreva amare con tutto il cuore il proprio quadrupede e lui avrebbe saputo ripagare con tanta generosità.
“Amate il vostro futuro cavallo!” dicevano gli anziani e i saggi ai giovani che sognavano da grandi di occuparsi dei destrieri, raccontavano poi favole sulla elevatezza d’animo dei cavalli e sulla loro nobiltà:
LA MAGIA DEL CAVALLO
Scorreva un torrente argentato lungo Valle Chiara. Era una conca abbellita da fiori gialli che si specchiavano nell’acqua e da rose selvatiche nascoste nella forra. Cerbiatti veloci giocavano tra i pruni e usignoli soavi cantavano splendide melodie.
“Sono tanto contenta!” diceva la Sorella Buona al suo cavallo. Era un destriero tanto intelligente, al punto che sapeva parlare:
“Oh mia padrona, mi fa piacere saperti lieta!” rispondeva e insieme percorrevano quell’angolo di paradiso terrestre.
Una sola cosa angustiava la ragazza, sua Sorella Cattiva.
Il cavallo, per fare un bel regalo alla sua amazzone, la condusse verso il picco luminoso. Salirono a lungo, percorrendo tornanti e inerpicandosi per la china. Il destriero moveva con forza i suoi potenti arti e le vene gli si gonfiavano per lo sforzo, ma veniva ripagato della fatica, dalla gioia di soddisfare la sua dolce e buona compagna.
Andarono sempre più su, ove si mirava lo splendore del creato. Era un luogo che ritemprava il cuore, si vedeva l’iride splendere sui cirri ovattati, la pianura sottostante era verde smeraldo, c’erano greggi candidi di pecore a pascolare in un tenero paesaggio che pareva dipinto dalla mano superba di un grande artista.
“Che incanto!” diceva commossa la sorella buona una volta giunta alla cima, nel mentre comparve la sorella cattiva, essa rubò il cavallo e se ne scappò. Il destriero sapeva però come fare. Cominciò a galoppare dentro alla selva e scese, scese all’infinito. Giunsero nel bosco nero. La sorella cattiva, che aveva rubato il cavallo per sfruttare le sue conoscenze dei luoghi più belli e ameni, si ritrovò nelle tenebre e nel freddo. Ogni cosa era buia; ella tremava. Suoni orripilanti si udivano stridere. La sorella cattiva cercò ti tapparsi le orecchie ma il cavallo nitrì forte e l’ammonì:
“Commettere atti infami e rubare a nulla serve!”
La sorella cattiva chiese perdono e si pentì:
“Oh cavallo generoso e buono, non lo farò mai più!”
Era veramente sincera e venne condotta a far ritorno dalla sorella mite. D’allora divennero entrambe buone e il destriero le portò a turno, ogni mattina, a scorgere i miracoli della Terra.
Gli aruspici, sulla collina degli olivi, sottolineavano ai fanciulli il fascino degli uccelli. Il gran sacerdote, tenendo in mano uno specchio artisticamente decorato da colombe in volo, faceva da richiamo luminoso. I volatili si abbassavano e si tentava di leggere le rivelazioni divinatorie dal muovere delle ali. A seconda delle traiettorie di anatre e germani, si trovavano indicazioni e auspici e gli etruschi conoscevano assai bene ogni specie di uccello.
“Gli uccelli stamattina parlano a voi ragazzi e vi esortano a vivere sempre con animo e coraggio!” disse il sacerdote con il cappello a punta e la barba, poi venne raccontata una fiaba:
LA LEGGENDA DELLO STORMO
Presso Tarquinia, anni e anni fa si parlava della leggenda degli aironi. Poilo non ci credeva. Gli avevano narrato della gioia di vivere di questi uccelli. C’era l’airone bianco, assai grande che parlava di candore. C’erano l’airone cinerino, colle piume argentate che narrava di amicizia e l’airone rosso il quale predicava l’amore.
“Gli uccelli non sanno parlare!” diceva Poilo.
Un giorno vide un uomo pacato e calmo che distendeva il suo mantello giallo. L’uomo cosparse il mantello di pane e chicchi di sementi. Uno stormo di aironi bianchi discese a cibarsi:
“Grazie!” dicevano gli uccelli.
Il capo stormo degli aironi scorse Poilo:
“Viva la vita!” proferì il volatile piroettando nell’aere con le gambe lunghe e il becco acuto e sottile ma robusto.
Poilo era stupefatto vedendo e udendo quell’animale capace di articolar verbo.
“Vivi con gioia!” affermò l’airone.
“Io non voglio vivere con felicità! Tutto mi pare oscuro e freddo!” rispose Poilo.
Allora l’airone chiamò gli altri uccelli. Insieme si misero a cantare in cerchio poi, presso i tanti alberi presenti in quel sito, si appollaiarono in cima a tronchi alti e robusti, per rivolgersi al ragazzo. Ognuno cominciò a parlare rivolto a Piolo:
“Ci vogliono coraggio e fiducia nella vita per volare e volare!” disse uno.
“Serve ardimento!” aggiunse un altro.
Tra i magici uccelli si udì dire:
“Andrai lontano con la voglia di fare, prova a cercare l’animo e ti alzerai con noi in volo!”
Poilo raccolse tutte le sue forze e si alzò insieme allo stormo.
“Andrai lontano se cercherai la forza nel tuo cuore!” concluse il capo stormo.
Era vero: con la fiducia nella vita si poteva persino volare.
Gli etruschi erano religiosissimi e i sacerdoti assai ascoltati:
“Combattete le forze oscure e invocate gli dèi buoni!” dicevano i saggi sul colle degli olivi ai giovani. Monumenti, sculture e specchi incisi, venivano prodotti per invocare le divinità. Si pregavano gli spiriti protettori, si commemoravano gli antenati presso le stupende tombe.
“Attenti agli spiriti che portano alle tenebre, quelli cattivi, cercate le vie dell’amore!” dicevano i sacerdoti che erano soliti raccontare favole come quella che segue:
LA LUCE DELL’AMORE
C’era una volta un bel cane lupo, anche lui figlio del Creatore. Gli uomini lo avevano tolto alla foresta e lo avevano legato alla slitta. Sul ghiaccio bianchissimo il cane lupo doveva fare da capo muta e condurre il mezzo sulle pianure fredde.
Il dio della cattiveria si presentò la notte al quattro zampe:
“Divieni cattivo e avrai la forza per continuare il tuo lavoro!” il cane stava per affidarsi a quello spirito malvagio.
Egli si era sempre comportato bene coi suoi compagni di muta. Esortava e dava incitamenti con amore agli altri, infondeva spirito di collaborazione e unità.
“Devi divenire famelico e cattivo!” gli disse il dio del male.
L’animale aveva un gran cuore ma stava per lasciarsi dissuadere dal percorrere i saggi insegnamenti dei suoi avi, per seguire la strada cattiva. Una voce più dolce gli diceva però:
“Io sono il dio del bene, non porgere l’orecchio alla malvagità e segui l’amore!”
Il cane era davvero indeciso. Doveva scegliere tra il bene e il male e rimase a pensare tutta la notte. L’alba, nel cielo sopra i ghiacci era luminosissima, il dio cattivo tuttavia era stato convincente e il capo muta decise di darsi a lui:
“Sarò cattivo e spregevole!” disse. Di colpo tutto divenne nero e freddissimo. Affidarsi al male porta solo al buio. Si spensero i raggi luminosi dell’astro del giorno che avevano reso tutto grande e bello.
“Aiuto!” cominciò a urlare il cane lupo, quando tornò a parlargli la divinità gentile e cortese.
“Tira fuori l’amore!” sentì dire dall’alto il cane e cercò nuovamente tutta la sua bontà, per offrire amicizia ai compagni. Sulla pianura tutto fu nuovamente luminoso e non si tremava più dal gelo. Il cane lupo partì a capo del viaggio e poté lavorare in gran letizia e con soddisfazione.
Mai doveva cadere nell’oblio il ricordo degli antenati, così le tombe erano costruzioni importantissime e molteplici i riti che ivi si compivano. I saggi guidarono i ragazzi sottoterra, nella necropoli. Erano preparati banchetti in onore degli ultimi defunti, sotto fregi artistici, presso le volte del soffitto, ardevano delle lampade, ma la luce era poca.
“E’ buio!” dicevano i bambini.
Piano piano si cominciò a pregare per le anime pure e buone e di colpo venne gran luce, mentre gli auguri raccontarono:
NELE TENEBRE
Una volta, presso l’alta valle, venne d’un tratto gran buio. Erano le tenebre dell’odio e della cattiveria. Tutto sprofondò e la gente cadde sempre più in basso vagando nel vuoto: giù, giù, sempre più giù.
Alcuni si aggrappavano alle rocce, altri scivolavano sulle pareti che si erano fatte di ghiaccio, era impossibile resistere.
Ombre sinistre spuntavano dalle rocce sottolineando l’oscurità
del male.
“Aiuto!” urlavano donne e uomini ma tutti continuavano nell’aborrire il prossimo e non ci si aiutava.
In una voragine infinita, i corpi precipitavano inghiottiti dalla terra. L’ambiente ogni metro si faceva più tetro e la situazione più sconvolgente: era buio pesto.
I bambini furono i primi a reagire. Alcuni tesero le mani ai compagni per darsi sostegno a vicenda.
Nelle tenebre dell’odio, una mano tesa può fare gran luce. I palmi spalancati dei piccoli, in atto di soccorso ai compagni, vennero illuminati da raggi potenti e invincibili, erano le luci della bontà. Venne tutto rischiarato. I corpi cessarono di precipitare.
“Viva l’amore!” gridavano i bimbi. Si era capito come fare: bastava amare. L’odio venne vinto e la pace guidò il popolo a risalire da quel dirupo terribile. Mille arcobaleni colorati splendettero forte, le genti cadute nel baratro si rialzarono e ognuno tornò nel paese ameno della valle, con in cuore sentimenti nuovi di amicizia e unione. La valle irraggiò luce per sempre, nell’accordo e nell’armonia, con la vita allietata dalle tinte dei fiori e dal calore del bene, in una giornata eterna di fratellanza e amicizia reciproca.
Quella mattina c’era una sorpresa, sul colle degli olivi, per tutti i bambini. I saggi recavano in una grande cesta decine di bei sandali di legno, con suole leggere e lacci color dell’oro. Erano magnifici, ma soprattutto erano metafora di cammino:
“La vita è un viaggio, un lungo viaggio!” affermavano seri gli auguri. I piccoli ascoltavano e comprendevano l’importanza del pellegrinaggio dell’uomo sulla Terra.
“Non errate invano!” disse il gran sacerdote che poi lesse dall’importante volume delle fiabe:
LE CALZATURE INTELLIGENTI
In un luogo magico viveva Cabo, circondato da vasi di fiori colorati e da profumi soavi. Era un sito ameno e tanto gaio, in completo connubio con la natura.
Cabo provava felicità nel godere dei colori e della vicinanza dei suoi amici e dei tanti animali che scorrazzavano nel giardino. Tutto era incantato. Bastava andare in cucina e si trovavano pentole e ciotole che parlavano. Le sedie pure, erano capaci di articolar verbo. Quel giorno Cabo si mise a parlare con i suoi abiti prima di vestirsi.
Per prima Cabo salutò la tunica.
“Ciao tunica!” diss’egli, con tanta attenzione a disporre quella veste con le giuste pieghettature. Cabo curava assai l’eleganza. Fu poi il momento della Tebenna, un manto direttamente padre della toga romana.
“Buongiorno!” disse l’elegante manto. I due parlarono e poi Cabo lo indossò. Per il capo c’era un berretto simile a una cupola e tutto ricamato, chiamato Tutulus, anch’esso magico e capace di proferir parola.
“Sei assai raffinato!” disse il berretto al suo padrone, ma non bisognava solo pensare all’eleganza, tanta attenzione c’era per le calzature. Nello scaffale Cabo aveva stivaletti e le famose ciocie per scalare le montagne, tuttavia l’uomo decise d’indossare i suoi sandali magici.
” Dove andremo?” chiese Cabo ai sandali ed essi risposero:
“Non affannarti a correre per strade senza méta. Andremo verso la vetta dei giusti che ci darà beatitudine e soddisfazione, non sarà sciocco sgambettare, ma cammino di vita!” e Cabo capì che con quelle magiche calzature poteva percorrere la strada dell’esistenza inseguendo la rettitudine e l’onestà.
Turlo e i suoi amici assistevano allo spettacolo degli artigiani che lavoravano i metalli nelle fornaci. I forni fusori erano alimentati da carbone e si creavano medaglie, fibule, monete, piccole sculture, elmi, brocche e tante altre cose. Gli etruschi erano straordinariamente abili nello svolgere in maniera artistica il mestiere di fabbri. Turlo vide confermare la stima che aveva per quei lavoratori, osservando modellare bronzo, rame, piombo, ferro e perfino oro. Questi fabbri erano rinomati in tutto il mondo allora conosciuto e provenivano richieste da ogni territorio. Quella mattina, un guerriero esotico voleva uno scudo tutto d’oro, con istoriate scene di battaglie tempestate di pietre pregiate. Era una eccessiva esibizione della propria dovizia e gli auguri narrarono una fiaba sulla temperanza e la sobrietà, con l’intento di educare i piccoli a non esagerare mai:
VOGLIO TROPPO
Nel regno degli dèi, molto importante era la divinità Cautha, sorella del sole e che decideva l’alba e dava inizio alle giornate.
Ella era assai attiva e grazie al suo intervento, in cielo, suo fratello si alzava illuminando tutto:
“Voglio che tu sia più luminoso!” disse al Sole Cautha.
“Quanto, più luminoso?” chiese l’astro del giorno.
“Troppo!” rispose la sorella che non aveva giudizio né equilibrio, lei non sapeva misurarsi e voleva sempre troppo di tutto.
All’alba, così, venne tutto illuminato con raggi cocenti. C’erano davvero troppa luce e troppo calore. I virgulti teneri e i fiori dolci hanno bisogno invece del lieve tepore dell’aurora e non poterono aprirsi al dì.
Intervenne allora Fufluns, dea della Terra che spiegò a Cautha:
“Troppa distanza e troppa prossimità impediscono la vista; troppa luce abbaglia e troppo buio non fa vedere; troppo rumore assorda e troppo poco non si sente !”
Cautha aveva compreso:
“Non voglio più troppo, fratello Sole!” disse e finalmente da quel giorno la nascita a oriente della palla rossa, tornò a essere delicata e leggera, affinché ogni virgulto potesse godere dell’aria frizzante della mattina.
Il sole si levò in alto, imporporò tutto e screziature rosa e rosso tenue dettero vita a un nuovo splendido dì, sottolineato dalla sobrietà e dalla moderazione.
Nel forno dove venivano fusi i metalli ardeva una potente fiamma. Tutto era incandescente e il calore davvero eccezionale. Si vedevano gli artigiani tanto vicini a quella fornace, con i tratti sfocati per la temperatura elevata che creava strane rarefazioni nell’aria per via del bollore.
“Bisogna stare attenti alla fiamma!” dissero gli auguri, ma si riferivano a scottature metaforiche e raccontarono:
LA FIAMMA DEL MALE
Tanto bello era il bosco magico, ove colori fantastici rendevano il palcoscenico incantato e si vedevano gnomi e fate scorrazzare alla ricerca degli amici animali, da curare e con i quali giocare.
“Abbracciamoci!” diceva allegro il re degli gnomi con la sua corona sormontata da un diadema azzurro scintillante.
Marmotte, scoiattoli, gufi e lepri lo festeggiavano e lui guidava un trenino di esseri che danzavano intorno al grande albero della pace.
Un brutto giorno comparvero gli uomini, brandivano torce accese e davano fuoco a tutto. La foresta divenne fiamma. Il rogo si spandeva dappertutto, mentre malvagi stregoni facevano risuonare tam tam e gli animali fuggivano impauriti.
Ardevano tronchi e foglie secche. Tutto divampava ma furono le fiamme stesse a ritorcersi contro gli uomini. Mentre essi urlavano con la voglia di distruggere, la fiamma più grande si levò altissima. Si vedevano folgori accecanti rosse e gialle. Emerse una figura bianca e pura, dal volto severo che disse:
“Con il fuoco della cattiveria ci si scotta!” e tutti gli esseri umani cominciarono a bruciarsi mani e membra.
“Spengete questo fuoco!” ordinava lo stregone. S’iniziò a battere coi piedi sulle vampe. Le lingue infuocate piano piano si placarono. Tornò la calma e gli animali si rifecero avanti a cercare le loro case distrutte.
“Vi aiuteremo noi, non vogliamo più scottarci al fuoco della cattiveria!” dicevano gli uomini che in quell’epoca lontana, compresero una delle chiavi dell’esistenza: il male è pericoloso soprattutto per chi lo compie.
…E si conclude qui questa nostra narrazione di quanto avveniva nella zona italica che protendeva, principalmente in Etruria, ma che poi si espanse sino a Mantova a nord e oltre Capua a sud e nella quale vissero gli etruschi. Furono popolo dedito sia al commercio che all’estrazione di minerali, vero esempio d’industriosità e che dal XI secolo a.C. persistette sino a essere inglobato dalla civiltà romana nel 396 a.C.. Per tutti questi anni probabilmente, sul colle degli ulivi o in siti simili, i saggi narrarono di continuo fiabe ai giovani.
Grazie a tutti dal vostro scrivano
Roberto Bianchi


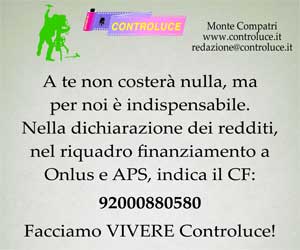


















































































































































































Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento