Le fiabe dell’età della pietra
Diecimila anni fa, nei fondovalle dell’Italia settentrionale, alla fine dell’ultima glaciazione, vivevano tribù di uomini che basavano la loro vita sull’unione, la comunità di gruppo, la caccia e la raccolta. I villaggi si spostavano, si viveva infatti in pianura nei periodi più freddi e si saliva fino a duemila metri durante l’estate. Quando stavano nel pianoro, i componenti il gruppo umano della nostra piccola Graz, vivevano presso caverne rivestite di legno e con grandi pietre incassate a dividere la casa di una famiglia dall’altra. Ogni gruppo familiare aveva la propria privacy, ma c’era anche tanta comunione. Graz aveva ormai sei anni e da poco aveva smesso di essere allattata, ma ancora amava recarsi nella grande grotta, dove tutte le mamme della tribù, a turno, tenevano al seno i piccoli, anche scambiandoseli tra loro e provvedendo a far poppare i fanciulli che avevano la loro madre impossibilitata dall’allattarli. La grande grotta era rivestita di calcare bianco, nelle zone più umide cresceva del bel muschio simile a velluto verde, c’era un odore strano, di fresco che Graz amava tanto. Mentre i piccoli suggevano avidamente il latte, una delle donne anziane della tribù raccontava sempre una fiaba e per questo molti dei bimbi che ormai non venivano più allattati, andavano ad ascoltare quanto si narrava. Graz quella mattina stava seduta su un giaciglio di paglia e gustava una ciotola di legumi schiacciata e tritata.
“Che buona!” disse Graz coi suoi occhi neri. Accanto a lei c’era il suo cane, gli uomini infatti avevano già da tempo addomesticato i quattrozampe che aiutavano i giovani nella caccia e facevano la guardia durante la notte. Era quello il periodo che precedeva l’inverno, la tribù viveva quindi nella zona meno fredda, soprattutto per seguire le prede e sfruttare quanto offriva l’ambiente. Si raccoglievano bacche e frutti e questo ruolo spettava proprio alle donne e ai bambini dell’età di Graz. Mentre fuori gli uomini stavano preparando steccati per dirigere i ‘leptobus’, dei grossi bovini, verso un recinto e in mano tenevano archi potenti, nella grotta Scira, la più anziana e saggia della tribù narrò una favola sulla creazione:
IL MOTORE DELLA VITA
Il creatore aveva messo in cielo sia la luna che il sole. Di giorno l’astro della Terra scaldava e dava energia, di notte il bel satellite color argento illuminava le ore buie.
“Manca però qualcosa!” disse il creatore osservando la sua opera. C’erano già il vento e l’acqua, i mari e le montagne, ma il creatore aveva proprio ragione, doveva studiare qualcosa che portasse davvero la vita nel pianeta.
Lavorò assai per giorni e giorni finché arrivò alla conclusione che doveva dare uno spirito vitale a quel palcoscenico.
Provò col fulmine ma a poco servì.
“Utilizzerò l’alta marea!” ma neanche il crescere dell’oceano dette alcun frutto.
Usò il terremoto, la neve e la grandine ma senza successo.
Ci vollero millenni ed ere, fino a che pensò di usare l’amore.
Chiamò sua moglie:
“Aiutami tu!” disse alla bellissima donna, tanto buona e cara.
La donna aveva in cuore tanti stupendi sentimenti. Si lavò con acqua purificante e mangiò erbe magiche, poi salì sul monte più alto. Mise tutta sé stessa in quegli atti, i suoi sogni erano quelli di compiere tutto col massimo impegno.
Toccò con mani materne il globo terrestre. L’amore colorò tutto di fiori dalle mille tinte e presto nacque la vita. Milioni di animali cominciarono a correre per foreste e campi.
“Tutto vive!” esultava lieto il buon creatore.
Con il suo bene e quello della moglie, avevano dato vera vitalità alla Terra che d’allora fu popolata da miliardi di esseri, tra i quali un giorno nacque anche il primo uomo che diede vita alla nostra specie. Vi furono così tanti discendenti che mai devono dimenticare che tutto ciò che esiste è nato dall’amore.
In quell’epoca della Terra la temperatura, dopo il gran freddo precedente si stava innalzando, i ghiacci si andavano sciogliendo e il livello dei mari cresceva. Nel villaggio i compiti erano ben suddivisi, molti erano i pescatori.
Graz ammirava ogni mattina le canoe intagliate in tronchi di legno, partire per procurare cibo.
Il suo sguardo in quell’alba, era fisso su coloro che si accingevano a prendere il largo. L’oceano era mosso e la fanciulla provava tanta considerazione per quei prodi:
“Che corpi muscolosi!” pensava osservando i bicipiti dei ragazzi sulle piccole imbarcazioni.
Divenendo il clima più temperato, gli animali si spostavano a seconda della variazione della temperatura. Si trasferivano cavalli e bisonti e anche i cacciatori si avventuravano all’aurora per svolgere la loro ricerca. Pure guardando gli arcieri, Graz osservava i loro corpi scultorei. Le donne e i giovanissimi invece si limitavano a raccogliere frutta e piante commestibili.
“Che differenza rispetto ai muscoli degli uomini!” disse Graz quella mattina nella grotta delle fiabe, allora una donna le narrò:
LE GAMBE E IL CUORE
C’era una volta un bambino con le gambe corte che viveva piangendo per la propria sfortuna:
“I miei compagni corrono veloci e io rimango indietro!”
Già i coetanei erano capaci di correre dietro a un ghiottone e cacciarlo, mentre lui rimaneva a gran distanza. Era piccolo e lento, ma aveva un’eccezionale caratteristica: era dotato di gran cuore.
Un giorno particolarmente ventoso, la sciamana della tribù si ammalò.
“Occorre giungere al lato opposto del bosco e raccogliere la pilosella!” disse uno dei saggi del gruppo.
La pilosella era un piccolo fiore giallo che serviva per scacciare la febbre.
I ragazzi con le gambe lunghe erano indecisi. Le loro falcate avrebbero percorso il difficile tragitto in breve tempo, ma mancava loro l’ardimento.
“Partirò io!” disse il bambino dalle gambe corte. Mise tutto il cuore in quell’impresa. Sudava e aveva la bocca secca ma non si fermava. Si bucava con le spine e tuttavia insisteva. Giunse al lato del bosco dove nasceva la pianta febbrifuga e ne raccolse molta. Grazie al suo animo generoso, nonostante le gambe corte fu proprio lui che riuscì a portare in tempo la medicina per salvare la sciamana. Lo portarono in trionfo e fu per lui gran festa. Il bambino non pensò mai più alle gambe corte.
Ormai molti erano i villaggi che detenevano il fuoco, rintracciato da secoli e secoli nell’oriente del pianeta. La tribù di Graz era capace persino di accenderlo volontariamente, per mezzo di un metodo a percussione. L’addetto al fuoco possedeva sassi di pirite di ferro e li sfruttava battendoli vicino a un’esca di paglia secca, per poter così avere la fiamma, utile a cuocere i cibi, a scaldarli, rendere meno faticoso il lavoro di escavazione del legno nella costruzione delle piroghe, ammorbidire ciò che era troppo duro, fare segnalazioni a distanza, tenere lontane le belve feroci.
A Graz piaceva tanto il fuoco. Si raccontava che nell’epoca precedente, il paleolitico, il fuoco veniva custodito giorno e notte dai villaggi.
“Tra le cose che più amo ci sono il fuoco e gli adornamenti delle donne!” diceva sempre la piccola Graz.
Le donne infatti portavano ossi e conchiglie per adornarsi, ma in una giornata d’autunno, nella grotta delle fiabe venne raccontata una fiaba:
I FALSI IDOLI
Tanti e tanti anni fa il capo tribù di un villaggio che viveva presso delle palafitte, riunì il suo popolo e domandò:
“Cosa abbiamo di più prezioso?”
La tribù viveva ripartendo equamente ciò che aveva cacciato e raccolto, c’era grande armonia, ma troppa importanza si dava alla superficialità, come all’abbigliamento sfarzoso e alle conchiglie al collo delle donne.
“E’ importante avere vesti di camoscio belle ed eleganti!” disse Giob.
“Io ringrazio sempre gli spiriti che ci consentono di adornare le nostre donne con pietre belle e colorate!” aggiunse Molog.
Tutti pensavano che la cosa più preziosa consistesse nell’esteriorità, senza invece riflettere sull’armonia di gruppo e la fratellanza che rendeva la comunità una grande famiglia.
Il capo tribù disse:
“Dobbiamo invece apprezzare soprattutto la nostra unione, la generosità di ognuno e la solidarietà! Provate a immaginare a cosa servirebbero pelli preziose e conchiglie variopinte se tra noi mancasse l’affiatamento, non ci sarebbe da mangiare per tutti, né avremmo a disposizione l’acqua che le donne raccolgono al torrente, come non ci sarebbe per ognuno una rassicurante caverna per dormire!”
Molog e Giob battevano freneticamente i piedi, in segno di nervosismo, avevano fatto una brutta figura a parlare di suppellettili e adornamenti e allora dissero:
“E’ vero, ci sono cose assai più preziose di conchiglie e pelli di camoscio!”
…E da quel giorno importante di assemblea attorno al capo tribù, che era il più generoso e buono di tutti, il popolo imparò ad apprezzare soprattutto l’amore del gruppo, grazie al quale nelle ere si imparò a convivere, a spartire, a superare le tante difficoltà dell’esistenza.
Le difficili condizioni di vita andavano superate anche per mezzo degli strumenti. L’uomo preistorico aveva già da tempo imparato a produrre asce, punteruoli e raschiatoi in osso o selce. Con manici lavorati da artigiani c’erano seghe di pietra e lance con particolari forme. Normale era l’uso di aghi di osso o corno che permettevano così di cucire le pelli. Nel mesolitico, specialmente per i pescatori, fu importantissima la realizzazione di ami e reti.
A colpire l’animo della piccola bambina Graz c’erano comunque le armi da guerra. Nella sua epoca i giovani di ogni tribù avevano il compito di viaggiare assai, peregrinare, scoprire nuove terre e conoscere altre genti. Spesso però tra chi s’incontrava scoppiavano battaglie. I vecchi tuttavia narravano di comportarsi sempre con giustizia e correttezza, lealtà e onestà. Ecco cosa si raccontò un giorno nella grotta delle fiabe:
LA RUPE
Un dì venne il giorno del giudizio. Tutti erano pronti a essere esaminati dal Grande Spirito che avrebbe deciso la sentenza. Uomini e donne erano tremanti. Le stelle brillavano nel firmamento, a indicare l’inizio della nuova era. Ognuno era diretto alla rupe centrale, dove stava colui che doveva esprimere la propria decisione. Alberi frondosi costeggiavano lunghi viali che salivano verso l’alto.
“Io sono stato imperatore e sarò giudicato in base a ciò!” diceva il re dei re.
Si vantavano anche i capi, i combattenti e gli arditi.
Moltissimi erano i prodi che pensavano, grazie alla loro forza di esser valutati positivamente.
Il Grande Spirito aveva due grandi occhi pieni di saggezza e guardava la processione di gente che si dirigeva al giudizio.
Philo si sentiva misero in quanto mai aveva combattuto né fatto guerre, lui aveva solo un grande cuore e non pensava di ottenere un buon voto.
Tra tutti fu il più generoso, faceva spazio agli zoppi e aiutava gli anziani.
Il Grande Spirito, che tutto vedeva e tutto sapeva, lo chiamò al trono. Una miriade di angeli e fatine volavano intorno rendendo l’aere multicolore.
Philo sentì il cuore battergli in petto.
Il Grande Spirito sorrise e disse:
“Philo sarà giudicato con tanto amore: ci saranno grazia per chi ha avuto grazia e misericordia per chi ha avuto misericordia!”
Così non furono premiati guerrieri e prodi, ma i buoni e i generosi.
Assai interessante, tra le grotte degli artigiani, era per la piccola Graz assistere ai lavori di coloro che modellavano l’argilla. Erano soprattutto le donne a svolgere tale attività. Davanti alla grotta c’era un riparo di rami, foglie e pelli, per proteggersi, ora dal sole, ora dalla pioggia. Graz andava spesso sotto questo riparo a mirare i lavoratori e soprattutto le lavoratrici. Erano abili e la loro tecnica già progredita, costruivano cucchiai, ciotole e vasi. L’argilla era materiale del quale si poteva disporre in quantità quasi illimitata , con essa si usava anche costruire muretti di protezione, argini per la piena del fiume, ma più di ogni altra cosa se ne faceva oggetti.
Si formava una palla di argilla, poi la si comprimeva con leggerezza al centro e per mezzo di un’asticella di legno con all’apice una pietra, si cominciava a modellare un vaso o un recipiente. Una volta ottenuta la forma voluta si coceva in forno o a fuoco aperto. Graz stette tutta la mattina a vedere queste opere, poi si diresse alla grotta delle fiabe. Mentre camminava pensava a tutto l’amore che coloro che lavoravano l’argilla mettevano nella loro opera. Agivano con la voglia di costruire qualcosa di utile per la comunità. Nella grotta, una delle donne spiegò alla piccola Graz che ascoltava attenta quel discorrere di esperienze:
“Senza amore non si può fare nulla, serve amore in ogni atto e in ogni cosa!” quindi la donna si mise in ginocchio davanti ai fanciulli, che in cerchio l’ascoltarono, anche loro a terra ma con le gambe incrociate, mentre lei narrò:
LA VECCHIA CHE AVEVA SEMPRE ODIATO
C’era una volta una vecchia che per tutta la vita aveva sempre odiato e mai amato. Si dirigeva ai margini della foresta, quando vide uno stagno, ricco di narcisi che gialli si specchiavano nell’acqua, mentre le ranocchie saltavano allegre di ninfea in ninfea e tante farfalle volavano verso il roseto selvatico che stava di rimpetto alla piccola conca d’acqua.
“Che bel paesaggio!” disse la vecchia e si avvicinò all’acqua. Si vide riflessa sulla superficie di liquido chiaro, dal quale qua e là spuntavano delle canne. Si guardò e lei, che mai aveva amato ma solo odiato, si vide essere bruttissima, coi capelli color cenere e piena di rughe, con gli occhi ingialliti e i denti neri.
“Sono l’unica cosa brutta di questo palcoscenico!” si lamentò l’anzianissima donna.
Una farfalla provò a volarle vicino.
“Ti odio!” disse la donna scacciandola movendo di scatto le mani, ma la farfalla gialla e rossa si posò su un fiore e le disse:
“Sei così brutta perché non hai mai amato, senza amore si è orribili!”
La donna si rilassò, provò a cercare nel suo cuore disponibilità e amore per il prossimo. Accolse la farfalla, cominciò a cantare con l’usignolo che stava sui rami del salice vicino alla sponda dello stagno e cominciò a provare tanto amore per tutti gli altri. Di colpo le rughe sparirono, gli occhi persero il giallo e divennero di un bel colore iridescente, i capelli non erano opachi bensì luminosi e il nero sparì dai denti.
Si specchiò nuovamente e adesso che non odiava più ma aveva imparato a usare l’amore in tutti i suoi atti, era divenuta bellissima.
A decidere le migrazioni erano soprattutto i cacciatori. In quel periodo si sarebbe rimasti in pianura. Le donne caricavano i loro piccoli sulle spalle e andavano in cerca di bacche succulente e drupe dolci. La vita era dura e piena di rischi, ma l’unità di gruppo dava tanta forza. Graz camminava vicina alle mamme che intanto cantavano allo spirito della luce. Il viso del sole era bello in quel cielo autunnale, mentre la campagna ingialliva e pareva tutto screziato da tinte ora ocra, ora color del rame.
La preistoria andava finendo e nel periodo intermedio dell’età della pietra, gli uomini imparavano a costruire abitazioni e ricoveri sempre più confortevoli. Si parlava, mentre si continuava a raccogliere, nelle ceste preparate dagli artigiani, dei popoli del fiume, che per tenere lontane le belve abitavano su palafitte, c’era chi aveva sentito narrare di capanne o di villaggi con già le pareti fatte d’argilla, si discuteva sulle case.
Nella grotta delle fiabe venne narrato:
LA RICCHEZZA
Faceva un gran freddo per tutto il popolo della valle. La montagna che troneggiava la conca stagliandosi verso l’aere, aveva ormai la cima coperta di neve.
“Bisogna costruire case più calde!” diceva lo stregone, invitando la gente a mettere in comune le proprie cose per erigere e dare vita a luoghi accoglienti.
Molti si vantavano. Avevano gran ricchezza nelle loro capanne. C’era chi possedeva oro e chi argento. I poveri si vergognavano, loro avevano ben poche cose da offrire.
Il più povero di tutti era Pet. Lui viveva senza pensare ad accumulare, ma solo dedicandosi alla caccia per sfamare i giovani del villaggio, aveva però animo ardito e non si lasciò intimorire dalle ricchezze degli agiati.
“Andrò in cerca di quanto la natura mi offrirà e porterò quanto trovato alla capanna centrale, dove vengono raccolti tutti i materiali!”
Mise sulle spalle una capiente cesta e si avviò: raccolse sassi e legna.
Alla fine della raccolta dei materiali, il capo popolo cominciò a fare la cernita di quanto si era messo insieme.
I ricchi si vantavano, il cumulo era pieno di ori e argenti.
Parecchi dei ricchi canzonavano Pet:
“Tu con la tua povertà sei stato capace di portare solo legna e sassi!”
Il capo popolo stupì tutti e prese la parola:
“Ecco che costruiremo case grandi e robuste, non certo con l’oro e l’argento…!” infatti per dar luogo a confortevoli abitazioni, vennero usati proprio il legno e i sassi portati dal povero Pet.
C’era un uomo, nella tribù di Graz, che non cacciava né raccoglieva, eppure era stimato e amato da tutti: era lo stregone. Egli usava talismani e onorava gli spiriti degli animali uccisi dai cacciatori, teneva il conto delle lune e celebrava riti propiziatori. Insegnava ai fanciulli il rispetto per la natura, l’amore per gli animali:
“Non uccidete mai una mamma con un cucciolo!” diceva. Lo stregone conosceva tutte le storie e le leggende della tribù, tramandate oralmente negli anni. Quella mattina nella grotta delle fiabe lo stregone parlava della bellezza della Madre Terra, del rispetto che ci vuole e raccontò una favola:
LA LEZIONE DEL GENIO DELLE STAGIONI
Il genio delle stagioni lavorava per permettere ai cicli naturali di avvenire. Era uno spirito buono e benevolo, usava il suo soffio per spargere i semi, così nascevano frutti e piante. Si succedevano la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno, magicamente, ogni anno. In marzo i rami del bosco si riempivano di nidi e frutti. Le tribù raccoglievano ottimo cibo, era gran festa. Ma i popoli non portavano rispetto a quei prodigi.
“Sono molto preoccupato!” pensava il genio delle stagioni, si era persa nel tempo l’usanza di venerarlo e adorarlo, per ringraziarlo del cibo, dell’acqua e del sole. Egli però era buono, nonostante tutto fece venire l’estate, con le spighe biondeggianti. I cacciatori uccidevano senza pensare al ripopolamento. I giovani e le donne non usavano pregare per rendergli grazie. Venne comunque anche l’autunno con l’uva e i suoi magnifici colori.
“Ma nessuno pensa a me e alla natura!” si lamentò il genio delle stagioni. Ergo una coltre di neve coprì come per scaldare il suolo il palcoscenico. Gli animali dormivano e tutto cadde in un sonno profondo. Gli uomini continuarono a vivere senza onorare il genio delle stagioni, né i fiori, gli alberi e gli animali. Quella volta cadde proprio la goccia che fece traboccare il vaso. Non c’era più devozione per i luoghi e le piante.
“Sono proprio arrabbiato!” disse il genio e quell’anno non fece risvegliare la natura. L’inverno persisteva e la primavera non veniva. Gli uomini cominciarono a piangere e a disperarsi, proprio come i coccodrilli. Il gelo continuava a rendere fredde le loro capanne e il villaggio era avvolto nella bufera.
“Solo ritornando come ai tempi antichi, rendendo ossequio agli alberi, alle corolle e alla fauna potrete riavere la primavera!” urlò il genio dai cieli, indirizzando le proprie parole a tutte le tribù. La gente allora tornò a rispettare mamme e cuccioli, ad amare i petali colorati, a rendere omaggio al genio delle stagioni e finalmente un bucaneve spuntò dal suolo gelato e in pochi giorni il miracolo della primavera tornò a rendere gai gli animi e i cuori di ognuno. Il ghiaccio si sciolse e in breve tutto fu colorato, accompagnato dal canto degli usignoli e con tanti germogli che promettevano gustosi frutti.
C’era una grotta, nella parte nascosta sotto alle fronde del villaggio, nella quale non era permesso l’ingresso ai giovani dell’età di Graz. La piccola bambina si chiedeva cosa mai custodisse. Si narrava di graffiti, rappresentazioni di bisonti, cavalli, uomini a caccia. Graz era assai curiosa. Si avvicinò alla grotta e scorse una delle pareti, leggermente illuminata da una fievole torcia accesa perennemente. Si vedevano incisioni rupestri e pitture. Nella caverna si potevano scorgere immagini di rinoceronti lanosi ma soprattutto diverse statuette rappresentanti una donna grassa: Madre Terra.
Bisognava proprio avere grande arte per poter dipingere, fare graffiti, realizzare quelle opere.
“Ma come fanno gli uomini a dipingere cose così belle?” chiese Graz alle donne anziane, che quella mattina raccontarono una favola sulla capacità di ammirare e commuoversi di fronte agli spettacoli della natura:
LA COMMOZIONE
Era triste la vita per Rup, egli non sapeva mirare né il prodigio dell’aurora, quando il firmamento s’imporporava, né il cielo terso delle ore dopo la burrasca. La giumenta allattava dolcemente il puledro e lui rimaneva impassibile, i fiori sbocciavano tra mille colori e con intense fragranze, ma Rup era duro nel cuore.
“Ammira i miracoli della vita!” gli diceva lo stregone del villaggio, tuttavia Rup era freddo e insensibile.
Un dì accadde che Rup perse tutti i componenti la sua famiglia, erano periti durante la caccia al bisonte. Nulla lo confortava né gli portava pace. Egli continuava a essere distaccato e senza la capacità di cogliere l’essenza dello spirito. Uno scoiattolo magico balzò da un albero innanzi a lui. Aveva occhietti vispi e folta coda. Mostrò i dentini aguzzi intenti a rodere un guscio di noce. Rup non assistette con curiosità ed emozione a quello spettacolo semplice ma grande, di una creatura vivente che mostrava le bellezze della natura e seguitava a compiangersi.
Lo scoiattolo magico sentenziò:
“Poca cosa ci consola se non sappiamo commuoverci innanzi agli spettacoli della vita!”
Rup si fermò, cominciò a riempirsi i polmoni e le nari dei profumi intensi del bosco, mirò con il cuore il verde delle piante, toccò con piacere il muschio vellutato, s’intenerì nell’osservare gli uccellini recarsi al nido per cibare i figli pigolanti.
Riuscendo a commuoversi davanti alla natura, per la prima volta trovò un po’ di consolazione: bisogna saper cogliere ogni cosa meravigliosa dell’esistenza!
Importante scuola, per tutti i giovani della tribù, era osservare gli adulti e provare a imitarli. I maschietti ammiravano gli uomini, le bambine le mamme e tentavano di emularli. Graz si appassionava nel guardare con attenzione le donne che ora preparavano nei mortai legumi pestati per i piccoli, ora cucinavano nei recipienti d’argilla sopra alle pietre arroventate. Momenti molto importanti erano le feste e i riti. La tribù si riuniva sotto la luna e spesso si stava alzati fino al tramonto del satellite terrestre per cantare agli spiriti del cielo e invocare benignità. Allora era assai importante per Graz istruirsi sui comportamenti dei grandi, vedeva nel gruppo eccezionali atteggiamenti che educavano alle credenze nelle anime degli alberi, all’onore per i morti e rappresentavano grande esempio di unione e amore:
“Bisogna sempre testimoniare l’amore!” venne narrato una mattina nella grotta delle fiabe. Era un dì umido. Al centro della caverna si era acceso un fuoco che trovava sbocco in un foro scavato nel soffitto roccioso. Graz era seduta vicino alla fiamma e ascoltò raccontare:
CANTARE IL BENE E LA FRATELLANZA
Sotto ai funghi e ai muschi del bosco, Nep scavò un giorno una buca. C’erano vari strati di terra.
“Voglio scoprire cosa c’è sotto!” disse il giovane e cominciò, a mani nude, a togliere tappeti magici d’erba e di zolle.
Sotto al primo strato vide che ce n’era uno e poi un altro ancora. Tolse vari livelli di terreno quando incontrò una talpa, essa aiutava gli gnomi a costruire le proprie case.
“Continua a cercare!” gli disse la talpa dal muso appuntito nero e marrone.
Nep rimase sbalordito. Vedeva le piccole talpe che portavano rami per gli omini col cappello a punta e gli abitini rossi e verde. Uno gnomo vide Nep. Mentre lavorava lo gnomo cantava e abbracciava i compagni. Erano tutti uniti e fraternamente si scambiavano tra loro gli arnesi, si davano il cambio, operava in sintonia perfetta. Nep divenne piccolo piccolo e lo gnomo gli disse:
“Tu che hai avuto il coraggio di scoprire gli strati di terreno per vedere e svelare, potrai vedere cosa ci rende magici!”
Anche Nep divenne per una mattina uno gnomino e poté comprendere cosa dava tanta vitalità e perfezione a quella comunità. Gli esserini magici infatti, procedevano e lavoravano cantando e testimoniando amore e fratellanza. Ognuno parlava di pace e solidarietà, si zufolava allegramente e si stornellavano canti di bene.
Ecco qual’era il segreto di quella zona incantata del bosco: la voglia di parlare di onestà e giustizia ai compagni, con il desiderio di spartire la felicità con gli altri.
Nell’era post-glaciale ci si alzava all’alba, sia nel periodo estivo, sia in quello trascorso in pianura e che coincideva con la stagione fredda. Il cielo era nuvoloso, mentre la natura autunnale rendeva il palcoscenico ricco di sfumature dorate. Molti erano i piccoli nati nella tribù di Graz, in quei mesi dell’anno, calcolati dallo stregone in base alle lune che crescevano e calavano. Le donne stavano cucendo cogli aghi d’osso, apposite tele che servivano per portare i neonati sempre con le madri, legati al petto. I più giovani erano anche tenuti in braccio, o sul grembo, per un’ unione continua e calorosa. Graz guardava i bambini piccolissimi dormire durante il cammino, mentre la raccolta procedeva. Si coglievano more in quantità, come avveniva spesso in settembre. Quando i cesti furono colmi, alcune donne si recarono con gusci d’uova ad attingere l’acqua. Si sarebbero bolliti i frutti per creare una bevanda fermentata e zuccherosa dalle capacità ritemprati e che avrebbe scaldato durante il clima rigido dell’inverno. Mentre la frutta bolliva si ringraziava il generoso spirito di Madre Terra che tanto dava al popolo della tribù e venne raccontata una favola:
LO SPIRITO DELL’ALBERO CHE PERDONAVA
C’era una volta un guerriero che pensava di avere tanto potere:
“Sono forte e malvagio: sono tanto potente!” diceva procedendo con la lancia affilata e il pugnale, per farsi spazio nella selva. Egli si pensava esuberante e malvagio, così da essere superiore a tutti, ma quella mattina avvenne un fatto straordinario. Intanto che continuava a distruggere piante e germogli per aprirsi il cammino, si presentò lui lo spirito dell’albero:
“Ecco che tu hai tagliato i miei rami e hai distrutto le mie foglie senza pensare che io ti do riparo, ti offro i frutti e ti proteggo: tuttavia io ti perdono!” disse lo spirito dell’albero perdonando l’uomo incosciente e cattivo che distruggeva tutto.
Il guerriero rimase a bocca aperta, scoprì che il vero potere non stava nelle armi ma in quell’esempio di generosità dell’albero che era capace di perdonare. Fu così che da quel giorno il guerriero imparò a rispettare la natura e a preservarla da ogni scempio: mai più tagliò o recise un ramo e ogni volta che raccoglieva della frutta, o trovava riparo sotto a delle fronde, ringraziava Madre Terra.
Ad eccezione dell’Antartide, ogni angolo della Terra, stava divenendo abitato dall’uomo. Le genti si spostavano verso nuove lande, oltre il mare, verso isole e pianure, oltre i monti e al di là del freddo. A differenza degli animali, la specie umana, era capace di adattarsi e vincere le difficoltà naturali. Si sapeva come coprirsi, procacciarsi selvaggina e seguirne gli spostamenti. Via via che i popoli abitavano nuovi siti, tra essi comparivano diversità: di colore, di pelle, di abitudini; tuttavia una cosa rimaneva simile in tutte le tribù: la generosità che ognuno offriva a prò di tutto il gruppo. Così i cacciatori ottenevano prede da spartire coi compagni, le raccoglitrici servivano il prossimo e ognuno si sentiva soddisfatto nel mettere il proprio lavoro a disposizione della comunità. In quell’autunno, in una di quelle giornate col cielo riscaldato dagli ultimi bei soli di fine bella stagione, mamme e bambini stavano all’ingresso della grotta delle fiabe. Gli uccelli migratori volavano verso sud e i piccoli li ammiravano, mentre veniva narrata proprio una favola sulla generosità:
LA MANO GENEROSA
La mano destra e la mano sinistra erano assai diverse tra loro, non solo perché avevano aspetto opposto, come riflesso su uno specchio, tra di loro. Soprattutto erano dissimili perché la mano sinistra era avara e quella destra era generosa.
“Tengo tutto per me!” diceva la mano di manca e stringeva con forza le piante mangerecce raccolte. Voleva accumulare tutto per sé, senza pensare agli altri.
“Ci vuole gran cuore!” rispondeva la mano di dritta e offriva tutto con magnanimità.
Per la mano destra c’erano complimenti e belle parole, mentre tutti parlavano male dell’altra mano.
Alla mano destra faceva piacere questo fatto ma avrebbe voluto redimere anche la compagna.
La mano sinistra non viveva bene, era sempre insoddisfatta e chiese un giorno alla vicina:
“Come mai nessuno dice bene di me né mi ama?”
Allora l’arto destro disse:
“Dimmi di un solo avaro ricordato dall’amore del popolo per la sua grettezza e di un solo generoso ingiuriato per la prodigalità!” e da quel giorno anche la mano sinistra divenne generosa.
Mentre le donne raccoglievano, al villaggio rimanevano gli artigiani, quelli che lavorano la selce e producevano lame e lance. Essi battevano in modo veloce dei sassi per ottenere lame. Ogni pietra, chiamata ‘chopper’, aveva punta diversa e serviva, ora per creare armi, ora per tagliare pelli, aprire un osso, lavorare legna . Graz rimase tutta la mattina a osservare i lavoratori usare le diverse pietre e creare. Quando le donne tornarono dalla raccolta, avevano le ceste piene di frutta e ringraziavano lo spirito degli alberi con riconoscenza, infatti quella mattina venne narrata una favola:
LA RICONOSCENZA
C’era una volta un albero generoso che produceva frutti di tutti i colori, dolcissimi e succosi. La gente correva sotto di lui nella stagione della maturazione e coglieva quei tesori di zucchero e sapore.
“Che bei frutti!” esultava il popolo e attorniava l’albero.
La pianta generosa era contenta, percepiva il calore di uomini e donne attorno a lui. Quando però l’abbondante produzione era stata razziata dalla tribù e i rami rimanevano spogli, nessuno si occupava più dell’albero che veniva lasciato solo e triste.
L’albero si arrabbiò.
“Perché nessuno mi è grato per quanto ho dato?” si chiedeva e tristemente decise di attendere il periodo invernale per dormire il riposo del giusto.
Le stagioni si succedettero e stava per giungere la nuova primavera. Dai tronchi non nasceva quell’anno alcun frutto. L’albero era arrabbiato.
Il buon Col, un ragazzo giovane e dal cuore tenero e dolce si avvicinò ugualmente all’albero.
“Io ti voglio bene e ti sono riconoscente per tutti i frutti che nei tempi hai dato alla mia tribù!” diceva all’albero curandolo, annaffiandolo e carezzando i rami e le foglie.
La pianta decise allora di premiare Col. Davanti agli occhi emozionati del buon giovane, l’albero fece nascere frutti grandissimi rossi, gialli e arancioni, dal gusto portentoso e unico:
“Questi frutti sono tutti per te che hai dimostrato riconoscenza!” disse l’albero che da quel giorno divenne l’amico intimo del giovane Col.
Andare a caccia, nel periodo appena successivo all’ultima glaciazione era assai duro. C’erano mandrie di renne, cavalli, bisonti, rinoceronti lanosi e soprattutto in Alto Adige e in Padania, orsi, lupi, caprioli e grossi cervi stupendi, che si cercavano seguendone gli spostamenti. Servivano, non solo per mangiare, ma anche per rifornire la tribù di ossa, pelli, corni utili per l’abbigliamento e la costruzioni di dimore o barche e strumenti . Con l’arco in spalla e con le frecce nelle rozze faretre, si partiva dal fondovalle e si camminava per ore e ore. Una volta trovata una grande mandria la si dirigeva dall’altura verso il picco, tentando di far cadere dai dirupi gli animali spaventati. Molti erano i riti che si facevano per accattivarsi il benvolere degli spiriti. Si pregava per le anime degli animali periti, ma ciò non aveva a che fare con la dea fortuna. Non era la fortuna che serviva, ma il coraggio e l’ardore. Per instradare i giovani a non contare sulla fortuna si raccontavano fiabe come quella che segue:
LA DEA BENDATA
Cik pensava che ogni suo atto dipendesse dal volere della dea della fortuna. Attendeva ogni notte lo spuntare della luna e si rivolgeva al firmamento con macumbe e celebrazioni.
“Oh dea Bendata, fa che io possa avere una sorte benigna!” diceva e cantava accompagnandosi con un tamburo.
Trascorreva così ore e ore, mentre gli altri riposavano per poter così durante il giorno prepararsi fisicamente alle attività, creare gli strumenti e gli attrezzi, progettare lavori.
Cik, trascorrendo le ore del sonno a invocare la dea bendata, non aveva durante il giorno la forza di lavorare, ebbe però una gran fortuna e si ritrovò a scoprire mandrie di grassi cervi, cinghiali, camosci, tassi e stambecchi.
I cervi erano enormi e con palchi di corna stupendi. I tassi belli grassi, Camosci e stambecchi colorati di bel fulvo, agili e scattanti.
Stanco e sfinito per la mancanza di sonno, Cik aveva però le idee poche chiare. Non era d’accordo con la legge del gruppo, secondo la quale ognuno era disposto a spartire cogli altri ogni preda rintracciata. Prevalse l’egoismo.
“Catturerò ogni animale trovato e lo terrò per me! Fuggirò dal villaggio e sarò il solo a beneficiare della caccia!” disse Cik.
I compagni lo videro e commentarono:
“La fortuna non è solo cieca, ma rende ciechi anche coloro che ha beneficato !” e Cik udendo tali parole tornò presso le nicchie ove avevano le loro dimore gli abitanti della sua tribù, chiese scuse e tutti insieme si unirono per andare a far propria la selvaggina trovata.
Ai bordi di un piccolo lago, spesso, i componenti la tribù di Graz si riunivano per ringraziare la Madre Terra di ogni cosa: del sole, degli animali e dei frutti. Dopo lo scioglimento dei ghiacci, la conca d’acqua si era formata contornata da belle cime innevate ed era uno stupendo panorama vedere le cenge coronare lo specchio lacustre sul quale si specchiavano formando un tappeto luminoso. Sui colli si scorgevano, ora nascondersi, ora galoppare, camosci e stambecchi. Il popolo continuava a ringraziare di tutto e sovente, negli ultimi periodi che lo consentivano, si accampava tutta la notte per riti e celebrazioni in onore di ciò che veniva donato dal pianeta alla tribù. Mentre qualcuno, illuminato dai raggi della luna, cercava quarzi che poi sarebbero serviti per costruire utensili e armi, lo stregone accendeva un fuoco profumato e gli altri cantavano.
“Ma bisogna ringraziare Madre Terra proprio di tutto?” chiese la piccola Graz sotto la sua chioma bruna che le copriva gli occhietti vispi, mentre correva intorno al bivacco con le sue gambette snelle. Le donne la invitarono a sedersi e una di esse le raccontò:
NULLA E’ SCONTATO
C’era una volta un bambino che non capiva quanto preziose fossero le cose che avesse. Un giorno un elfo vestito di argento e oro bianco, lo invitò a rendere grazie per ogni cosa che faceva la sua vita più piacevole.
“Tieni questo frutto, assapora il dolce succo che esso contiene e gioiscine!” disse il bell’elfo porgendo sul palmo una drupa succulenta.
“Non mi va di ringraziare di nulla! E’ normale che nascano i frutti!” rispose il bambino. Allora l’elfo magico rese onore a quanto portato dai cacciatori dopo la giornata di lavoro. C’erano carni bianche e rosse in quantità. Alcune venivano cotte subito in una grande buca, altre venivano fatte essiccare: sarebbero servite per portare dietro cibo durante gli spostamenti, o per i periodi di carestia.
Il bambino non volle ringraziare nemmeno per la carne, a lui pareva tutto scontato.
“Devi renderti conto di quanto sei fortunato per l’acqua, la luce, il sole, il vento e la pioggia, per ogni cosa!” continuò l’elfo e provò a cantar strofe antiche per ricordare la generosità della Terra. Il fanciullo non riusciva a comprendere, non gli andava proprio di rendersi conto di quanti regali eccezionali e prodigiosi contornavano la sua esistenza.
Per lui era tutto normale. A un certo punto il bambino cominciò a maledire ogni cosa, compresa l’aria che respirava e si dimenticò di respirarla. L’elfo magico allora giunse tosto in suo soccorso. Lo risvegliò con il profumo di sali portentosi dicendo:
“Tutto ci pare scontato, anche l’aria che respiriamo, eppure ogni cosa rende l’essere vivente, capace di vivere ogni ora piccoli-grandi miracoli !”
Il fanciullo comprese, ricominciò a respirare gustando quell’aere fresca e vivificante e da quel momento imparò a ringraziare per ogni cosa.
Le tribù del mesolitico avevano imparato a proteggersi dal vento e dalla pioggia per mezzo di costruzioni composte da conci e argilla. Il popolo, nelle giornate autunnali piene di vento si riparava a sud della bella prateria ingiallita. A destra si scorgeva la zona acquitrinosa dove si raccoglieva l’acqua, mentre avvolti da pelli di ghiottone, stavano i bambini ad ascoltare le anziane donne raccontare favole.
“Non dobbiamo aver paura delle cose che ci paiono negative, come la pioggia, ogni cosa ha utilità!” dicevano madri e nonne ai piccoli mentre erano intente a usare la pietra focaia e anche i primi animali addomesticati, come il cane e le capre, cercavano di trovare ristoro vicino ai massi frangivento.
Pure gli uomini quel giorno non sarebbero usciti, rimasero infatti al riparo preparando scuri, fiocine e archi, intanto che venne narrato:
NON TUTTO E’ MALE
In una valle ampia e arricchita da arbusti verdi e rigogliosi il buon Giac si alzava ogni mattina invocando fratello sole di imperare in cielo e scacciare le nuvole gonfie di pioggia.
“Voglio sempre il sole!” diceva Giac provando per la prima volta nella storia a compiere tentativi con le piante e cercando di far nascere verdure e frutti.
Era quello l’inizio dell’era dell’agricoltura, quando l’umanità avrebbe imparato a far nascere prodotti dal suolo.
“Speriamo che rimanga il bel tempo!” pregava Giac, ma la stagione umida si avvicinava e il cielo piano piano diventava fosco nascondendo i raggi solatii.
Immancabilmente si annunciava l’arrivo di un temporale.
Giac continuò a invocare frate’ sole. Le sue suppliche furono tante e tali che la pioggia non sopraggiunse. I suoi tentativi di far crescere semi e germogli però andavano male. La terra divenne secca e brulla. I germogli richiedevano una bella rinfrescata, c’era bisogno della pioggia.
Fratello sole si mostrò con la sua bella faccia sorridente, tuttavia stava diventando pallido. Lo stupendo astro del giorno disse a Giac:
“Non tutto ciò che ci sembra male vien per nuocere. Le nuvole gravide di pioggia calmano la sete dei campi!” e finalmente uno scroscio d’acqua si scaricò sul terreno con le piante che nacquero e produssero grossi frutti.
Giac capì che anche gli eventi che ci appaiono poco buoni hanno un loro importante e fondamentale valore. Da quel giorno, insieme a fratello sole imparò ad amare anche le sorelle nuvole.
L’evoluzione della specie aveva portato l’uomo a diversi cambiamenti. Dopo aver assunto la posizione eretta si notava soprattutto il mutamento, rispetto all’uomo di Neanderthal, per il cranio sviluppato in lunghezza e larghezza anziché in altezza. Ciò, secondo le scienze, aiuta a comprendere che il cervello, via via, con l’arrivo delle stirpi meridionali di una razza bruna nell’Italia del nord, assumeva forme diverse. Proprio in virtù dei reperti preistorici ritrovati, si è pensato che con le variazioni della scatola cranica e del contenuto della materia grigia, la specie umana ha variato le proprie capacità fonetiche e di ragionamento. L’uomo preistorico, secondo alcuni, aveva un cervello grande poco più di un pompelmo . Eppure l’uomo di Flores, vissuto almeno diciottomila anni fa, era già capace di orientarsi e abitare in gruppo; questa specie infatti andava oltre i saperi e le scienze: seguiva il cuore. Ecco cosa si raccontò quella volta nella grotta delle fiabe:
I SENTIMENTI INDICANO LA STRADA
Un giorno Amub si ritrovò disperso nella selva. Non sapeva dove andare, eppure egli sapeva bene di tracciati e percorsi. Il suo sapere era tale che conosceva perfettamente ogni meandro e dedalo della selva. Il sole stava ormai calando e la paura gli saliva in cuore. Sarebbe stato assai pericoloso pernottare fuori dal villaggio:
“Come farò?” si domandava Amub pensando alla sua grotta, alla famiglia, al calore del fuoco e al pasto serale.
Da bravo cacciatore sapeva scorgere le orme lasciate dalla selvaggina, ma pur vedendo tracce di rami spezzati da un capriolo e notando il passaggio di uno scoiattolo, non si raccapezzava:
“Chissà dove sono!” gemeva parlando tra sé e sé.
A quel punto, a poco valeva avere tante conoscenze, sapere di armi e tecniche di costruzione; qui ci voleva un’altra via. Amub si portò al centro della foresta di piante decidue. Nella zona esposta ai raggi della luna che ormai era salita in cielo, si rivolse alle stelle.
“Devo seguire il fiume? Devo cercare la strada pensando alle piante e agli alberi?” domandava.
Una stella buona gli rispose:
“Non contano i saperi: va dove ti porta il cuore!”
Amub allorà si concentrò, ascoltò il proprio animo e là ove lo sentiva caldo, grazie al calore dei propri familiari che lo stavano aspettando, percepì quale via prendere fino a che si ritrovò proprio presso la pianura ove la sua tribù si era stanziata in quel periodo. Venne accolto dall’abbraccio di parenti e compagni: era proprio valsa la pena ascoltare i sentimenti più delle conoscenze.
L’organizzazione sociale, diecimila anni fa non aveva nulla da invidiare a quella che noi chiamiamo la società progredita. Ognuno si occupava di collaborare per il bene dell’intera comunità. Ormai si lavoravano metalli e si produceva nuova ceramica, i vari gruppi umani s’incontravano e nascevano scambi e commerci. L’attività principale consisteva nella caccia. Occorreva spostarsi sottovento, affinché la selvaggina non avvertisse l’odore dei cacciatori. Se al giorno d’oggi si va a caccia soprattutto con animo violento e tanta cattiveria nel cuore, all’epoca c’era amore per la natura e per gli animali. L’uomo sapeva che era gran ricchezza sapersi integrare all’ambiente, rispettarlo ed onorare fauna e flora.
Nella grotta delle fiabe si narravano spesso favole legate alla consapevolezza di saper controllare i propri impulsi malvagi, eccone una:
LA RICCHEZZA
Nella caverna c’erano tanti simboli. Una luna disegnata, la roccia della sapienza, i graffiti con raffigurati l’uro e il bisonte lanoso. Ogni simbolo rappresentava una caratteristica diversa. La tribù comunicava ai posteri modelli di vita e credenze attraverso ciò.
Prima di tutto stava il vecchio legno di un grande albero.
“Questa è la ricchezza!” dicevano gli anziani innanzi a quella corteccia scura, levigata da tante screziature che sfumavano dal giallo pallido al fulvo scuro.
I piccoli percorrevano il legno con le dita per sentire con la sensazione tattile gli anni rappresentati da quel pezzo d’albero. Si trattava della secolare pianta che, si narrava, tanti e tanti anni prima aveva dato vita alla prima capanna del villaggio, offrendo la propria legna per edificare le rudimentali abitazioni.
“Se abbiamo gli alberi allora siamo ricchi!?” disse il piccolo Rok.
Uno degli anziani gli rispose:
“Non basta avere gli alberi, bisogna soprattutto essere ricchi dentro. La miseria dell’uomo è la propria cattiveria. La ricchezza è rendersi conto della cattiveria e riuscire a domarla, così da rispettare e onorare l’albero !”
Il piccolo Rok si diresse verso la parte della valle coperta dalle piante e s’inginocchiò ai piedi dei tronchi e davanti alle fustaie, ringraziando Madre Terra di tutta la ricchezza che aveva in cuore.
Andare a caccia era un vero lavoro di squadra. Ci volevano unità di gruppo e capacità di collaborare. Una delle cose che più avevano permesso di cacciare coesi e con armonia era il linguaggio. Per gli ominidi era impossibile poter comunicare pensieri e idee come lo fu per gli uomini di diecimila anni fa.
La maniera di comunicare piano piano si evolveva e cambiava. All’inizio assai rudimentale, poi sempre più attenta alla sintassi e alla grammatica ; ma nella grotta delle fiabe, ove fino a quattro anni e oltre i fanciulli venivano allattati, si narravano loro fiabe per educarli ad altri aspetti. Ad esempio si voleva insegnare loro a dominare il tono della voce, anche Graz, che era un po’ più grande dei piccoli che suggevano il latte materno, ascoltò raccontare:
IL TONO DELLA VOCE
La canna di bambù voleva suonare una ninna nanna al piccolo narciso, il fiore giallo che si specchiava nel limpido lago.
La canna di bambù era innamorata di quella splendente corolla che si rifletteva sulla superficie liquida. Non aveva occhi che per quei petali che parevano imitare la luminosità del sole e apparivano splendidi.
“Dormi e riposa mio adorato!” disse dolcemente la canna di bambù che allargò le nari e cominciò a far passare il venticello dentro di sé. Lo zefiro provocava così una melodia che si spargeva attorno al lago. Si alzarono i girasoli e si misero ad ascoltare anche le ranocchie, ma la canna di bambù non badava loro, tutta impegnata a cantare per il narciso.
La canna decise che doveva mettere ogni forza nel cantare. S’irrigidì e fece entrare un’enorme quantità di vento nel proprio incavo. Purtroppo la forza dell’aria fu tanta e tale che anziché una ninna nanna venne fuori una serie insopportabile di note troppo acute. Il narciso, invece di addormentarsi si tappò le orecchie. Una magica ondina, una dolce creatura del lago che viveva su una bella ninfea galleggiante, si avvicinò alla canna di bambù e le disse:
“Il tono di voce muta la forza e il senso dei nostri messaggi: se canti troppo forte le tue note divengono nocive per chi ascolta!”
La canna di bambù allora provò a sussurrare lo stesso motivo e finalmente il narciso si addormentò tranquillo e sereno.
A Graz piacevano soprattutto le capanne estive, nelle quali si poteva entrare e uscire a piacimento per giocare con gli altri bambini; quell’inverno, invece, si preannunciava assai freddo e si continuava a migrare verso le zone riparate. Ormai erano dimenticate nelle leggende le glaciazioni dei tempi passati, ma la stagione nella quale la marmotta andava in letargo, la temperatura era assai rigida. Si propose di trovare riparo presso le grotte che si affacciavano sul fiume, cosicché sarebbe stato facile attingere l’acqua. Nel corso del torrente, oltretutto si potevano trovare succulenti salmoni. Sulle montagne ormai nevicava. Molti narravano del caldo e del sole, altri si sperdevano in pensieri pensando alla prossima estate, ma gli anziani invitavano a vivere con gioia il presente, perché ogni stagione è bella, anche l’inverno, quando la natura si prepara a rinascere.
Nella grotta delle fiabe venne raccontato:
NON SI DEVE DIMENTICARE DI VIVERE IL PRESENTE
Nel bosco umido galoppava il bel cervo. Uscì dalla foresta e si trovò davanti a una distesa d’erba che avrebbe costituito per lui un ottimo pasto. Il suo palco di corna era stupendo, tanto che pareva una maestà. Il colore del manto sfumava tra il ruggine e il fulvo dorato. Le montagne alpine erano illuminate da un bel sole, ma il cervo non pensava a mangiare. Nella sua menta scorrevano i ricordi. Rammentava i tempi dell’amore, le battaglie con gli altri maschi, il comportamento sociale che lo rendeva parte del suo gruppo e così si dimenticava di aggregarsi agli altri e brucare l’erbetta.
“Che bei tempi ho passato!” rifletteva.
Dalla parte opposta della distesa verde c’era suo fratello. Neppure lui mangiava ma per un altro motivo, egli progettava e sognava il futuro:
“Come vorrei veder nascere i miei cerbiatti! Anelo a vedere quanto prima mia moglie partorire giovani dalla groppa chiazzata di candidi fiocchi!”
Il fratello del cervo che pensava sempre al passato, era talmente intento ad agognare ai tempi futuri che neanche lui mangiava.
Dall’imbocco della valle comparve lento ma sicuro, il cervo più anziano del branco, che osservò e vide i due cervi, entrambi occupati a pensare anziché cibarsi, così sentenziò additandoli:
“Spesso chi ama rimpiangere il passato, o affrettare il futuro, si dimentica di vivere il presente !”
A quelle parole i due fratelli si destarono dal loro torpore e finalmente cominciarono a strappare dolcemente coi loro dentoni quell’erbetta fresca e vivificante.
In alto in alto, dove la pietra della montagna diveniva rossastra di dolomia, illuminata dal solicello di quell’ottobre, si scorgeva una cavità naturale, di forma ellittica: era quello il ricovero del lupo.
“C’è sempre pericolo!” dicevano gli uomini del villaggio e i baldi tiratori stavano appostati a far la guardia alle prime pecore addomesticate, con la fionda in mano per allontanare la bella belva dagli occhi azzurri. Era un lupo stupendo, dal folto collare grigio antracite e il pelo sfumato ora d’argento ora di bianco e nero. Nelle notti di plenilunio ululava forte e chiamava tutto il branco. Allora bisognava trascorrere a veglia le ore destinate al sonno, quando solo le sentinelle vigilavano e a volte anche Graz rimaneva desta intimorita dai ruggiti degli animali feroci.
I piccoli già sapevano adoperare la fionda, ma non era loro consentito far da pattugliamento durante i pericoli creati dal lupo, animale assai temuto ma rispettato per il suo comportamento di amore verso il branco ed esempio di fraternità tra i membri della stessa specie. Fra i ragazzini che si esercitavano ogni giorno a tirare con l’elastico di tendine di uro, alcuni sbagliavano spesso. Certi canzonavano chi non era pratico con la fionda, ma le anziane donne dicevano di non prendere in giro gli amici. L’amicizia era una cosa fondamentale, ognuno doveva essere corretto e aveva il dovere di impegnarsi, ma non per questo ci potevano essere discriminazioni verso chi era più bravo a fare una cosa anziché un’altra e proprio in relazione a ciò venne fatta ascoltare dai giovani questa storiella:
IL BAGNO NEL LAGO
Un lago ampio rendeva alla tribù facile attingere acqua per bere, cucinare e lavarsi. L’unica maniera per potersi detergere totalmente era tuffarsi nello specchio di chiaro liquido e usare le piante di saponaria per pulirsi bene, creando una bella schiuma da sciacquare poi con cura. Le mamme portavano i piccoli del villaggio almeno una volta alla settimana a immergersi nel lago. I cuccioli d’uomo avevano un po’ timore di quel bacino lacustre ma poi si distraevano mirando i pesci saltare a fior d’acqua, ascoltavano il rumore lento della fonte che si trovava sotto alla volta rocciosa e i più grandicelli si divertivano a nuotare.
Tra i provetti nuotatori c’era il giovane Ben. Egli sapeva gettarsi in acqua dalla grande pietra e poi si vantava e andava borioso delle sue gesta.
“Guardate come sono bravo!” urlava rivolto a chi invece non sapeva ancora mostrare muscoli e agilità. Tra tutti c’era Pol, un bimbo esile e poco robusto.
“Pol è proprio un inetto!” commentava il vanaglorioso Ben, sempre intento a sottolineare i fallimenti del bimbo gracilino che si sforzava ma veniva solo deriso.
Gli adulti volevano predicare amicizia e unità di gruppo ma Ben era imperterrito a giudicare con parole sprezzanti il compagno. Un giorno un pesce tutto d’oro, dal potere magico, si presentò in mezzo al lago. I fanciulli lo guardavano a bocca aperta. Sapevano che i pesci magici portano grandi tesori, tuttavia il pesce aveva qualcosa di più prezioso d’ogni cosa da donare:
“Vi donerò l’amicizia. Il vero amico è quello che sa ogni cosa di te e nonostante tutto ti ama !” e dall’incontro col pesce magico Ben imparò ad accettare e ad amare Pol, anche se non sapeva tuffarsi dal trampolino.
Per il periodo estivo si confezionavano artigianalmente bei sandali fatti di corteccia , ma per il clima rigido che si avvicinava, le donne avevano già preparato pelli conciate, che avrebbero rivestito il piede dei cacciatori, legate con dei laccioli per riscaldare e proteggere. Le pelli erano messe a seccare, rese molli con dell’olio di origine animale e poi lavorate con aghi d’osso per cucirle.
A Graz piaceva molto assistere alla produzione di quegli utilissimi oggetti. Specialmente quando si doveva salire verso le cime innevate, colà ove la coltre bianca copriva tutto, le dita dei piedi rischiavano addirittura il congelamento, pertanto oltre alle scarpe si doveva fasciare il tutto con un’ulteriore pelle. Le donne lavoravano con tanta alacrità, ma soprattutto mettevano amore nella loro opera.
“Senza amore non si può fare nulla, col sentimento invece si raggiunge ogni scopo!” dicevano le lavoratrici.
“Anche guarire i mali?” domandò la piccola Graz curiosa e le donne le risposero con una favola:
LA GHIANDA MAGICA
La tribù era in fermento, nella grotta del parto stava per venire alla luce la figlia del capo villaggio. Si erano costruite statuette d’argilla che rappresentavano la fecondità: si trattava di figure femminile grasse e con la pancia grande grande. Lo sciamano recitava salmodie allo spirito dell’albero e tutti erano in fibrillazione per l’esito dell’evento.
Una processione di donne si era recata nella galleria che scendeva nelle viscere della terra , per calmare gli spiriti profondi. In ocra rossa si erano dipinte scene di parto, continuando a fare riti magici.
Come previsto dalle anziane, nacque una femminuccia, ma la moglie del capo villaggio pareva non sopravvivere al parto.
“Come faremo?” si disperavano i componenti la tribù.
Le giovani indossarono braccialetti colorati per adornarsi davanti allo spirito della quercia, alcune avevano anche messo cinture fatte di guscio di chiocciola , o collane di denti.
Avevano in cuore tanto amore per la moglie del capo tribù. Ci misero tutto il sentimento, mentre si prostravano e s’inginocchiavano ai piedi dell’albero. Dalla quercia cadevano ogni tante belle ghiande. Trascorse il tempo in preghiera e giunse la notte. Le giovani del villaggio continuavano a mettere tutto l’amore possibile nelle preghiere. Era buio e le tenebre avevano avvolto la scena, quando dalla quercia cadde una ghianda d’argento. Era una ghianda magica che venne recata presso il giaciglio della donna ormai agonizzante. La ghianda faceva gran luce. L’argento sprizzava raggi caldi e luminescenti che si diressero verso la moglie del capo villaggio che guarì e prese in braccio la neonata fra i festeggiamenti di tutti. L’amore aveva vinto il male, fu gran festa e si mangiarono frutti conservati dolci come l’amore, accompagnati da bevande fermentate calorose e forti.
Per molte lune sarebbe durato il freddo. La tribù accendeva grandi fuochi comuni, tutti si riunivano attorno alla fiamma. Le cuoche mettevano grossi recipienti su pietre ardenti, in un abbondante brodo si bollivano legumi, farro ed erbe proteiche. Via via che i pasti venivano serviti si aggiungevano altri ingredienti e la cottura continuava ininterrottamente. Era piacevole riscaldarsi vicino alla fiamma e con cucchiai di legno assaporare il contenuto di quelle ciotole d’argilla: a Graz piaceva tanto. Vicino al fuoco stava sempre l’anzianissimo sciamano. Era uomo assai ascoltato da tutti, che grazie all’esperienza e alla bontà d’animo, sapeva comprendere i messaggi della natura. Il suo volto era solcato da rughe di saggezza, la sua pelle scura era appaiata ai capelli canuti e leggermente crespi. Lo sciamano insegnava ad amare piante, animali e natura intera, come fossero veri e propri prodigi. Anche le donne, nella grotta delle fiabe, raccontavano fiabe riferite ai miracoli di Madre Terra. Un giorno infatti Graz ascoltò questa favola:
I PRODIGI
Mana stava lavorando una lunga fascia di cuoio: con la punta di un coltello la istoriava decorandola con belle teste di cervo e stelle. Era quello il suo modo di officiare agli spiriti della Terra. Ella chiedeva con tutto il cuore di poter assistere a dei prodigi. Si aspettava di vedere eventi miracolosi e sognava di poter mirare cose uniche e particolarissime.
“Voglio decorare questo cuoio con scene belle e importanti, così che Madre Terra mi ascolterà e provocherà miracoli nella mia vita!” diceva Mana, mentre sostituiva i suoi arnesi con lame di tutti i tipi, per migliorare sempre più il suo lavoro. Aveva un cuore buono Mana. Dopo aver terminato la lavorazione del cuoio continuò nella sua attività artigianale. Decorò un vaso con una faccia dolce e mite. Magicamente da quel bel volto raffigurato sul vaso, uscì una voce incantata.
“Non attendere che si verifichino miracoli, ma guarda con gli occhi dell’animo i prodigi che già sono sulla Terra. Osserva i colori della farfalla, godi del profumo dei fiori, assisti eccitata all’alba come al tramonto, desidera di saper apprezzare la magia dei frutti e delle bacche!”
Mentre Mana ascoltava ciò, una meravigliosa farfalla rossa e nera mostrava le sue ali decorate da fantastici disegni, l’effluvio di un rosaio selvatico entrava nelle nari di Mana, il sole esibiva i suoi stupendi colori e dagli alberi pendevano succosi prodotti:
“E’ proprio un miracolo!” disse Mana che aveva compreso l’essenza magica dell’esistenza che ogni giorno e ogni ora ci regala doni da poter assaporare.
Via via che le condizioni climatiche mutavano con la fine della glaciazione, gli esseri umani andavano occupando nuovi territori, mentre i ghiacciai arretravano. Durante quei mesi di freddo, nella tribù di Graz, già si programmano nuovi viaggi e novelle scoperte. I pescatori offrivano le loro barche agli esploratori, ogni giovane sognava di compiere imprese ardite e tornare per informare il proprio popolo di aver conosciuto progressi e conoscenze. Le trasformazioni ambientali vedevano adesso belle foreste, nei luoghi una volta completamente congelati. Grandi querce, conifere e noccioli presso i quali vagavano renne, cervi e caprioli. S’invocavano gli spiriti degli animali ma i giovani non si sentivano degni di diventare esploratori e cacciatori. Allora gli anziani cercavano di spiegare come ognuno ha un compito nella vita, basta cercare di scoprirlo.
Infatti, già ai piccoli si raccontava nella grotta delle fiabe:
LO SPIRITO DELL’AQUILA
Nella zona alta della valle dei messaggeri di pace e gioia d’amare, cresceva il giovane At. At vedeva i suoi compagni andare avanti nel cammino di vita, indossare le calzature fatate e percorrere miglia e miglia per annunciare felicità e solidarietà.
“Io non sono all’altezza di emulare i miei amici!” rifletteva con lo sguardo mesto e gli occhi bassi.
Dall’alto lo guardava l’aquila reale, importante rapace che dominava l’elevate cenge attorno alla valle.
Era ormai primavera. La bella stagione era stata accompagnata dal ritorno degli uccelli migratori e dal nascere di corolle variamente colorate. Tutti erano gai e volevano partire per il mondo, con l’intento di annunciare lietezza presso ogni villaggio.
At si sentiva meschino, non comprendeva che anche lui aveva un ruolo importante nel dover testimoniare l’allegria di esistere.
Gli altri partirono, lui rimase solo solo presso la capanna di canne, ove avrebbe trascorso a compiangersi tutta la stagione. L’aquila reale volò nella volta azzurra e poi si lanciò in picchiata presso la capanna di canne.
“Chi sei?” chiese At al grande uccello che mostrava il suo rostro adunco, gli artigli forti e la potenza del suo carattere.
“Sono l’aquila che sceglie coloro che debbono annunciare amore. Io ti ho scelto. Ognuno di noi è degno di essere eletto ad annunciatore di pace, basta ascoltare il cuore e sentirsi voglioso di compiere il proprio dovere. Parti dunque e incamminati per essere portatore di buone ambasciate!”
Finalmente At partì, non ebbe mai più paura di gridare unione e felicità al prossimo, tanto che venne ricordato da tutte le leggende narrate dagli anziani ai piccoli nelle lunghe serate invernali presso il fuoco.
Mentre le specie animali non potevano contare che sui cambiamenti biologici, per migliorarsi, l’uomo aveva la possibilità di sviluppare la sua intelligenza, il linguaggio e i progressi culturali . Ecco cosa distingueva la razza degli uomini dagli altri: la capacità di trasmettere saperi e conoscenze alle generazioni successive, cosicché via via si potessero aumentare i modi di affrontare le difficoltà e il bagaglio di apprendimenti fosse sempre più nutrito. Mezzo primario per regalare saperi ai giovani era la favola. Quel giorno si parlò di come gli strumenti creati dagli artigiani si fossero evoluti nel tempo. Nella grotta delle fiabe si raccontò dei tempi arcaici, nell’antica età della pietra (paleolitico) quando si lavorava limitandosi a scheggiare gli utensili. In quel periodo invece si era progrediti e gli uomini usavano speciali strumenti, detti “microliti” che modellavano e rendevano atti all’uso coltelli, punteruoli e asce. Crescere culturalmente e nelle capacità industriali era gran cosa, gli anziani però prediligevano sempre il cuore, ecco infatti la favoletta di quel giorno. Accucciato sotto a una nicchia, con le mani sulle ginocchia, il più anziano della tribù raccontò, mentre i piccoli erano tutt’orecchie:
LA MACCHINA DELL’ABBONDANZA
Noc levigava la pietra e costruiva utensili. Il suo laboratorio era una piccola grotta, cinta da ciottoli di bella selce scura e con striature di calcare che la rendevano simile al manto di un animale fantastico.
Noc sognava di creare uno strumento che avrebbe reso ricchi lui e il suo popolo:
“Voglio costruire la macchina dell’abbondanza!” diceva mentre continuava a formare e dare modello ai vari materiali disposti su una lunga tavola di pietra.
Agognava ad avere un arnese straordinario, che portasse cibo a iosa, monili ricchi, ciottoli scintillanti e conchiglie di valore. Per magia comparve davanti a lui un machete fatato.
“Agitami e avrai per te e la tua tribù ori, smeraldi, pane e carne!” disse il machete.
Era vero! A ogni sciabolata si producevano alimenti e ori per tutti.
Noc corse a perdifiato in mezzo alle capanne. Gridò a tutti di aver creato la macchina dell’abbondanza. I suoi compagni cessarono di lavorare e si diressero a mirare cosa annunciava Noc. Il popolo, una volta dedito all’alacrità e all’impegno, cessò da quel giorno di lavorare:
“Voglio avere e voglio avere!” diceva ognuno senza più pensare alla solidarietà e all’amicizia. Con la macchina dell’abbondanza gli uomini e le donne divennero egoisti. Si mutò; pieni di cupidigia, senza più pensare al bene della comunità.
I più tristi furono i bambini, che erano rimasti puri di cuore, allora si riunirono e comparvero in mezzo alle capanne urlando:
“La macchina dell’abbondanza ha fatto ricche le nostre capanne, ma poveri i nostri cuori!”
Gli adulti compresero e la macchina dell’abbondanza venne distrutta. Il vero valore della vita era quello di amarsi l’un l’altro in coesione ed armonia.
Era chiaro, a tutti gli adulti del villaggio, quanto importante fosse il fatto che la specie umana era in grado d’imparare. Così s’insegnava ai piccoli a riconoscere le piante mangereccie, a comprendere il soffio del vento che portava la pioggia, a capire quando il sole avrebbe imperato sul palcoscenico. Mentre infatti i cuccioli potevano solo seguire l’istinto, i bambini avevano la possibilità di acquisire una gran quantità di nozioni. Insegnamento principale voleva essere quello di aiutare a comprender la gioia di darsi al prossimo, piuttosto che divenire ricchi e con la capanna piena di pelli e lane.
Mentre le donne suonavano primordiali strumenti, composti da corni o avorio, venne narrato:
LA CONCHIGLIA MAGICA
C’era una volta una donna di nome Lopa che pensava solo ad arricchirsi di conchiglie e ornamenti. Si metteva ciondoli e collane e poi si esibiva nel mezzo del villaggio. Tutti si occupavano di procurare cibo per i bambini e di partecipare al benessere della comunità. Era una tribù che viveva lietamente e tutti sorridevano nel rendersi utili agli altri, mentre Lopa rimaneva in disparte preoccupandosi solo di mettere nella sua capanna manufatti artistici di valore.
Quel giorno aveva un oggetto color ocra inciso con motivi fantastici ed era assai orgogliosa. Lo attaccò a un tendine essiccato di uro e se lo mise al collo per farlo vedere a tutti.
“Guardate come sono ricca!” esclamava tutta impettita e con lo sguardo altero, davanti ai compagni intenti a lavorare.
“Sarai anche ricca, ma noi non ti stimiamo!” risposero raccoglitrici e cacciatori.
“Come mai anche se sono ricca nessuno mi ama?” domandò Lopa rientrando mestamente nella sua dimora. Tra gli oggetti messi in mostra su un ripiano di pietra c’era una conchiglia magica che le rispose:
“Prova a pensare meno alla ricchezza degli oggetti e pensa al cuore!”
Lopa uscì con l’intenzione di ravvedersi.
Scorse un uomo assai indigente che chiedeva aiuto.
Lopa gli offrì tutti i suoi oggetti preziosi, lo coprì con pelli di camoscio di gran valore, lo abbeverò con squisiti e corroboranti pozioni poi gli servì una zuppa calda.
Da sotto al suo cappuccio il poveruomo ringraziò Lopa, quindi si rivelò lei… era il capo tribù travestito che la celebrò insieme a tutta la comunità:
“Lopa è diventata buona!” urlava ognuno e da quel giorno tutti l’amarono.
In autunno molti animali cadevano in letargo, così la selvaggina diminuiva di numero e assai importante, per ogni cacciatore, era vantarsi di aver catturato una preda. Ognuno aveva le frecce del proprio arco, o le lance, adornate dai propri colori. Una volta ucciso l’animale si poteva così individuare chi l’aveva colpito. Quando si trattava di una grossa preda, colui che era possessore dei colori legati alle frecce o alla lancia, veniva festeggiato da tutti. Al rientro da quella caccia, quando ormai l’inverno si faceva sempre più vicino e la carne scarseggiava, venne portato un grosso bovino. Nel suo corpo, onorato da tutti per ringraziare lo spirito dell’animale, c’erano frecce contraddistinte da due colori, quelli del cacciatore Rin e quelli del cacciatore Bon. I due cominciarono a litigare e azzuffarsi. Non sentivano il bisogno di pace e correttezza che deve esistere in una comunità affiatata ma solo la voglia di primeggiare. Fu un brutto esempio per i giovani del villaggio che dovevano invece essere educati alla concordia.
Graz fu assai contenta nel vedere poi i due cacciatori fare la pace e la serenità tornare nel gruppo.
“Non prendete Rin e Bon a modello!” dicevano i più savi ai giovani e venne narrato:
NON RISPONDERE AL MALE CON IL MALE
Il fuoco del bivacco scaldava quella freddissima notte.
La tribù era riunita attorno alla fiamma che ardeva potente, ci si scambiavano pareri sul tempo e i vecchi narravano le loro antiche gesta per trasmettere la storia dell’umanità ai posteri.
Mentre con il volto illuminato dalla brace e dagli zampilli del fuoco il saggio della tribù faceva da cantastorie, due uomini cominciarono a litigare.
“Ti colpirò!” diceva uno agitando il coltello.
L’altro inveiva e mostrava i denti, quindi morse il compagno.
Di colpo, davanti a quella scena di cattiveria e aggressività, come per magia la fiamma si spense e il buio cadde attorno al bivacco.
La tribù venne presa da gran panico e si sentì una voce cavernosa dalla brace che disse:
“Non rispondete al male con il male, siate lieti e con il cuore aperto, godete con solidarietà di ogni circostanza e la fiamma non si spengerà mai !”
I due litiganti fecero pace. La fiamma repentinamente si riaccese, il calore tornò a scaldare la tribù infreddolita, non c’era più buio e ognuno comprese che non si sarebbe mai più dovuto litigare.
Nelle antiche leggende che venivano narrate, erano individuabili storie di dinosauri e periodi nei quali gli uomini ancora non c’erano. Si raccontava di tante vicende, fino a spiegare come nella valle si fosse formato il lago per lo scioglimento delle nevi.
In quei giorni si celebrava il rito di passaggio per gli adolescenti che divenivano adulti e potevano partecipare alla caccia. Essi venivano portati per una luna a purificarsi nel bosco poi si festeggiava la loro entrata nel gruppo degli uomini e non più bambini, passando una notte nella grotta gelida. Quando il sole nasceva a nuovo giorno, lo sciamano invocava gli spiriti e tutta la tribù si riuniva insieme. In quell’occasione si pensava anche ai giovanissimi, specialmente cercando di far comprendere loro il significato dell’anima, quello spirito vitale che secondo la fervente credenza dava spirito attivo ai corpi.
Ecco la favola che venne a spiegare queste cose a Graz e a agli altri piccoli:
URP NON VOLEVA PIU’ MANGIARE
Il giovane Urp non capiva l’ambivalenza di corpo e anima. Rifiutava le sue membra, si dannava e si strappava i bei capelli di tinta corvina.
“Non voglio più mangiare!” diceva, odiando le proprie mani e le sue gambe, il suo tronco e la sua faccia che vedeva riflessa in una lastra color dell’argento.
La tribù tutta era in gran pensiero per lui.
“Dobbiamo fargli capire che il suo corpo è sede della sua anima!” diceva lo stregone.
Non c’era verso di convincerlo a nutrirsi; gli offrivano carni saporite e fagioli pestati, frutti gustosi e tisane corroboranti ma lui non voleva ingerire nulla.
“Devi ringraziare gli spiriti che ti permettono di vivere, non puoi rinunciare a esistere!” lo supplicava la mamma.
La popolazione s’inginocchiò davanti al grande roseto selvatico che nasceva dalla roccia. I fiori vellutati e di color carminio intenso olezzavano soavi.
Ogni petalo era qualcosa di vivo e animato e si muoveva dolcemente mosso dalla brezza di sud. Un’aria calda cantò spirando tra le fronde e si udirono parole fatate rivolte a Urp:
“Il tuo corpo, Urp, è tempio della tua anima ed è un gran dono !” si udì pronunciare dal roseto.
Urp accettò i cibi caldi portati dalle donne della tribù. Da quel giorno capì che dentro di lui c’era una forza soprannaturale, come in ognuno di noi, che ci rende vivi e che è tanto importante.
“Curerò d’ora innanzi le mie braccia e le mie gambe, il mio corpo e tutto il resto, affinché cuore e mente possano essere pronti e accalorarsi alla vita!” disse Urp mentre tutti danzavano contenti.
La culla del genere umano, colà ove sono vissuti i primi uomini è l’Africa. Traccia di ciò si trovava anche nelle fiabe narrate dalle anziane donne a Graz e ai suoi compagni. A nord si sapeva degli enormi mammut, ma era sconosciuto l’elefante. Nelle leggende invece si parlava di questo grosso animale che nella savana era una gradita carne per gli antenati degli omonidi, i così detti Ramidus, che vivevano nella foresta, avevano già portamento eretto e pare siano alla base della nostra specie . I Ramidus incontravano spesso gli elefanti e da loro imparavano l’attenzione per i partecipanti al gruppo.
Ecco una favola sulla cura verso i fratelli narrata quella mattina di novembre nella grotta delle fiabe:
AL LAGO
Presso un antico lago, 4,5 milioni di anni fa, nell’Africa orientale, le piogge andavano diminuendo e la popolazione di Ramidus, abituata a dormire sugli alberi, via via si apprestava a prendere possesso delle pianure, ove trovava tuberi e raccoglieva altro cibo.
Bisognava difendersi dagli animali predatori, tuttavia c’erano anche tante specie delle quali non bisognava temere: gli ippotteri (antenati dei cavalli), gli impala, le scimmie e gli antilopi.
Al lago, per l’abbeverata comparvero quella volta gli elefanti. Era un enorme branco. I Ramidus si acquattarono dietro i sicomori per spiare questi grandi mammiferi.
I Ramidus non sapevano ancora vivere aggregati, ma avevano tanta voglia d’imparare. Gli elefanti si portarono tutti insieme a bere. Erano mastodontici, con le orecchie grandi che si movevano leste per scacciare le mosche e la lunga proboscide.
I più adulti si misero a spruzzare l’acqua sui piccoli per lavarli; alcuni, con l’udito e l’olfatto sviluppatissimo, stavano di guardia dai predatori, per avvertire gli altri se il pericolo si avvicinava, ma più di ogni altra cosa colpì i Ramidus la responsabilità di ogni elefante verso i propri fratelli, infatti tutti aspettavano i più anziani lenti nel camminare. I Ramidus non sapevano articolar ancora parole compiute ma si misero a urlare contenti per quegli atti di fratellanza e da quel giorno cominciarono a intendere l’importanza dell’unità di gruppo. Uno dei Ramidus prese un ramo duro, incise sulla sabbia due mani che si stringevano, primo simbolo di unione. Tutti si misero felici attorno alle mani segnate sulla rena esprimendo grande gioia.
La dieta della tribù prevedeva frutta e vari vegetali, legumi e cereali, ma soprattutto l’onnivoro homo habilis preferiva la carne ricca di calorie. Sulle mense si potevano vedere noci, radici, cipolle e diversi tipi di bulbi, tuttavia assai apprezzate erano carni di antilopi, lepri e altra selvaggina, mangiando per prime le interiora (fegato, cuore, reni e cervella). Passando dai coriacei cibi solo vegetali a quelli animali, le mascelle, con l’evoluzione, divenivano sempre più ridotte e in confronto ai primi ominidi la fisionomia si trasformava . Le donne ormai avevano imparato a cucinare. Si preparava la polenta in otri di pelle, si cocevano gli alimenti in grandi pentole poste su pietre roventi. Piano piano si scopriva come usare il frumento e tracce risalenti a quell’epoca hanno rivelato che già si sapeva fare il pane .
Ecco cosa ascoltò Graz quella volta riguardo al lievito:
UN PO’ DI BENE
“Ama!” diceva il nonno al nipotino.
Il piccolo però rispondeva:
“A cosa serve un po’ di amore in mezzo a tutta questa cattiveria?”
Al giovane non pareva importante mettere la propria goccia positiva, dato che il male imperversava su quei territori. Intorno il cielo era nero per la malvagità che imperava. Le montagne erano ricoperte di giaccio e ogni cosa era fredda e scura. I fiori non profumavano più, gli alberi si rifiutavano di dare frutti in punizione agli uomini intenti solo a fare la guerra.
“Ama!” ripeteva il nonno mentre la nonna cucinava il pane.
La nonna mise il lievito nella pasta, ne bastava poco per far crescere tutto il preparato.
“Vedi il lievito?” disse il nonno “Ne basta un poco per far lievitare tutto il pane, esso è come l’amore a volte è sufficiente un esempio di bontà per aiutare tutto il resto!”
Il giovane capì, provò ad amare, gli altri lo imitarono: il ghiaccio si sciolse per incanto, il cielo divenne azzurro, i fiori olezzarono soavemente e gli alberi cominciarono a regalare succulenti frutti.
Era tanto bella la valle mentre gli animali andavano in letargo e piano piano la terra veniva ammantata dalla coltre bianca della neve. Pochi uccelli volavano in cielo, raffiche di vento sferzavano i volti dei bambini, anche quella mattina diretti nel sottobosco in cerca di lamponi e ribes insieme alle donne:
“In ogni cosa c’è energia: nel volatile che usa le sue potenti ali; nel soffio dello zefiro, nei raggi di luce!” commentava l’anziana dai denti scuri. In tutto infatti c’era una forza incredibile: nel sole, nella pioggia. Era un’energia che si raccontava fosse incantata e che andava rispettata con il massimo ossequio.
“C’è energia nelle radici che scavano nel terreno. C’è energia nelle acque del torrente che scorrono con forza verso la pianura!” aggiungeva qualche donna rivolta ai fanciulli e indicando le acque che fluivano dalla pendice verso il basso.
I bimbi comprendevano e annuivano col capo, in segno di approvazione. Una volta giunti alla grotta, per l’ora della fiaba, mentre molti suggevano il latte e i più grandicelli come Graz assaggiavano bacche rosse e viola, venne narrata una fiaba:
L’UCCELLO DORATO
Tanti e tanti secoli fa volava nei cieli un uccello color dell’oro: re dell’aere. Le sue piume risplendevano illuminate dal sole e pareva tinto da fatate sfumature.
Era un mondo di pace e allegria, tutti comprendevano l’incanto del pianeta, rispettavano la giumenta col puledro, avevano cura per i fiori e per i frutti.
Gli occhi dei popoli erano capaci di vedere gli esseri invisibili e incantati, che non possono scorgere coloro che sono intenti solo a uccidere e far la guerra: si trattava degli uccelli fatati. Questo gruppo di volatili era guidato dall’uccello d’oro. Egli ordinava di punire chi oltraggiava l’ambiente ma era tanto buono nei confronti di chi si comportava bene.
“Fate diventare le acque chiare e fresche!” diceva l’uccello d’oro alle colombe per premiare la tribù riverente verso piante e animali.
Così le colombe facevano cadere un paio delle loro piume candide sulle acque e queste da scure diventavano trasparenti e piacevolmente fredde.
“Coronate la foresta di frutti e funghi!” proferiva l’uccello d’oro e i passeri facevano in modo che dai pini nascessero belle pigne color marrone scuro con enormi pinoli, more eccezionali nei rovi, funghi d’ogni tipo accanto ai muschi.
Il tempo poi passò. Gli uomini cominciarono a disboscare senza ritegno per costruire le loro capanne. Cacciarono uccidendo madri e cuccioli, nessuno apprezzava più il pianeta.
L’aria divenne scura e nessuno fu mai più capace di vedere l’uccello d’oro e i suoi accoliti: solo chi era capace di vivere la dolcezza e l’energia della Terra poteva scorgerlo, erano soprattutto i bambini puri e col cuore pulito.
Le donne portavano sulla testa grosse gerle di vimini e raccoglievano gli ultimi cereali selvatici della stagione. Sulla montagna si vedevano galoppare bei cavalli non addomesticati e cervidi dai palchi enormi. I cacciatori stavano pedinando un gregge di capre, non si era ancora capaci di allevarle ma già si controllavano gli armenti dirigendoli in radure per poter disporre così di sicure prede.
Nella tribù ognuno svolgeva il proprio compito con solerzia e impegno. Non c’erano divisioni in censi o caste e come esempio si narravano fiabe sui fiori:
LA VERA REGINA
Vicino alla grotta litigavano gli uomini di quell’epoca, con clave in mano si minacciavano:
“Io sono il più forte e devo comandare!” diceva uno basso ma possente.
“Guarda che muscoli: sono io il capo!” ribatteva un altro.
Continuavano a scontrarsi dividendo la tribù in ranghi diversi.
Sopra all’ingresso alla grotta, abbarbicato sulla roccia, stava uno splendido roseto selvatico.
“Noi non siamo divise in gruppi!” diceva la rosa gialla: la tea.
Un fiore vellutato, una comune rosa canina, dai petali rosa, faceva d’appoggio alla vicina, una rossa corolla più delicata.
Non c’erano alterchi tra le rose.
Ogni petalo amava gli altri petali.
Il cespuglio di rose viveva in gran concordia e per questo riusciva a crescere tra i sassi con eccezionale forza. I fiori esultavano tutti insieme davanti al sole o benedicevano in fratellanza la caduta della vivificante pioggia.
“Non esistono tra noi censi o gruppi sociali!” andavano fiere le rose.
Infatti fra tutte la più generosa era la regina: una stupenda rosa del Bengala. Ella si dedicava a curare le altre, primeggiava per l’altruismo: proteggeva i germogli parandoli dal vento; con la sua corolla grande faceva da ombrello ai rami nascenti e cacciava gli insetti nocivi dai rami delle altre. Ecco qual era la vera regina, colei che più delle altre sapeva offrirsi al prossimo.
E grazie a questo spirito di solidarietà e accordo, senza capi e sottomessi, il roseto profumava splendidamente e le sue sfumature creavano effetti dalle tinte soavi.
All’inizio dell’era postglaciale, definita dagli studiosi con il termine di olocene (10mila- 8mila anni fa), gli uomini del mesolitico si adattavano alle trasformazioni dell’ambiente , alla ricerca dell’equilibrio con la natura. La vita delle tribù dipendeva dagli spostamenti degli animali, dalle piene dei fiumi, dalla possibilità di raccogliere frutti. Tanti erano i riti propiziatori che si compivano prima di ogni caccia. Si rappresentavano nelle grotte, con graffiti, i grandi animali dell’epoca, si seguiva lo sciamano nel cantare e pregare, si scolpivano sculture d’osso o si inscenavano catture e uccisioni di prede. Grande era però l’umiltà con cui gli uomini si comportavano, infatti consideravano ogni aspetto del pianeta da rispettare e venerare.
“Vi sono gli spiriti buoni della montagna e del fiume che ci guardano sempre! Vi sono anche gli spiriti protettori delle prede che cacciamo!” raccontava lo sciamano al popolo. Fu lo stesso stregone del villaggio che quella volta narrò una favola nella grotta delle fiabe, mentre gli adulti raffiguravano teste di cervo con bei dipinti rupestri nella volta della caverna.
IL CACCIATORE
Giak era un ardito cacciatore, non aveva paura di niente e portava al villaggio tanta carne.
Si trovò quella mattina a seguire le tracce di una cerva. Dietro alle orme della cerva, s’intravedevano piccole impronte di un cerbiatto. Era obbligatorio rispettare ogni mamma col suo cucciolo, eppure Giak, preso dalla brama di uccidere non desistette dalla ricerca.
“Voglio colpire con la mia lancia cerva e cerbiatto!” diceva tra sé, fermandosi di tanto in tanto per mangiare un pezzo di carne essiccata e recuperare le forze che via via andavano scemando. Non pensava alla deferenza che ci voleva nei confronti degli animali. Vagò per giorni continuando nella famelica caccia, quando le energie cominciarono a venir lui meno. Iniziò ad aver freddo. Gli occhi gli si chiusero mentre perdeva i sensi e una serie di spiriti protettori degli animali lo portò in un antro. Accanto a lui disegnarono in ocra rossa e gialla immagini di volti arrabbiati con gli occhi grandi, poi uno degli spiriti protettori si mise in attesa del risveglio di Giak.
Trascorsero tre giorni e tre notti, quando il cacciatore si destò. Era impaurito, vedeva dipinti sulle pareti di roccia volti con occhi grandissimi che lo fissavano.
“Cosa sono?” chiese Giak.
“Sono questi gli occhi degli dei della caccia che non vogliono che i cacciatori sterminino i cuccioli con le loro madri. Occhi di questo tipo ti guardano ogn’ora!” disse lui lo spirito protettore della natura.
Giak da quel giorno non inseguì mai più madri con cuccioli, sapeva che lui non li vedeva ma per gli occhi degli dei della caccia non c’erano segreti.
L’abbigliamento, in quell’epoca, andava cambiando assai. Esso non aveva certo l’importanza estetica della nostra era, tuttavia, essendo meno rigido il clima, si cominciava a pensare anche all’aspetto. Si usavano belle e colorate piume per adornare le fogge degli abiti; s’impiegavano materiali vegetali d’ogni sorta e le donne si adornavano con pendagli e collane ritrovate recentemente nelle tombe, per lo più composte di denti di cervo o minute conchiglie . Compito di cucire vesti, scarpe e copricapo era femminile. I bambini passavano aghi d’osso e strumenti per incidere pelli di camoscio e tagliare velli. Intanto le donne narravano fiabe come quella che segue, ispirata al coraggio.
Ecco cosa ascoltò, assorta e colpita dal racconto, la nostra piccola Graz una volta:
IL CORAGGIO
Ron era ragazzo gagliardo e aitante. Nel suo animo viveva un sentimento di amore e fratellanza che lo induceva a compiere generosamente ogni atto, pur di aiutare i bisognosi. Il capo del villaggio era cattivo e se ne approfittava degli indigenti.
“Voglio sconfiggere il capo!” decise Ron e si recò nella capanna dello sciamano.
“Come posso trovare il coraggio per sopraffare il capo?”
“Dovrai andare a mezzanotte nelle tombe e prendere una costola dallo scheletro della famosa donna nera! Poi compiremo le magie adatte!” disse lo stregone.
Quando giunse la notte, particolarmente fredda e scura, Ron si mise sulle spalle una pelle di daino e tremando per la bassa temperatura, si avviò alla tomba sotterranea. Lì erano sepolti tutti i predecessori della tribù. In un antro, lontana dagli altri, stava la nicchia ove si trovava lo scheletro della donna nera, tanto cattiva e malvagia. Una serie di pipistrelli sorvegliavano la nicchia ed essi si gettarono tosti sulla testa di Ron. Egli si coprì il cuoio capelluto nascondendolo sotto la pelle di daino. Non vedeva più niente. Sentiva i ghiaccioli pendenti dalle volte del soffitto sfiorargli le spalle, mentre il vento ululava fuori e provocava una mestissima melodia. La paura lo stava per assalire. Scavò un poco con i palmi delle mani e sentì subito le ossa della donna nera. Pensava ai racconti uditi su questa donna tanto perfida e temuta. Si narrava che il suo spirito continuasse a vagare presso le tombe portando malefici e dolore.
Intanto si scatenò un temporale violentissimo. Persino la monotona civetta cessò di cantare e si udirono tuoni che là sottoterra pervennero come devastanti deflagrazioni.
Ron tastò le costole dello scheletro e ne prese una.
C’era riuscito. Sgaiattolò fuori sotto al pioggia e tornò al suo giaciglio. Attese la mattina e portò la costola allo sciamano.
“Ora ho la costola, ma come farà a darmi coraggio?”
“Non hai bisogno di magie e sortilegi, ora che hai osato prendere questa costola sai già di avere abbastanza coraggio per affrontare il capo!” e fu così che Ron si diresse alla grotta del capo per allontanarlo per sempre e portare la pace la giustizia nella sua tribù.
Nell’anfratto di un grosso albero, proprio dirimpetto alla collina ormai innevata che si trovava vicina al fiume, gli uomini della tribù mesolitica erano già capaci di allevare api. Gli alveari, all’inizio della stagione fredda, si preparavano al riposo invernale, tuttavia c’era da raccogliere il miele prodotto, c’era da conservare la cera e già si sapeva sfruttare, anche se in maniera primitiva, la propoli.
“Disegniamo nella grotta il lavoro delle api!” propose un facente parte il villaggio. Uomini e donne cominciarono la loro opera rupestre.
Qualcuno raffigurò la bella ape regina, ma i più decisero di disegnare l’ape operaia, non bella come la sovrana, ma assai notevole per il cuore e l’ardore con i quali si dedicava al benessere della comunità.
Graz guardava tutte quelle creazioni sulla roccia bianca della caverna calcarea. Era vero: le api operaie non erano le più belle, tuttavia qualcosa di particolare le contraddistingueva e apparivano davvero stupende, più della regina dal bell’addome sottile e giallo e nero.
“Che belle le operaie!” esclamò Graz.
“Infatti non è solo l’aspetto che conta per ben apparire!” disse una delle anziane che poi narrò:
BELLI NEL CUORE
Quella notte, mentre un fantastico disco d’argento, che era la luna, si stagliava in mezzo al firmamento e illuminava le ore di veglia, la tribù celebrava la più bella del villaggio.
C’erano giovani decorate con collane e pietre rare.
Alcune danzavano accompagnate dal tamburo, altre mostravano le loro chiome ondulate e morbide.
“Sono assai attraenti!” commentavano i giudici della gara di bellezza.
Da una parte stava Anas, una ragazza tanto brava e gran lavoratrice. Ella aveva trascorso la giornata a curare i bambini del villaggio e non aveva avuto tempo di indossare le calzature per la festa né dei vestiti per partecipare alla gara. Tra canti e balli la festa continuò e Anas se ne stava sempre esclusa dalla celebrazione.
“Perché non partecipi?” chiese il capo tribù alla ragazza tanto alacre e buona.
“Io non mi sono potuta preparare e non sono bella come le altre!” rispose Anas.
D’un tratto il buio calò sulla sabbia ove le belle donne si esibivano. Un raggio di luna si diresse sul campo tra le tenebre e andò a illuminare la buona Anas.
“Sei la più bella!” cominciarono a urlare tutti vedendola risplendere.
Il capo tribù intervenne dicendo:
“Chi è bello nel cuore è bello anche fuori, qualunque sia il suo aspetto!” e la gara di bellezza fu vinta proprio dalla nostra Anas.
Un’attenzione particolare va posta in riferimento all’uso dello spazio, cioè degli insediamenti ove le preistoriche tribù convivevano e dividano tempo e attività. Nella tribù di Graz, per esempio, erano parecchie le grotte entro le quali ci si riuniva, o per lavorare o per relazionarsi. C’era la caverna dei cacciatori, quella delle cucitrici di pelle, quella delle favole. Era un ventoso giorno, mentre erano diretti ai loro magazzini i pescatori: imbacuccati sotto a calde pelli di ghiottone, per proteggersi dai soffi dello zefiro.
Non si vedevano nemmeno i volti.
“Anch’io vorrei incappucciarmi, così nessuno mi scoprirebbe!” disse Lulo, uno dei monelli della combriccola di giovinetti.
Allora venne raccontata una fiaba collegata a quella frase:
MASCHERARSI
Un gran rimorso assaliva il cuore di Ural, un malvagio uomo che spargeva terrore presso pianure e montagne roteando una lancia.
La gente scappava nel vederlo.
Lui allora decise di mascherarsi:
“Userò frasche per coprirmi il viso e indosserò una pelle nera!” disse e provvide a coprirsi con un manto scuro e una serie di fronde che celavano i suoi lineamenti e nascondevano la sua corporatura.
Per un po’ di tempo parve che la trovata funzionasse, ma dato che lui continuava a spargere terrore, cominciò a girare la notizia che un essere coperto di nero e frasche se ne andava a portare la morte per i villaggi.
Così, sebbene lui pensasse di essere occultato al prossimo, tutti riconoscevano la sua figura e scappavano.
Appena Ural si muoveva verso una tribù, questa si traeva in salvo e a nulla servì provare a coprirsi con nuovi mascheramenti.
Ural se ne stava chino davanti alla Grotta del Pensiero e cominciò a riflettere. Iniziava a detestare quella sua condizione di essere spregevole e cattivo e si chiedeva perché. Su un lato dell’apertura della grotta cresceva un bel gelsomino, dal quale si levò un esserino minuscolo, facente partì del popolo magico degli gnomi e dei folletti.
Esso disse a Ural:
“Ci si può coprire con abiti e pelli, ma le vesti non nascondono l’anima!”
Furono parole importantissime, che scossero Ural, il quale si decise a cambiare totalmente la sua vita. Mai più se andò in giro portando terrore, scelse invece l’amicizia. Cessò per sempre di mascherarsi… non ce n’era bisogno e a nulla serviva.
Gli abiti non possono nascondere infatti la cattiveria dello spirito.
Descrivere una società dell’era mesolitica è assai coinvolgente. Si deve parlare dell’unità di gruppo, si possono sottolineare i momenti di convivenza: le preghiere agli spiriti presso la capanna dello sciamano, contornata da sculture in legno e primordiali totem rappresentanti donne grasse e opulente in segno di fecondità; le riunioni dei cacciatori prima di partire alla volta della foresta; le relazioni tra madri e figli.
Tuttavia, quando la mattina il gruppo delle donne e dei fanciulli si dirigeva a raccogliere lamponi e ribes, o radici e tuberi, non tutti i bambini volevano partecipare alla ricerca:
“Bisogna lavorare l’uno per altro, affinché tutto il popolo possa godere del benessere!” fu detto quella volta dalle mamme, che poi narrarono nella grotta delle fiabe:
IL VILLAGGIO DELL’EGOISTA
C’era una volta una valle ridente, amena per i gai colori che la tingevano, il cielo sempre terso e i profumi della resina di pino che venivano dal bosco.
Il popolo della valle viveva in gran concordia e armonia.
I cacciatori portavano la carne cacciata durante il giorno e la mettevano a disposizione del gruppo.
“Noi abbiamo pescato tanto pesce!” arrivavano lieti i pescatori con le reti colme di salmoni e anguille. Anche i prodotti ittici erano divisi equamente. Mentre cacciatori e pescatori lavoravano sotto al sole, intanto gli anziani si preoccupavano di dirigere gli animali che si andavano addomesticando presso i recinti rudimentalmente costruiti. Le cucitrici trapuntavano e usavano gli aghi d’osso, le cuoche scaldavano le pentole sui ciottoli arroventati: tutti insomma cooperavano. Solo Pig se ne stava da una parte.
“Io sono pigro e non mi va di cercare frutti o raccogliere funghi per gli altri!” diceva lui in maniera egoistica. Pensava solo al piacere individuale, senza aver nessun pensiero per il gruppo.
Il capo del villaggio era un gran saggio.
“Vieni alla mia capanna!” disse a Pig invitandolo con un bel sorriso.
Pig come al solito chiuse il suo ricovero di paglia e giunchi, sempre preoccupato che gli altri usassero le sue cose.
Il capo offrì una tisana di malva addolcita di melassa a Pig e poi lo portò dietro alle dune di sabbia che si trovavano nel lato sud del villaggio. Lì era pieno di formiche. Si vedevano questi minuscoli esseri lavorare tutti insieme.
“Vedi? Ci sono nel formicaio i magazzini per il cibo; si vedono le stanze delle larve per far crescer le nove generazioni. La formica è un animale sociale.” Ogni imenottero viaggiava veloce con le antenne e l’addome caratteristico diviso in tre parti. Pig le vedeva laboriose e impegnatissime. Alcune formiche si univano per portare grossi semi, altre in gruppo stavano di guardia ai magazzini.
“Pensa cosa accadrebbe se ogni formica pensasse solo a sé stessa: bisogna prendere esempio da loro!” disse il capo .
Pig aprì finalmente gli occhi e decise di unirsi agli altri e partecipare fattivamente ai lavori del villaggio.
Seppur lentamente, gli uomini andavano evolvendosi nelle manifatture e mutavano le loro attività. I pescatori avevano scoperto come poter usare le corna di cervo a mo’ di arpione, non ci si limitava più a cacciare, ma si cominciava piano a piano a fare i pastori e allevare gli armenti. Come risulta dai disegni, non si considerava più l’animale solo in base all’occhio del cacciatore, anche se per adesso era addomesticato del tutto soltanto il cane. I quattro zampe erano ormai infatti, abitanti dei villaggi, buoni coi bambini, compagni di chi andava alla ricerca di selvaggina, fedeli guardiani.
Era tanto bello per Graz coccolare il cane della capanna dell’anziana Monna. L’animale aveva occhi azzurri e pelo nero e grigio, con un dorso possente e il petto ampio: diretto discendente del lupo.
“Più di tanti oggetti e ricchezze, il regalo più bello che possiamo fare a un bambino è quello di donargli un cane, tanto è l’amore che può nascere tra i due!” dicevano le donne nella grotta delle fiabe.
“Io preferirei tanti giocattoli!” disse la piccola Graz mangiando le castagne, frutto di quella stagione.
“La vera gioia, quella che si sente nel cuore, non è qualcosa di materiale!” risposero le donne e raccontarono una fiaba:
LA VERA GIOIA
Il capo tribù era triste.
Il popolo si dispiaceva assai di questa condizione del capo, vedendolo sempre mesto e angosciato.
“Facciamo qualcosa!” decisero di buon grado e tutti partirono alla ricerca di doni che potessero dare materiale gioia all’uomo tanto malinconico.
“Guarda che bell’avorio!” si presentò un componente la tribù innanzi al capo addolorato, ma l’avorio regalato non portò sollievo alcuno all’animo sempre più abbattuto della persona più importante del villaggio.
Una donna portò una lesina:
“Te la reco come strenna!” disse ella, tuttavia neanche ciò produsse risultati.
Furono portate pietre preziose e poi abiti stupendi, calzature da caccia e conchiglie pregiate.
Il capo continuava a essere tanto addolorato. Aveva cose da toccare e vedere ma il suo spirito era ogni ora più depresso.
Si alzò ed uscì dalla bella capanna di comando; un bambino biondo e con gli occhi color del cielo terso, gli andò in contro:
“Ti voglio tanto bene capo!” disse con la sincerità del suo cuore puro.
Il capo sorrise e gli passò il dolore. Non erano stati oggetti o cose a renderlo felice.
“La felicità non è un corpo e non la si vede con gli occhi, né la si può toccare con mano : la vera gioia è quella che un gesto o una parola d’amore fanno sentire nell’animo!” commentò il capo, mentre tutti danzavano in segno di festa, contenti che la loro guida fosse tornata a sorridere.
Una cosa singolarissima, inerente ai popoli del mesolitico, sono i ritrovati in molte grotte, di pietre dipinte di rosso e nero con incisi dei segni assai simili a lettere dell’alfabeto . Secondo i più esimi studiosi, si tratta di una specie di bolle d’accompagnamento, che venivano unite a carichi di ciottoli, legna, derrate alimentari o mattoni d’argilla. Rimaniamo stupiti davanti a ciò, ma per i bambini come Graz era normale assistere alla preparazione di queste pietre. Si vedevano gli addetti operare sui piccoli sassi e farne poi l’uso che era a essi destinato. Erano un po’ gli scribi dell’era preistorica.
“Anche io da grande voglio dipingere i ciottoli!” sognava uno dei piccoli, pensando che d’adulti si può fare ciò che ci pare.
“Vivi con gioia la tua età, è il momento più puro e più bello!” gli dissero dolcemente le donne nella Grotta delle Fiabe per poi narrare:
ALLA RICERCA DELLA GIOIA
Il puledro galoppava allegro per i prati. C’erano fiorellini gialli e lui di tanto in tanto li assaporava insieme al trifoglio, poi si metteva col musetto dietro alla coda della mamma e si faceva scacciare le mosche; quindi ripartiva sgroppando di gioia e si metteva a nitrire verso i pini del bosco. Allora uno stormo di passerotti volava verso di lui al suo richiamo.
“Come stai puledrino?” gli chiedevano.
Un giorno lui rispose un po’ turbato:
“Voglio galoppare e galoppare, per diventare uno stallone e trovare finalmente la gioia!”
I passerotti, scorgendo tutto dall’alto, hanno una visione assai chiara delle cose e narrarono:
“Gli stalloni continuano a galoppare anche loro, alla ricerca della felicità. Muovono passi lunghi a grandi falcate, attraversano pianure e sono capaci di valicare alti monti con la loro muscolatura possente. Cosa è che li porta a cercare in siti remoti e a continuare a galoppare? E’ la memoria di una gioia lontana: quella che hanno vissuti da puledri quando c’è la mamma accanto a darci amore e scopriamo tutte le cose belle e colorate attorno a noi: quindi tu non sognare il giorno in cui sarai adulto, ma vivi con estrema letizia questo periodo della tua vita!”
Il puledrino mosse il collo magro in segno di aver compreso. Nitrì forte indirizzando il suo richiamo alla giumenta sua madre: era davvero bello essere giovani, ammirare il cielo, provare l’ebbrezza delle prime esperienze, giocare e ridere con gli altri puledrini; una vera gioia.
Alla base della vita, per i popoli di quell’epoca, c’era lo scambio. I giovani partivano con conchiglie e penne d’uccello e barattavano ciò con arpioni e pelli. Nello scambio si trasmettevano, tra l’altro, anche saperi e conoscenze.
Dal fiume tornarono sulla canoa fatta nel tronco dell’albero più grande, i ragazzi che erano andati a barattare con il popolo del Sole, che viveva dalla parte ove l’astro del giorno nasceva.
“Il capo tribù del popolo del Sole è un gran tiranno!” commentavano tutti sdegnati. Nella Grotta delle Fiabe si raccontò:
IL CAPO
Al centro del villaggio stava a dar ordini il tiranno. Si sentiva potente e forte.
“Picchiate con la clava i poveri!” urlava ai suoi servitori.
Imponeva su ogni cosa la sua volontà cattiva e credeva di essere superiore a tutti.
Gli artigiani producevano ceramiche e lui se ne appropriava, le cuoche cucinavano ed egli s’impossessava delle vivande.
“Voglio andare a zonzo esibendo ciondoli e ornamenti!” impartiva comandi, così i cacciatori, anziché procurare quanto utile al fabbisogno del villaggio, dovevano andare alla ricerca di pietre utili per rendere più belle le collane del capo.
Si presentava addobbato e guarnito di fregi, con pelli colorate e ricamate finemente.
A ogni cosa metteva davanti l’apparenza e il suo bell’aspetto, continuando a comandare a destra e a sinistra senza rispetto alcuno della dignità del popolo. Tuttavia, dall’alto delle stelle, i sapienti lo vedevano. Erano gli spiriti di tutti coloro che con giustizia e rettitudine avevano guidato i popoli alla crescita e al benessere. Una nuvola bianca si posò sopra alla ricca capanna del capo. Apparve lui un fatato volto, coi capelli canuti e rughe sulle gote, segno di anni e anni di esperienza. Il volto disse al tiranno:
“La tirannia non ha valore: nel regno dei sapienti non signoreggia la sapienza, ma il cuore !”
Il capo tribù rimase basito da quell’apparizione, si vergognò assai di sé stesso e da quel giorno divenne umile, magnanimo e generoso.
Gli abitanti delle valli mesolitiche pensavano anche all’aspetto. Si decoravano con piume di pavone, portavano adornamenti alle caviglie e tenevano a decorare faretre e borracce. Non bisognava però pensare solo all’aspetto, infatti a Graz e agli altri piccoli quella mattina fredda, davanti al fuoco si narrò nella Grotta delle Fiabe:
FARSI AMARE
Imo desiderava farsi amare da tutti gli altri e ciò era naturale, chiunque apprezza la stima e la benevolenza del prossimo. Egli, tuttavia, percorreva strade che portavano a mète diverse, voleva mettersi al centro dell’attenzione esibendo collane e fregi preziosi.
“Cercherò conchiglie pregiate!” disse in quella mattina piena di sole, così mentre tutti lavoravano per il bene della tribù, lui se ne andava tutto solo sulla riva del mare a cercare conchiglie.
Aveva ormai percorso un lungo tratto dell’arenile deserto.
Si vedevano solo le sue orme sulla sabbia chiara. Il vento era lieve e il profumo salmastro era accompagnato dal rumore dello sciabordio lento delle onde. Trovò tante conchiglie. Imo si adornò da tutte le parti:
“Sono bello e mi dovranno amare!” diceva tanto soddisfatto.
Raccolse altre conchiglie per tutto il giorno meditando tra sé e sé:
“Sono stato capace di adornarmi e mi stimeranno!”
Giunse la sera. Ognuno procedeva verso il centro del villaggio per portare quanto raccolto, da dividere con il prossimo.
C’era chi aveva nel carniere la selvaggina cacciata, c’era chi recava succulenti frutti o radici. Le donne avevano raccolto piante da offrire dopo aver preparato tisane. Tutti avevano qualcosa da spartire a prò del popolo.
Avevano i vestiti lisi e le mani callose, ma tanta bontà nel cuore.
Imo si avvicinò ai compagni tutto fiero e continuando a pensare:
“Loro non sono belli e nessuno li amerà, non sono ricchi e nessuno li apprezzerà!”
Si esibì vantandosi, ma anziché tributare onore a lui, i compagni osannarono Peplo, in quel momento ancora evidentemente in disordine, dopo l’eroica caccia al bisonte. Peplo aveva dedicato tutto sé stesso e rischiato assai, per procurare cibo al suo popolo. Non aveva bell’aspetto né conchiglie a decorargli il collo; non era insomma bello… eppure tutti lo amavano.
Con ossa e corna, selce, vetro e ambra si producevano vari strumenti: coltelli e rasoi, ma anche spille e monili.
Coi rasoi gli uomini si radevano la barba, tenendo assai all’ordine. Graz aveva assistito tutta la mattina gli artigiani creare stupendi rasoi a luna, con il manico d’osso.
“Ma come fanno a essere così bravi?” domandò Graz davanti a quegli artigiani che operavano con solerzia e attenzione.
“Bisogna scoprire le proprie caratteristiche. Ognuno ha delle peculiarità personali, che lo rendono unico e irripetibile e proprio voi giovani dovete cercare di comprendere di quali positività ciascuno di voi è portatore!” dissero le donne che poi narrarono:
IL VILLAGGIO BELLO
C’erano sulle colline verdi e profumate due villaggi.
“Noi siamo la tribù più bella!” dicevano quelli del villaggio più basso. Lì non si pensava però a ricercare le qualità di ognuno, così il barbiere faceva il muratore, il cacciatore faceva il cercatore, le mamme facevano da cacciatrici e gli uomini volevano allattare.
In questo villaggio era un gran caos. Nessuno agiva in base alle proprie caratteristiche. Tutto era confusione e nessuno riusciva a portare positività per il bene comune.
Il villaggio che stava in alto, all’opposto, anziché andare tronfio e pavoneggiarsi, pensava solo a scoprire le capacità di ognuno. Il barbiere radeva i peli dai volti, le mamme facevano le mamme, i cacciatori andavano a caccia e chi era adatto a raccogliere raccoglieva.
In questo villaggio, nel quale ognuno era capace di scoprire le personali caratteristiche tutto era bello: le case ben costruite, il fuoco pronto per cucinare, la carne sempre a disposizione del popolo. C’era grande armonia e tutto era perfetto, vivendo in coesione ed eccezionale concerto.
Intanto nel villaggio nel quale nessuno cercava di conoscere sé stesso, tutto era una mescolanza disordinata.
Un’aquila si fermò sul picco che si stagliava sulla valle. Il suo rostro magico indicò al villaggio disordinato, di stare a osservare i vicini.
Tutti guardarono coloro che erano intenti a scoprire le proprie capacità per poter trovare il mestiere e il compito giusto.
Finalmente quelli del villaggio in confusione capirono, cominciarono da quel giorno a cercare di conoscere sé stessi, così ognuno capì cosa doveva fare. In breve anche quel villaggio divenne lieto e sorridente, perché tutti riuscivano a fare bene la propria parte.
Una roccia nera, chiamata ossidiana, veniva lavorata per produrre vari oggetti. L’ossidiana ha aspetto vetroso e serviva per ottenere molti accessori. Precisamente tale materiale si origina col raffreddamento delle lave, pertanto la si raccoglieva vicino ai crateri, dei quali l’Italia centrale e meridionale erano assai ricche, ma mancavano al nord, essendo ormai spenti da milioni di anni le bocche dei Monti Berici e dei colli Euganei.
Si facevano anfore, bricchi, utensili per la cucina, ma bisognava procurarsi la materia prima percorrendo l’Appennino, fino a raggiungere i Monti Volsini, la Tolfa, oppure il Monte Amiata.
Proprio quel giorno tornò da tale viaggio un gruppo di raccoglitori di ossidiana. Narrarono delle belle cose viste e scoperte durante il percorso, si raccontò di incontri strani, animali diversi e fiori mai veduti.
Graz e gli altri bambini ascoltavano esterrefatti, immaginandosi cose bellissime da poter osservare; gli anziani e le mamme però, volevano loro insegnare che la vera bellezza va oltre l’aspetto e la favola di quella giornata era proprio legata a tale argomento:
IL FIORE CHE AMAVA
C’era una volta un giardino magico. In esso olezzavano fiori dagli sgargianti colori. Il bambino voleva raccogliere i petali più belli da portare alla mamma.
“Quale sarà il fiore più attraente?” si chiedeva il piccolo toccando i virgulti vellutati, inspirando i profumi dolci, godendo di quella vista allegra e affascinante.
C’erano viole, rose selvatiche e gigli bianchi.
Il giglio bianco era piccolo ma qualcosa di magico lo faceva svettare su tutti: simbolo di purezza.
“Io sono testimone di candore!” disse con umiltà il giglio bianco. Gli altri fiori ostentavano grandi foglie, altri si arrampicavano con le loro radici avventizie su per i tronchi dell’albero, altri ancora manifestavano la loro bellezza con boria e prosopopea. Il giglio bianco invece continuava a parlare con il piccolo, usando modestia e semplicità e con misura.
Le tinte delle orchidee e la fragranza del gelsomino invitavano, tuttavia il giovane venne colpito da quella limpidezza del giglio bianco che emanava tanto amore e buon cuore.
“La bellezza non è solo in ciò che si vede, è soprattutto nei cuori !” pensò il bambino e tra tulipani gialli e rossi e ciclamini, scelse la bontà del giglio bianco. Lo portò alla mamma ed ella ne fu entusiasta. Dai petali nivei traspariva tutto l’affetto che il suo piccolo serbava in cuore per la madre.
La bellezza va oltre i volti, la si scopre nell’animo.
Fondamentale, per l’uomo di diecimila anni fa, era riuscire a scegliere il luogo adatto dove vivere, era infatti l’ambiente a offrire la possibilità di vivere, con gli animali, l’acqua e le piante mangerecce. Il sito per la stagione fredda, della tribù di Graz, era piuttosto ameno e ricco. Nella conca della valle si estendeva una pianura nella quale sorgevano sul lato di levante molti alberi, tra i quali i cacciatori potevano procurare selvaggina. I mari stavano acquisendo la conformazione attuale, mentre le nevi continuavano a sciogliersi. Gli insediamenti umani cercavano di sfruttare ogni risorsa, come bacche, frutti ed erbe, ma occorreva rispettare assai la natura.
Per affrontare le difficoltà relative alla vita ci voleva tanta saggezza.
“Bisogna sempre riuscire ad agire uniti, con amore e deferenza verso le prede, il verde e l’habitat.!” dicevano gli adulti. Si educavano i fanciulli alla ricerca continua del bene rispetto al male, pertanto si raccontò nella grotta delle fiabe:
L’ALBERO DELLA CONOSCENZA
Il nutrimento del popolo dipendeva all’epoca, soprattutto dalla raccolta di frutti e piante. Nell’oliveto si appropinquava anche quella mattina la raccoglitrice Beba, una donna tanto laboriosa e alacre. Pure quella volta aveva la gerla di vimini colma di drupe verdi.
Mentre procedeva a radunare frutti, sentì un grande albero, dalle qualità magiche, sibilare mosso dal vento. Era uno zefiro dolce, quello che cullava le fronde di quell’enorme pianta. Sui rami stavano appollaiate belle tortore color caffé e latte.
“Esprimi un desiderio!” dissero le tortore per premiare la laboriosità di Beba. La donna tremava d’emozione. Era davanti a una manifestazione della bontà dell’ambiente, di fronte a chi lo rispetta e ha deferenza nei confronti del territorio. Beba mise le mani nella sacca che si portava sempre dietro e trasse da essa una statuetta rappresentante madre Terra. Era una piccola scultura d’osso e selce che raffigurava una donna prosperosa, simbolo di fecondità. Rivolta alla statuetta ringraziò per quel prodigioso evento, poi cominciò a pensare cosa poter chiedere.
“Puoi domandare ricchezze e grandi cose!” dicevano lei le tortore.
Per un attimo Beba pensò ad avere una grande casa, tante conchiglie da barattare e abiti preziosi, poi però i suoi pensieri vennero interrotti del robusto tronco che disse:
“Io sono l’albero della conoscenza!”
Allora Beba espresse il suo più intimo desiderio:
“La ricchezza delle ricchezze, oh Albero della Conoscenza, è quella di riuscire a distinguere il bene dal male: per cui io ti chiedo di regalarmi la saggezza, la sapienza e la bontà di cuore!”
“Dicendo queste parole dimostri d’essere degna di tale dono!” rispose l’albero e la capacità di distinguere il bene dal male venne regalata a Beba che da quel giorno visse in piena gioia, certa di custodire nell’animo la più grande ricchezza: quella di riuscire a distinguere ciò che è brutto e cattivo dalla mansuetudine e la mitezza.
Nel periodo intermedio dell’età della pietra, ormai le comunità divenivano sempre più importanti e fondamentali. L’educazione dei giovani era basilare. Prima di tutto i ragazzi dovevano divenire coraggiosi e appena superata la fanciullezza compivano lunghe trasferte per imparare a dormire fuori e riuscire a comprendere l’arte della caccia. Fondamentale era che tra i componenti la tribù ci fossero tanta amicizia e tanto amore. Il più amato non era il più ricco ma colui che metteva a disposizione di tutti le proprie gesta.
Per aiutare i giovanissimi a capire quanto l’amicizia e l’amore siano importanti si narrò nella grotta delle fiabe:
IL FALCO CHE NON TROVAVA LA STRADA
Messer il falco vagava pieno di accidia e malevolenza verso il prossimo, cercando una tanto anelata strada.
“Voglio trovare la strada!” disse senza alcuna volontà di agire dabbene.
Messer falco era un rapace stupendo, dal becco ricurvo e forte, dotato di lunghi artigli, con un bel piumaggio scuro, color antracite sul dorso e chiaro sulla parte anteriore.
Volò e volò in cerca della strada, percorrendo i cieli col freddo e con il caldo. Da abile predatore sapeva cacciare, ma aveva carattere troppo irruento e prepotente, non condivideva mai nulla con nessuno.
Procedette per l’aere immensa, ma la via era difficile e spesso inciampava o perdeva l’orientamento. Era assai duro, tuttavia egli non voleva sapere di comportamenti amorevoli, amicizie o legami con alcuno: era egoista e cattivo.
Un giorno trovò una compagna. I due costruirono un bel nido sugli scogli, ma messer il falco pensava solo alla sua strada e voleva andare avanti senza pensare alla covata.
Non guardò le nuvole scure né il cielo annebbiato, voleva continuare a pensare solo a sé.
“Io mi occuperò dei piccoli, tu invece devi andare a caccia per procurar cibo ai nostri figlioli!” diceva la compagna.
“No! Io sono egoista! Non andrò a caccia per la nidiata, devo percorrere la mia strada!”
Così continuò a volare senza capire dove andava. Allontanava da sé ogni sentimento d’amore.
La sua compagna era una gran saggia.
Dal nido lo chiamò un’ultima volta.
Con una cabrata lui si diresse da essa:
“Cosa vuoi?”
“Non puoi trovare la via se non ti fai accompagnare dall’amore, continuerai a inciampare e non saprai dove andare!” disse ella.
“Ma cosa fa l’amore?” chiese messer il falco.
“L’amore con una mano ci indica la strada e con l’altra ci sostiene nel cammino!” rispose ella e finalmente messer il falco scelse l’amore.
Le abitazioni erano diverse, nel villaggio, a seconda del lavoro degli abitanti. C’erano le grotte per i lavoratori di selce, le capanne per i cercatori; i materiali usati erano argilla cotta e piante seccate. Al centro v’era comunque sempre un focolare, attorno al quale ci si scaldava e presso il quale si cucinava.
Le abitazioni erano più o meno belle, ma si narravano ai bambini fiabe che facessero capire loro che importante non è la ricchezza della capanna ma l’amore che vi regna. Eccone un esempio:
LA BELLA ABITAZIONE
Fora sognava di abitare nella capanna del capo tribù o dei ricchi del villaggio:
“Vorrei vivere in stanze grandi e decorate di marmo bianco!” diceva pensando ad avere dipinti e graffiti preziosi alle pareti del suo misero abituro. Ella infatti viveva in una delle capanne più povere, quelle poste sulla collina dirimpetto al bosco. Non c’erano che cannicci di bambù come soffitto e poca argilla secca come mura. In essa tuttavia, c’erano i nonni a insegnare ai nipoti, la mamma e il babbo di Fora a dare tanto amore a lei e ai suoi numerosi fratelli, regnava la pace in tanta armonia.
La mattina, la mamma serviva tisane calde e zuccherate con miele, dava un bacio in fronte a tutti e la giornata cominciava in allegria.
“Il capo tribù ha fiori pregiati all’ingresso! I ricchi hanno capanne stupende!” diceva Fora lamentandosi, guardando la madre che si limitava a porre fiori selvatici trovati nel bosco nell’antro di casa sua.
Un giorno la ragazza decise di andare verso le capanne ricche. Ce n’erano di grandi e bellissime. Si addentrò nella zona di quelle case per spiare come si viveva nel lusso. C’erano tante suppellettili e tanti monili, ma in esse mancavano i nonni, non c’era l’amore.
Fora rimase desolata e delusa, tornò dalla mamma e le raccontò tutto. La donna la portò ad ascoltare le viole magiche del bosco. A forza di andare a raccogliere corolle per la selva, la donna aveva scoperto che i fiori parlano e sono assai saggi. Sotto una bella quercia una bella viola disse a Fora:
“La casa bella non è quella ricca ma quella dove regna l’amore!”
Una cosa che ai ragazzi piaceva molto era celebrare, nella grotta delle preghiere, l’orazione agli spiriti degli antenati. Già nel mesolitico si usava fare tombe (necropoli), infatti ne sono state ritrovate tantissime. Si attribuiva infatti, già un valore al momento del trapasso, credendo in un’anima che sopravvive al corpo. Nella grotta delle preghiere c’erano stupendi incisioni. Si trattava di una grotta carsica. All’ingresso, un’edera sormontava l’arcata tonda, presso la quale stavano accese delle torce. Nell’oscurità si percorreva un corridoio e poi tutti, adulti e bimbi si ritrovavano a invocare lo spirito della Grande Madre Terra, tenendo in mano una fiaccola accesa; così l’antro tenebroso diveniva illuminato a giorno.
Ognuno teneva in mano la sua fiammella e ai bimbi venne raccontato:
LA LUCE
C’era una volta un posto buio buio.
“Come facciamo a vedere dove andiamo?” si chiedevano tutti brancolando nell’oscurità.
Intervenne un cercatore e portò una pietra provando a vedere se essa serviva per illuminare, era un sasso grande e niveo, ma non servì ad alcunché.
Una donna recò tra le ombre nere delle piume chiare.
“Tentiamo di verificare se esse danno luce!” venne deciso.
Si ballò attorno alle piume, ma non si ottenne nessun miglioramento.
“Dobbiamo trovare la cosa più bianca che c’è!” proposero alcuni credendo di essere nel giusto.
Tentarono con il gesso e poi con il latte, ma niente veniva illuminato.
Allora il gruppo, ancora non vedendo niente, si rivolse alle nuvole del cielo. Anche in alto tutto era scuro, s’intravedevano però le nuvole ammassate e in gruppo. Da una di esse sprizzò un raggio chiaro, era la nuvola dei cuori.
Essa si abbassò in mezzo alla gente e disse:
“Se tirate fuori la luce del vostro cuore, ognuno illuminerà una bella parte e l’intero ambiente sarà lucente!”
Tutti dunque si misero a manifestare chiaramente i bei sentimenti che avevano dentro, l’oscurità venne vinta e fu luce per sempre, fra colori bellissimi e raggi di luce.
Come in tutte le comunità di persone, anche tra i componenti la tribù di Graz c’era chi ostentava gloria e si vantava delle proprie gesta; i saggi però parlavano di umiltà e di comportamento modesto. Si voleva insegnare ai giovani a non atteggiarsi da boriosi. Mentre le donne lavavano ciotole e recipienti, con acqua e piante di saponaria raccolte nel bosco, si narrò:
IL CACCIATORE
Di ritorno dalla caccia il fiero cacciatore mostrava il suo carniere pieno. Aveva usato tutte le frecce del suo arco e aveva colpito diversa selvaggina, eppure il suo atteggiamento era troppo altero e la gente non gli tributava onori.
“Guardate che uccelli, guardate che lepri! Voi avete animo misero, non siete baldi come me!” diceva fiero e altezzoso. Esibiva le sue prede, faceva vedere il suo arco possente e si dava arie da grande eroe.
“Poveri e negletti siete voi altri, in confronto a me tanto bravo!” continuava a pavoneggiarsi
Il cacciatore tronfio e baldanzoso, camminava tra le capanne, ma nessuno batteva le mani.
“Compassionevoli voi siete e io tanto prode!”
“Vieni con noi e impara l’arte della modestia!” dissero gli altri.
Il gruppo partì e il cacciatore vanaglorioso lo seguì.
Si recarono nel centro del bosco per parlare con il propulsore magico, una grossa arma che saggiamente addestrava ogni cacciatore e sentenziava frasi dalla eccelsa sapienza.
Da questa grande arma partivano arpioni e giavellotti magici, rispettosi della natura ma utili a procacciare la carne indispensabile alla sopravvivenza.
“Il propulsore sa come un cacciatore deve comportarsi davanti ai suoi pari, ascoltalo!” disse il più anziano del gruppo al cacciatore vanaglorioso.
Il grosso propulsore era fatto di legno di pino e resina speciale univa due lunghe balestre, che lo rendevano assai potente. L’arma fatata fece segno al cacciatore tronfio di andare avanti, poi gli disse:
“Il vero orgoglio non è vantarsi di non aver miserie, ma gloriarsi di conoscerle!”
Da quel giorno il cacciatore imparò la modestia e l’umiltà e tutti lo apprezzarono e lo applaudirono a ogni ritorno dalle giornate di caccia.
Nella grotta delle fiabe, insomma, tutti i fanciulli imparavano a crescere, a emulare gli adulti nei comportamenti degni, capivano come dosare la propria irruenza e usare bene le personali energie, proprio come si raccontò nell’ultima favola riportata a conclusione di questa breve raccolta di racconti di Graz:
I BAGORDI
I ragazzi della tribù non capivano che si doveva imparare a dosare l’irruenza e comportarsi in maniera ligia:
“Vogliamo darci ai bagordi!” dicevano e preparavano banchetti sontuosi per ballare, mangiare e cantare, senza freno né limitazioni. Mangiavano a quattro palmenti, rimanevano desti di notte e sfrenate erano le libagioni.
“Balliamo perché siamo felici!” dicevano ai ritmi dei tam tam che suonavano frenetici.
Credevano che manifestandosi tanto euforici potessero mostrare così la loro gaiezza.
“Siamo scalmanati e gioiosi!” dicevano.
Gli anziani li guardavano con la loro saggezza.
Un vecchio canuto ebbe compassione di atteggiamenti tanto poco assennati.
I giovani continuavano a tracannare beveraggi, dandosi a gozzoviglie e baldorie.
“Facciamo grandi feste perché siamo sereni!” continuavano i ragazzi.
Il vecchio canuto prese la grande pietra nella quale era rappresentata in graffito la Grande Madre Terra. Essa era manifestazione di fertilità, ma per pregarla occorreva stare in silenzio e non darsi a baccanali, bisbocce e saturnali.
Il vecchio commentò:
“Se la vostra condizione fosse veramente felice, non occorrerebbero i bagordi per distrarvi e non pensare !”
I giovani compresero e da quel giorno impararono, sì a gioire, ma a moderare i comportamenti.
Per tante e tante ere le fiabe continuarono a essere narrate dai popoli col trascorrere dei tempi… e i quel modo l’umanità continuò a evolversi e crescere.

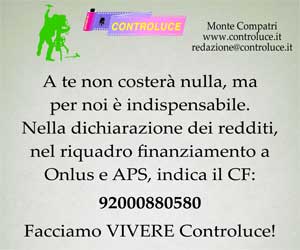


















































































































































































Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento